|
Due belle piante alpine, Favratia zoysii (sin. Campanula zoysii) e Viola calcarata subsp. zoysii (sin. Viola zoysii), entrambe endemiche delle Alpi Giulie, e il genere orientale di graminacee Zoysia, molto popolare per creare tappeti erbosi resistenti al calpestio e alla siccità, celebrano il barone sloveno Karel Zois, che si fece conoscere nell'ambiente botanico austriaco e tedesco con i suoi invii di piante alpine. Vissuto all'ombra del molto più celebre fratello maggiore Žiga Zois, figura chiave dell'illuminismo sloveno, insieme a lui creò un parco ricco di piante esotiche che comprendeva anche un giardino alpino, il più antico della Slovenia (nonché uno dei primissimi al mondo).  Un fratello famoso e brillante Nei primi anni del Settecento, i fratelli Francesco e Michelangelo Zois, nati a Berbenno in Valle Imagna (Bergamo), andarono a cercare fortuna a Venezia. Mentre il primo rimaneva nella città lagunare, il secondo intorno al 1720 si trasferì a Lubiana per lavorare nella bottega di un conterraneo che aveva fatto fortuna, Peter Anton Codelli, un mercante che commerciava in telerie e materiali ferrosi. Nel 1727, ottenne la cittadinanza e insieme a un socio rilevò la ditta. Era l'inizio di una straordinaria ascesa economica e sociale: già nel 1730 era membro del consiglio municipale, nel 1735 acquistò l'intera ditta e ne espanse gli affari; vedeva in Italia il ferro e l'acciaio della Carniola, importava attraverso Venezia prodotti orientali (uvetta, mandorle, fichi, allume, mastice, candele, incenso) che esportava in Germania e in Austria. Negli anni '40 e '50, grazie all'acquisto di diverse miniere e fonderie, controllava quasi l'intero settore siderurgico della Carniola ed era ormai una delle persone più ricche del paese. Nel 1737 fu insignito della nobiltà ereditaria, nel 1747 sposò in seconde nozze una nobildonna slovena e dal 1760 si fregiò del titolo di barone (Freyherr zu Edelstein). Era anche un grosso proprietario terriero; tra le sue tante proprietà, spicca il castello rinascimentale di Brdo, acquistato intorno a 1755. Situato nei pressi Kranj, al centro di una tenuta di 500 ettari, oggi è la principale sede di rappresentanza della Repubblica di Slovenia; qui visse per gran parte della sua non lunga vita il botanico Karel Zois (Karel Filip Evgen, in tedesco Carl Filipp Eugen Zois Freiherr von Edelstein, 1756-1799). Era uno dei più giovani dei numerosi figli (almeno otto) nati dal secondo matrimonio di Michelangelo Zois; sulla sua vita personale non sappiamo molto, forse perché è stato oscurato dal ben più famoso fratello maggiore Žiga (Sigismondo o Sigmund, 1747-1819), il principale esponente dell'illuminismo sloveno. Oltre a far prosperare gli affari di famiglia con l'aiuto del cugino Bernardin (figlio di un fratello di Michelangelo), Žiga Zois fece del suo palazzo di Lubiana il punto d'incontro degli artisti e degli intellettuali della Carniola; incoraggiò la codificazione dello sloveno, fino ad allora considerato un semplice dialetto, promuovendo anche la pubblicazione del primo giornale in lingua slovena, Lublanske novice. Mecenate di artisti e scienziati, si interessò egli stesso di geologia, mineralogia, zoologia (inviando tra l'altro alcuni esemplari di proteo Proteus anguinus a Schreiber perché ne studiasse l'anatomia), nonché botanica, probabilmente per influsso del fratello. Da buon proprietario di miniere e ferriere, era soprattutto un geologo e come tale è ricordato dal minerale zoisite, che gli fu dedicato nel 1805 da Abraham Gottlob Werner cui ne aveva inviato un campione raccolto sulla Svinška planina. Tra i maggiori esponenti del suo circolo, per il suo ruolo pionieristico nello studio della geologia e della flora delle Alpi Giulie, va citato il chirurgo di origini francesi Belsazar Hacquet (1739-1815); dopo una vita avventurosa, egli lavorò dapprima a Idria come chirurgo minerario e ostetrico. Qui conobbe il lavoro di Scopoli, che attirò la sua attenzione sulla flora della Carniola; ne continuò le ricerche esplorando le Alpi Retiche, Noriche, Carniche e Giulie. Nel 1773 si trasferì a Lubiana come docente del Liceo medico e chirurgico e della scuola di ostetricia e divenne segretario dell'Associazione agricola della Carniola, di cui Žiga Zois era membro eminente; divenuto suo stretto amico e collaboratore, lo aiutò a creare un gabinetto di scienze naturali e una notevole biblioteca e lo assistette nelle sue ricerche mineralogiche e geologiche. Una passione condivisa (anche da Karel, come vedremo più avanti) era quella per le montagne: già nel 1777 Hacquet aveva tentato di raggiungere la vetta del Triglav, la maggiore della Slovenia (2864 m.), ma aveva dovuto accontentarsi del Mali Triglav (2725 m). Certamente su suo suggerimento, nel 1778 il barone Zois finanziò la prima scalata coronata da successo, cui parteciparono il chirurgo Lovrenc Willomitzer (che era stato allievo di Hacquet a Idria), un cacciatore di camosci e due minatori che lavoravano per Zois. Uno di loro, Matevž Kos, è anche il più noto dei raccoglitori di Karel. Proprio la natura del Triglav trascinò Zois nella grande disputa che nel Settecento divideva i geologi; secondo i nettunisti e il loro caposcuola Werner, tutte le rocce avevano un'origine marina; sulla scia dello scozzese James Hatton, i plutonisti sottolineavano invece il ruolo del magma e delle eruzioni vulcaniche nei processi di formazione delle rocce. Un convinto seguace di questa posizione era Johann Ehrenreich von Fichtel di Sibiu in Transilvania, cui Zois aveva inviato campioni di rocce raccolte ai piedi di monti Vršac e Triglav. Nel suo Mineralogische Aufsätze (1794) Fichtel sostenne che questi fossili provavano che le parti basse del massiccio erano costituite da sedimenti di origine marina (calcari secondari), mentre le parti più alte erano costituite da rocce calcaree primarie di origine magmatica. Zois, che tra l'altro corrispondeva con Dolomieu, che fu suo ospite nel 1784, non era d'accordo: era convito che anche le rocce calcaree della sommità fossero di origine marina; se i suoi campioni di fossili venivano dalle parti basse, era perché non aveva chiesto ai suoi uomini di raccoglierne ad altezze maggiori. Urgeva una spedizione geologica in piena regola. Zois la affidò a due sacerdoti, Valentin Vodnik e Jožef Pinhak, accompagnati dal conte Franz Hohenwart e da alcune guide, tra cui Matevž Kos e un altro dei raccoglitori di Karel Zois, Andrej Legat. Nell'agosto il gruppo esplorò il Vršac, a settembre il Triglav, raccogliendo abbastanza fossili da dimostrare le origini marine anche delle parti alte del massiccio. Valentin Vodnik era anche un poeta, e quella scalata ispirò uno dei suoi poemi più celebri, intitolato appunto Vršac. Fu poi uno dei principali redattori di Lublanske novice, riunendo nella sua persona i diversi aspetti del mecenatismo di Žiga Zois: gli interessi letterari, la promozione della lingua e della cultura slovena, la ricerca scientifica e l'amore per la montagna. Della generosità di Zois si giovarono anche i cittadini di Lubiana, cui aprì il giardino che fece costruire su un tratto delle antiche mura; la sua collezione di oltre 5000 minerali andò a costituire il primo nucleo del Museo di scienze naturali di Lubiana.  Un botanico rispettato, ma oscuro Rispetto a questa brillante e poliedrica figura, il fratello minore Karel appare decisamente in ombra. Non faceva parte del "circolo di Zois", e neppure viveva a Lubiana, ma per lo più a Brdo o anche a Javornik nell'Alta Carniola, dove gli Zois, oltre alla loro maggiore fonderia, possedevano una casa padronale. Questa scelta contro corrente e la relativa carenza di informazioni su di lui hanno dato origine a qualche malignità. Uno dei suoi primi biografi, Karel Dežman, ipotizzò che fosse "un po' eccentrico"; Voss raccolse la voce che non fosse in buoni rapporti con il fratello maggiore e che, dopo la sua morte, questi avesse fatto sparire tutti i documenti più o meno compromettenti. Nada Praprotnik, che ha dedicato molti studi a questi precursore della botanica slovena, ritrovando anche documenti inediti, contesta almeno la seconda affermazione; fino al 1795, quando la gravissima gotta di cui soffriva relegò Žiga nella casa di Lubiana e lo costrinse su una sedia a rotelle da lui stesso progettata, il barone trascorreva lunghi periodi a Brdo e Javornik e visitava spesso le ferriere. Condivideva la passione per la botanica del fratello, era orgogliosissimo delle piante che gli furono dedicate, e incoraggiò in ogni modo le sue ricerche. Illuminante a tale proposito è una sua lettera a Hacquet: "La sua passione botanica mi sta già influenzando. Ho avuto la fortuna di potergli inviare il tuo Leontodon terglouense con altri materiali che ho riconosciuto dai tuoi disegni. Sulle nostre montagne ci sono molte piante che tu e il signor Scopoli avete ignorato; i miei numerosi lavoratori delle miniere e delle foreste più alte mi permettono di cercarle. Ho fatto ristrutturare una piccola casa colonica a due terzi dell'altezza di Belščica in modo che l'anno prossimo io vi possa trascorrere il mese di luglio per dedicarmi alla botanica sulle cime e lungo la valle. Successivamente partiremo per Bohinj. Ho trovato modo di far portare mio fratello a cavallo a Vele Polje sul Triglav a basso costo, e spero di arrivarci io stesso". Forse, semplicemente Karel era di salute cagionevole (morì a poco più di quarant'anni), oppure non amava la città e la vita di società. Secondo Wulfen, a iniziarlo alla botanica fu un suo ex allievo del collegio gesuitico di Lubiana, un certo Weber; sicuramente determinante fu l'esempio di Hacquet, autore fra l'altro di una Flora carniolica, che lo stimava al punto che, quando partì da Lubiana alla volta di Leopoli, gli lasciò il suo erbario. Il vero mentore di Karel Zois fu però Franz Xaver Wulfen, al quale il barone sloveno inviò diverse piante che il gesuita pubblicò a partire dal 1788. Nada Praprotnik ne ha individuate una dozzina, a cominciare dalle due che portano il suo nome: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), raccolta da Zois nelle montagne di Bohinj e sullo Storžič; Viola zoysii (oggi Viola calcarata subsp. zoysii) che gli spedì a Klagenfurt intorno al 1785 "dalle Alpi della Carniola al confine con la Carinzia, viva, ancora con la terra". Altri endemismi delle Alpi Giulie e Carniche segnalate da Zois e pubblicate da Wulfen sono Saxifraga tenella e Moehringia villosa. Zois era anche in contatto con altri botanici: a Willdenow inviò Senecio carniolicus (oggi Jacobaea carniolica), a Sternberg piante vive di Saxifraga atropurpurea (oggi Saxifraga exarata subsp. ampullacea) raccolte a Konjska Planina. Invece Thomas Host lo cita per Stemmacantha rhapontica (oggi Leuzea rhapontica subsp. rhapontica) raccolta sulle montagne di Bohinj. Sappiamo da diverse testimonianze che i fratelli Zois possedevano almeno due capanne o rifugi montani, da cui Karel partiva per le sue escursioni. Abbiamo già incontrato quella che sorgeva sotto Belščica sulle Caravanche; non esiste più ma è rimasto il nome Gospodova koča ("capanna del signore") perche la usava "un signore che era solito raccogliere piante". L'altra si trovava sul Dvojno jezero nella valle dei laghi del Triglav, o forse più in alto presso il lago Ledvice (a meno che le capanne fossero tre). Nel 1795 vi fecero sosta i membri della spedizione al Triglav; secondo la testimonianza di Franz Hohenwart, era costruita in legno di larice, comprendeva un'ampia cucina, dove dormivano anche i servitori, un magazzino per le provviste e le raccolte, camere per gli ospiti, una stanza da letto e un salotto per il barone. Arrivato poco prima del tramonto, il gruppo fu accolto molto ospitalmente e poté ammirare l'opera di Karel Zois che, sebbene si trovasse nel rifugio da solo una settimana, aveva raccolto già più di mille piante, molte delle quali destinate ai suoi corrispondenti; prima che potessero disimpegnarsi, ci vollero due ore! Chiaramente le piante venivano raccolte in più esemplari; alcune venivano essiccate per l'erbario (alla sua morte, Karel Zois lasciò un erbario di 2100 esemplari, per lo più costituito da piante alpine) o per essere spedite ad amici e corrispondenti; altre venivano portate vive a valle. Oltre a quelle raccolte di persona, Zois si serviva di una serie di raccoglitori professionisti; erano fittavoli o dipendenti della famiglia in qualità di boscaioli, cacciatori o minatori; tra i primi scalatori del Triglav, abbiamo già incontrato Matevž Kos e Andrej Legat. Secondo Wulfen, fu Kos a raccogliere Malaxis monophyllos sulle pendici del Vršac. Le piante vive, insieme a ceste di terra di montagna, andavano ad arricchire il giardino alpino che, con molta spesa e grande impegno, Karel Zois volle sul lato sud-est del parco di Brdo. Il castello era circondato da una vasta tenuta, con foreste, stagni, frutteti. Molto probabilmente già all'inizio del Settecento a sud dell'edificio c'era un parterre in stile barocco, con un asse principale lungo 600 metri, percorso da un ampio viale, con aiuole a ramages delimitate da siepi di bosso su entrambi i lati. Questa parte venne mantenute, ma già all'epoca di Michelangelo venne creato un giardino recintato che combinava il giardino di piacere con la tenuta agricola; progettato su due livelli, con un dislivello di 60 cm, era diviso in 24 parcelle rettangolari uniformi e simmetriche, piantate in vario modo e delimitate da alberi da frutto e siepi di agrifoglio. A partire dal 1784 o 1785, i fratelli Zois, pur rispettando la sostanzialmente l'impianto preesistente, intervennero aggiungendo diversi elementi: un nuovo viale con tigli posti su sei file e prati e campi su entrambi i lati; due stagni, ciascuno dei quali dotato di un padiglione estivo a pagoda e collegato al castello da un viale di carpini; diversi edifici, tra cui cottage rustici con il tetto di paglia, una gloriette, una ghiacciaia, una rimessa per barche e una pista da bowling; per le piante esotiche c'erano sia una serra sia un'orangerie, dove venivano ricoverate le piante in vaso che nella bella stagione era esposte all'esterno. Poiché utilizzavano il medesimo impianto di riscaldamento, forse erano due settori dello stesso edificio. Tra il 1785 e il 1796, a Brdo vennero piantati 6.398 alberi e 1.063 arbusti autoctoni ed esotici; le ornamentali esotiche furono fatte venire per lo più dall'Olanda ma anche dall'Inghilterra (tra i fornitori, il celebre vivaio Loddiges); per moltiplicarli, sul lato est venne creato un vivaio (Novina). A Karel le specie esotiche interessavano soprattutto come oggetto di studio; era lui a occuparsi della loro scelta e a tenere i contatti con i fornitori. Alcuni li ottenne anche dai suoi corrispondenti, in particolare da Thomas Host che, in cambio delle piante alpine, gli procurò diverse piante esotiche, probabilmente coltivate a Schönbrunn. La pupilla degli occhi di Karel Zois era però il giardino botanico alpino, che venne creato sul lato più assolato del giardino. Qui egli fece trapiantare le piante alpine che raccoglieva durante le sue escursioni o gli venivano portate dai suoi raccoglitori. Fare crescere e sopravvivere a Brdo, a circa 420 m sul livello del mare, piante che crescono molto più in alto e hanno esigenze particolari e diversificate non dovette essere un'impresa facile. Il giardino fu certamente preparato con grande accuratezza, provvedendo a fornire ad ogni pianta l'esposizione e il terreno giusto. Lo fa pensare il fatto che vi fossero coltivate con successo piante notoriamente difficili come l'orchidea Cypripedium calceolus, le emiparassite Pedicularis o la calcifila Tozzia alpina. Tra i manoscritti di Žiga Zois, ci è giunto un "Elenco principale dei semi delle piante alpine" che però fu certamente scritto da Karel Zois, come si deduce dal fatto che Campanula zoysii è chiamata "campanula mea"; è citata più volte, mentre non sembra che egli coltivasse la "sua" viola: forse era troppo difficile farla prosperare in pianura, o si accontentava di goderla nel suo cottage sulle Caravanche, dove ancora oggi cresce in abbondanza. Molte delle piante alpine coltivate a Brdo erano piuttosto comuni, ma non mancavano le specie più rare come un'altra campanula, Campanula cespitosa, un endemismo delle Alpi orientali scoperto da Scopoli; Lilium carniolicum, di distribuzione strettamente carsica; Primula carniolica, un raro endemismo sloveno che cresce solo nel settore settentrionale della Selva di Trnovo nelle Alpi Giulie; Drypis spinosa, una specie tipica dei ghiaioni calcarei, un endemismo illirico con stazioni disgiunte nelle Alpi di Kamnik; Geranium argenteum, che in Slovenia cresce solo in poche stazioni e probabilmente fu raccolto sul Črna prst, che già Wulfen considerava un vero e proprio giardino naturale per la sua ricchezza di specie. Oltre alle piante dei monti della Slovenia, Karel Zois coltivava anche specie montane ottenute dai suoi corrispondenti: ad esempio, non crescono in Slovenia Lomatogonium carinthiacum e Wulfenia carinthiaca, i cui semi gli vennero inviati dal direttore dell'orto botanico di Vienna von Jacquin. Alcune specie venivano da molto più lontano: nell'elenco e nei quaderni di Zois sono citate piante asiatiche provenienti dalla Siberia, dalla Kamčatka o dal lago Baikal. Probabilmente a procurargliele fu un altro illustre corrispondente, Peter Simon Pallas. Il giardino botanico alpino di Karel Zois è di grande importanza storica: non solo fu il primo orto botanico della Slovenia, ma è in assoluto uno dei primissimi giardini alpini. Basti pensare che l'Alpengarten del Belvedere a Vienna, che vanta la primogenitura, fu fondato successivamente, nel 1803. Tuttavia fu di brevissima durata: Karel Zois morì a soli 43 anni nella casa di famiglia a Trieste. Il fratello, ormai prigioniero della gotta, non visitava da tempo la proprietà, e alla sua morte, nel 1819, la lasciò a un nipote (anch'egli si chiamava Karel Zois) che trascurò del tutto sia il giardino alpino sia il vivaio. Nel catasto del 1826, mentre compare ancora il giardino barocco, non esistono più né l'uno né l'altro.  Erbe per prati indistruttibili Oltre che dall'eponimo delle due specie che gli furono dedicate da Wulfen, Karel Zois è ricordato dal genere Zoysia, omaggio di Willdenow con questa motivazione: "In memoria del barone Karl Zois di Lubiana, che ha studiato con grande zelo la flora del suo paese e attraverso un'attenta ricerca ha scoperto diverse nuove specie". Questo genere della famiglia Poaceae comprende otto specie di erbe originarie di una vasta area che va dall'Oceano indiano al Pacifico, con centro di diversità nell'Asia sud-orientale; sono erbacee perenni rizomatose tappezzanti con lamina fogliare breve, stretta e piatta che formano tappeti erbosi bassi e densi. Originarie di paesi caldi, fanno parte delle cosiddette "essenze macroterme", ovvero di quelle specie di graminacee per prati erbosi che prediligano climi caldi, hanno una notevole resistenza alla siccità, posseggono apparati radicali profondi e aggressivi che consentono loro di riprendersi rapidamente dopo la pausa invernale, durante la quale tendono a ingiallire o a perdere la parte aerea. Sono anche fortemente resistenti al calpestio, per cui trovano largo impiego, oltre che nei prati ornamentali, negli impianti sportivi come campi da golf, da calcio o da rugby, Le Zoysia formano un tappeto erboso molto fitto e compatto, che tende naturalmente a non permettere la crescita delle infestanti (tranne che nel periodo di dormienza, che è uno dei loro talloni d'Achille); la crescita è poi molto lenta, richiedendo quindi tagli meno frequenti delle classiche erbe da prato all'inglese. Ma soprattutto sono estremamente resistenti sia alle alte temperature sia alla siccità. In commercio si trovano essenzialmente due specie, Z. japonica e Z. matrella. Z. japonica, più settentrionale, è presente in Cina, Manciuria, Corea, Giappone; negli Stati Uniti fu introdotta dalla Cina nel 1895 e presto divenne la specie più utilizzata nei due terzi meridionali del paese. Rispetto alle altre specie, ha una tessitura più grossolana, cresce più rapidamente e necessita di almeno quattro ore di sole al giorno. Soprattutto negli Stati Uniti, ne sono state sviluppate numerose cultivar tra le quali 'Zenith' si segnala per la maggiore resistenza alle basse temperature (fino a -10). Z. matrella è diffusa in un'area vastissima che va dal Madagascar e dalle Mascarene a occidente fino alle isole Salomone a oriente; se ne distinguono due varietà: la più occidentale Z. matrella var. matrella, spesso commercializzata con il vecchio nome Z. tenuifolia, anche nota come "erba delle Mascarene" (dal Madagascar all'Australia settentrionale) e la più orientale, Z, matrella var. pacifica (dall'Indocina al Pacifico nord-occidentale), nota come "erba di Manila". Si distingue da Z. japonica per la lamina fogliare più fine (strettissima in Z. matrella var. matrella), i ciuffi più fitti, la predilezione per i terreni sabbiosi anche poveri e la resistenza alla salinità, essendo una specie prevalentemente costiera. La varietà occidentale con il nome Z. tenuifolia è stata fatta conoscere in Europa da Elie Bonaut, floricoltore di Antibes, che ne ha diffuso la coltivazione nella riviera francese. La sua principale caratteristica è la versatilità; inoltre ha un periodo di dormienza più breve (1-2 mesi). Anche di questa specie esistono molte cultivar, come 'BRF Zoysia' (la sigla sta per Blade Runner Farm), una delle più utilizzate per i campi da golf. Esistono anche ibridi tra le due specie, il cui nome botanico è Zoysia x forbesiana, dall'agronomo statunitense che per primo tentò questo incrocio. In epoca di riscaldamento globale e di precipitazioni ridotte, un prato di Zoysia può essere una soluzione particolarmente sostenibile, adatta anche a giardinieri pigri, anche se non sarà davvero "indistruttibile" come vanta la pubblicità. Ma così come c'è uno Zois famoso e uno più defilato, oltre a questa regina del green, abbiamo anche un'altra, più oscura Zoysia, anzi... falsa Zoysia. Nel 1924 in Somalia venne raccolta un'erba che a prima vista assomigliava a una Zoysia, ma non lo era. Nel 1928 il botanico italiano Chiovenda la pubblicò, denominandola Pseudozoysia sessilis. Unica specie di questo genere, è una piccola erbacea perenne, alta meno di 15 cm; anch'essa forma densi ciuffi di foglie con lamina stretta e lineare e ha infiorescenze a falsa spiga con spighette su assi contratti; è un'alofita che cresce sulle dune costiere.
0 Comments
Forse nel vostro giardino coltivate la bella e robusta Euphorbia characias subsp. wulfenii, oppure, se amate le piante alpine, conoscete Primula wulfeniana o Androsace wulfeniana, o addirittura la rara e bellissima Wulfenia carinthiaca. Tutte ricordano il sacerdote austriaco Franz Xaver von Wulfen, ex gesuita di santa vita, che nella seconda metà del Settecento fu tra i pionieri dello studio delle piante alpine, che andava a cercare nel loro ambiente naturale, tra malghe e crode; nella sua lunga carriera di naturalista delle grandi cime, fece più di 60 scalate, scalando tra gli altri il Grintovec in Slovenia, la Croda Rossa di Braies nelle Dolomiti, l'Eisenhut e lo Schleinitz nelle Alpi austriache. Ultra settantenne, partecipò addirittura all'epica sfida che portò alla conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria, anche se non fu tra quelli che raggiunsero la vetta. A ricordarlo non può che essere una pianta che egli stesso raccolse sulle sue montagne, appunto Wulfenia carinthiaca, specie tipo di un genere che non cessa di intrigare i botanici per la sua curiosa distribuzione disgiunta. Su montagne ancora più alte e lontane ci porta il secondo genere che lo celebra indirettamente, Wulfeniopsis. Entrambi appartengono alla famiglia Plantaginaceae.  Sacerdote e scienziato A Klagenfurt, la capitale della Carinzia, in una piazza affacciata su un giardino, sorge un modesto monumento, un cippo piramidale su base quadrata sormontato da una sfera; su una delle facce, la scritta: "Franz X. barone von Wulfen, ugualmente grande come sacerdote, studioso ed essere umano 1728-1805". Eretto inizialmente come cippo funerario, il monumento riflette la gratitudine e l'affetto dei cittadini di Klagenfurt per questo gesuita che visse nella città carinziana per quarant'anni distinguendosi per il suo spirito di carità. Ripercorriamone la vita, soffermandoci per ora sulla sua figura di sacerdote. Wulfen nacque a Belgrado, dove il padre, un militare tedesco al servizio dell'impero, era di stanza in quegli anni; la madre era invece una nobildonna ungherese. Secondogenito, dopo aver completato gli studi presso il liceo classico di Kaschau (oggi Košice, Slovacchia), a diciassette anni entrò nella compagnia di Gesù; seguì i due anni di noviziato a Vienna e completò gli studi umanistici a Györ (attuale Ungheria). Gli studi superiori lo riportarono a Vienna, dove studiò per tre anni filosofia e per due matematica superiore; quindi lo troviamo a Graz dove studiò teologia per quattro anni e completò i primi due anni di prova. Il terzo e ultimo lo trascorse a Banska Bystrica (nell'odierna Slovacchia) dove pronunciò i voti solenni nel 1763. Intanto aveva incominciato ad insegnare nei collegi gesuitici di diverse città: grammatica (ovvero le materie umanistiche dei primi tre anni del ginnasio) nel 1755 al Collegio di Gorizia e nel 1756 al Theresianum di Vienna; matematica nuovamente a Gorizia nel 1761; logica e metafisica a Lubiana nel 1762 e fisica newtoniana sempre a Lubiana nel 1763. Infine nel 1764 fu trasferito a Klagenfurt, dove insegnò dapprima matematica poi tutte le materie degli studi filosofici (studia superiora) fino alla fine del 1768. Nel 1769 lasciò l'insegnamento per dedicarsi esclusivamente alla cura pastorale. Dal 1769 al 1773 fu confessore e catechista presso le Suore Orsoline. La sua più profonda aspirazione era essere inviato come missionario in Cina o nelle Indie, ma nel 1773 lo scioglimento della Compagnia dei Gesù mise fine a questa speranza. Gli fu assegnata una piccola pensione e un alloggio in una casa sulla Burggasse; disponeva così di un modesto reddito che devolveva in gran parte ai poveri, così come dedicava molto del suo tempo all'assistenza spirituale dei poveri, dei malati e di chiunque cercasse in lui consolazione e consiglio. Non c'è da stupirsi se alla sua morte fu salutato dai concittadini d'adozione come santo. Ma era anche uno stimato scienziato, membro di numerose società scientifiche e corrispondente di naturalisti di fama, compreso lo stesso Linneo. Su questo secondo aspetto della sua personalità ci illumina la lapide posta sulla casa della Burggasse: "In questa casa visse e studiò fino alla fine della sua vita Franz Xavier v. Wulfen 1728-1805. Prendono il nome da lui la wulfenia e la wulfenite". La wulfenite è un minerale (molibdato di piombo), la wulfenia una rara pianta montana (Wulfenia carinthiaca); è il simbolo vegetale della Carinzia ed è ritratta nella parte bassa della lapide. Entrambi sono strettamente collegati all'attività scientifica di questo sacerdote-naturalista. 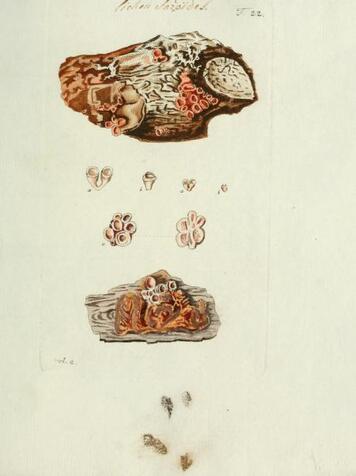 Alla scoperta della flora alpina Coltissimo, versato tanto nelle scienze umane quanto nelle matematiche, poliglotta che parlava e scriveva in quattro lingue (latino, tedesco, francese e italiano), come naturalista Wulfen era autodidatta; scoprì le scienze naturali, e in particolare la botanica, quando era novizio a Vienna, grazie a un amico medico Cominciò a tenere un erbario e ad esplorare le campagne in cerca di piante; come raccontò più tardi, per molto tempo il suo unico manuale fu Systema naturae di Linneo. Il primo terreno di ricerca furono ovviamente i dintorni di Vienna. Poi i continui spostamenti imposti dalla Compagnia di Gesù gli permisero di esplorare molte parti del variegato territorio asburgico, a cominciare dai paesaggi carsici dei dintorni di Gorizia, dove incominciò ad interessarsi anche di insetti e altri animali. Nel 1754 con un amico fece un viaggio a Venezia ed esplorò il Lido e Caorle. A Gratz ritrovò un amico d'infanzia, Leopold Biwald, che era entrato nella Compagnia qualche anno dopo di lui; gli diede lezioni di botanica e insieme batterono assiduamente le campagne. Forse durante il secondo soggiorno a Gorizia entrò in contatto con Scopoli, cui inviò esemplari sia per Entomologia Carniolica (1763) sia per la seconda edizione di Flora Carniolica (1772), in cui compaiono una sessantina di specie da lui raccolte; Scopoli così lo loda: "Grandissimi per la nostra flora sono i meriti del padre Francesco Saverio Wulfen della Compagnia di Gesù che benevolmente mi ha comunicato molte piante raccolte con indefessa industria nei dintorni di Gorizia". La passione per le ricerche naturalistiche si rinvigorì nei due anni trascorsi a Lubiana. Wulfen strinse amicizia con un confratello, padre Janez Jožef Erberg, anch'egli appassionato di botanica, che gli fece conoscere i dintorni della città; poiché nel mese di luglio le lezioni erano sospese e i professori erano in vacanza, Wulfen ne approfittò per esplorare i monti della Carniola; nacque probabilmente in questo periodo un'altra delle sue grandi passioni: l'alpinismo. Fu sul monte Nevoso nei pressi di Trieste e scalò il Grintovec, la cima maggiore della Carniola. Trasmise la sua passione per la montagna e la natura a uno dei suoi allievi, Sigmund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che fu suo compagno in alcune escursioni nelle Alpi di Kamnik e della Savinja, grazie alle quali incominciò a interessarsi anche di mineralogia. Situata sul lago Wörthersee tra verdi colline, in una zona ricca di stazioni termali, al centro di uno splendido scenario alpino, benché periferica e lontana dalle grandi biblioteche, Klagenfurt si offrì a Wulfen come un perfetto terreno di studio; presto si propose di scrivere una Flora norica, progetto a cui si sarebbe assiduamente dedicato fino alla fine dei suoi giorni. A tale scopo esplorò a fondo non solo i dintorni della città, ma gran parte delle valli e delle catene montuose della Carinzia, estendendo le sue raccolte alle crittogame e ai licheni, che egli classificava tra le alghe e che divennero il suo soggetto preferito. D'estate non perdeva occasione per percorrere le montagne per cercare minerali e piante alpine; durante i 40 anni in cui visse a Klagenfurt, fece più di sessanta scalate (ma su questo aspetto torneremo più avanti). Anche se finora non aveva pubblicato nulla, il suo nome incominciava ad essere conosciuto. Nel 1772 iniziò a collaborare con von Jacquin per Florae austriacae [...] icones; la loro era una tipica relazione patrono-cliente: grazie a corrieri, amici comuni, viaggiatori, commercianti, librai, da Klagenfurt partivano per Vienna esemplari d'erbario, semi, piante alpine vive e descrizioni, mentre da Vienna arrivavano libri e pubblicazioni difficili da reperire nella periferica Klagenfurt, nonché contatti con altri studiosi, come il padre della briologia Johannes Hedwig, che in quegli anni stava lavorando al suo trattato sui muschi. Jacquin utilizzò materiali comunicati da Wulfen sia per il quinto volume di Florae austriacae icones sia per Icones plantarum rariorum; inoltre pubblicò la prima opera a stampa di Wulfen, Plantae rariores carinthiacae, in sei puntate: nel primo e nel secondo volume della sua Miscellanea austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem spectantia (rispettivamente 1778 e 1781); nei primi quattro volumi di Collectanea ad botanicam, chemiam et historiam naturalem (1786, 1788, 1789, 1790). Le specie più nuove ed interessanti erano anche corredate di immagini di eccellente qualità, eseguite dal valente pittore Joseph Menning e pagate di tasca propria da Wulfen; di particolare importanza storica le descrizioni e le immagini dei licheni, che per le prima volta ricevevano un'attenzione privilegiata. Le 364 specie di piante, funghi e licheni descritte in Plantae rariores carinthiacae erano il frutto di diversi viaggi nelle montagne della Carinzia e del Tirolo che Wulfen poté intraprendere grazie al finanziamento del consigliere imperiale Franz von Mygind. corrispondente di Linneo e amico di Jacquin. Nel 1781, con la dedica da parte di Jacquin del genere Wulfenia nel secondo volume di Miscellanea austriaca, si ebbe la sua consacrazione simbolica nell'empireo della botanica, anche se, nella sua infinita modestia, il buon sacerdote si schermì, scrivendo di non essere degno di tanto onore. Eppure la collaborazione con von Jacquin lo lasciava insoddisfatto. Era uno studioso scrupolosissimo e perfezionista. Le sue descrizioni erano un capolavoro di precisione: già sul posto, per ogni specie osservata dal vivo stendeva su un foglio a parte una prima versione, che poi inseriva nel quaderno che portava sempre con sé; a casa, consultava la bibliografia botanica e ricopiava ogni nota in bella copia, corredandola di sinonimi e note d'autorità, per poi inserirla al suo posto nell'erbario, classificato secondo il sistema linneano. In tal modo le sue descrizioni risultavano allo stesso tempo precise, fedeli e vivaci. Quanto alle identificazioni, aveva spesso dubbi, e avrebbe desiderato confrontarsi alla pari con altri botanici. A von Jacquin invece premeva pubblicare, ed era molto più sbrigativo; almeno tale pareva all'ipercritico e perfezionista Wulfen. Fu questo a provocare la rottura: quando espresse le sue perplessità a Thomas Host, che, in viaggio per la Dalmazia, gli aveva fatto visita nella sua casa di Klagenfurt, questi le prese come una critica personale e le riferì a von Jacquin; da quel momento ogni collaborazione si interruppe. Ma Wulfen nel frattempo aveva trovato altri mecenati. Come membro della Società di agricoltura di Klagenfurt, aveva stretto amicizia con l'imprenditore Johann (Jan) von Thys, di origine olandese, che aveva fondato una manifattura di tessuti a Klagenfurt ed era uno degli animatori della modernizzazione agricola della Carinzia; Thys e dopo la sua morte il figlio Rainer Franz finanziarono alcune spedizioni di Wulfen, che nel 1781 accompagnò Thys figlio in un memorabile viaggio in Olanda, nel corso del quale visitò tra l'altro gli orti botanici di Leida e Amsterdam e ne incontrò i prefetti David van Royen e Nicolaas Laurens Burman; la moglie di quest'ultimo gli donò una collezione di insetti sudafricani, che egli tre anni dopo pubblicò a Erlangen sotto il titolo Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum. Durante il viaggio, si era fermato a Erlangen per incontrare di persona Johann Christian von Schreber, con il quale già corrispondeva grazie a un altro naturalista ex gesuita, Franz von Paula Schrank. Allievo di Linneo e traduttore delle opere linneane in tedesco, professore di materia medica e direttore dell'orto botanico di Erlangen, dal 1791 presidente dell'Accademia leopoldina, Schreber, oltre che uno dei più importanti zoologi del suo tempo, era una figura di primo piano del mondo accademico tedesco; anche grazie alla sua amicizia, Wulfen fu via via ammesso a molte società scientifiche (oltre alla stessa Leopoldina, quelle di Erlangen, Jena, Berlino, Göttingen, nonché l'Accademia delle scienze di Stoccolma). Inoltre Schreber sostituì von Jacquin come curatore editoriale di Wulfen, che a partire dal 1786 pubblicò tutte le sue opere a Erlangen. In precedenza, fu ancora pubblicata a Vienna Abhandlung vom Kärntner Bleispate (1785), una monografia sui minerali di piombo di Bleiburg in Carinzia, magnificamente illustrata da Joseph Menning; tra di essi il minerale originariamente battezzato da Ignaz von Born che lo descrisse per primo nel 1772 plumbum spatosum flavo-rubrum, poi denominato da von Jacquin Kärntherischer bleispath, "spato di piombo di Carinzia"; nel 1845 venne infine ribattezzato wulfenite in onore del nostro. Oltre a Descriptiones Quorumdam Capensium Insectorum (1786), le opere uscite a Erlangen sono Plantae rariores descriptae (1803) e Cryptogama aquatica (1803). Di particolare interesse l'ultima, dedicata ad alghe e piante acquatiche, con la descrizione di oltre settanta specie; anch'essa fu resa possibile dal mecenatismo di Thys, che gli procurò un'amichevole accoglienza presso la filiale triestina della sua ditta; nel corso di due lunghi soggiorni, Wulfen poté così esplorare la fauna e la flora della costa adriatica, visitando anche l'Istria e le isole di Veglia, Cherso e Arbe. Gli si deve tra l'altro la prima descrizione di Ulva stellata, Fucus musciformis, Fucus filamentosus e Fucus simplex. 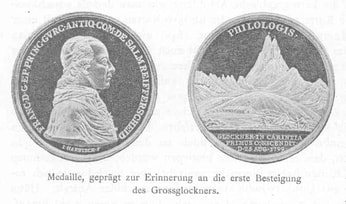 Scalate e piante alpine A Klangefurt, Wulfen riunì attorno a sé un piccolo circolo di più giovani studiosi, molti dei quali ecclesiastici, cui trasmise la sua passione per le scienze naturali e la montagna. Tra di loro spicca l'antico allievo di Lubiana Sigismund Ernst von Hohenwart (1745-1825), che dal 1787 era vicario generale del principe-vescovo di Klangenfurt. Come il suo maestro era un grande appassionato di montagna e lo accompagnò in diversi viaggi ed escursioni. Insieme al barone Joseph von Seenus (che nel 1805 avrebbe pubblicato il resoconto di un viaggio botanico in Istria e Dalmazia), fu compagno di Wulfen in un secondo viaggio a Venezia; sulla via del ritorno visitarono varie località del Friuli e a Tolmezzo non mancarono di scalare La Mariana (Monte Amariana, 1906 s.l.m). In compagnia di un terzo ecclesiastico, il domenicano Ignaz von Eisentratten, scalarono l'Eisenhut (2441 m), la cima maggiore delle Alpi della Gurtal, e nel 1790 lo Schleinitz (2904 m) nel Gruppo dello Schober. Nel 1791, quando il botanico dilettante Carl von Zois venne apposta da Lubiana per incontrare Wulfen, venne organizzata per lui una grande escursione attraverso le catene della Carinzia superiore e del Tirolo, alla quale partecipò, oltre a Wulfen e Hohenwart, anche il goriziano Joseph Reiner, archivista e cappellano di corte prima a Gorizia poi a Klangenfurt. L'anno dopo Reiner e Hohenwarth raccontarono l'impresa in Botanische Reisen nach einigen Oberkärntnerischen und benachbarten Alpen unternommen [...], che contribuì grandemente a diffondere l'interesse per le montagne e l'alpinismo. Le testimonianze del tempo descrivono Wulfen come un uomo di alta statura, eretto anche in tarda età, forte ed agile, capace di camminare per mezza giornata senza stancarsi alla ricerca di una pianta rara e di lasciare indietro guide ed accompagnatori più giovani. Quando aveva superato la sessantina, tra il 1791 e il 1794, di passaggio da uno dei suoi viaggia a Trieste, esplorò le Dolomiti di Braies. scalando il Monte Lungo, il Picco di Vallandro e addirittura la Croda Rossa, la cima maggiore con i suoi 3.148 m. Vista la sua età, c'è chi ha messo in dubbio questa impresa; ma aveva più settant'anni quando prese parte alla più celebre impresa alpinistica austriaca dell'epoca, la conquista del Grossglockner, la cima maggiore dell'Austria (3718 metri). La spedizione fu organizzata dal principe-vescovo della Carinzia Xaver von Salm-Reifferscheidt-Krautheim, sull'onda della prima ascensione del monte Bianco del 1786. Wulfen e Hohenwart conoscevano benissimo la catena del Grossglockner, frequente terreno delle loro esplorazioni botaniche, ne furono gli ispiratori e nel 1795 furono incaricati di una prima ricognizione; nel 1798 l'area fu ispezionata dall'arcivescovo in persona, che non badò a spese per la spedizione dell'anno successivo. Furono ingaggiati due montanari (le relazioni li ricordano come "i Glokner" e ci sono incertezze sui loro nomi esatti), che predisposero sentieri e all'altezza di 2620 m costruirono un rifugio, chiamato Salmhütte in onore del principe-vescovo, sufficientemente grande da ospitare i 30 membri della spedizione, tra cui Wulfen e Hohenwart. Il 23 luglio 1799 le due guide giunsero poco sotto la vetta del Kleinglochner, ma il maltempo rallentò a lungo la spedizione dei "signori"; solo il 24 agosto Hohenwart e quattro guide riuscirono a raggiungere il Kleinglochner, una cima un poco più bassa divisa dalla vetta principale da una forcella molto esposta, ma dovettero rinunciare a scalare la cima maggiore. Si diffuse però la voce che l'impresa fosse riuscita, e che i cinque avessero addirittura eretto una croce sulla cima, avvalorata da una medaglia commemorativa fatta coniare dal vescovo, con il suo ritratto sul recto, e il profilo del Grossglockner sul verso, con la croce sulla cima e la data dell'ascesa 25 agosto 1799. In realtà fin da settembre fu pianificata una seconda spedizione per l'estate successiva. Era ancora più imponente della precedente, con ben 62 partecipanti, tra i quali di nuovo Hohenwart, Wulfen, il botanico David Heinrich Hoppe, il geologo Ulrich Schiegg e il suo allievo Valentin Stanič . Fu costruito un secondo rifugio più in alto del precedente sull'Adlesruhe (3454 m). La spedizione si servì di scale, corde e rudimentali ramponi e fu guidata dai quattro montanari che avevano già partecipato alla spedizione precedente. Furono proprio loro a raggiungere la cima maggiore il 28 luglio, mentre Hoppe, Hohenwart e il parroco Orrasch li attendevano sulla cima del Kleinglocker; quindi, ridiscesero e raggiunsero nuovamente la vetta insieme a un altro parroco, Mathias Hautzendorfer, l'unico dei primi scalatori di cui conosciamo con esattezza il nome. Il giorno successivo anche Schiegg e Stanič raggiunsero la vetta; fecero misurazioni della pressione barometrica dell'aria e misurarono l'altezza della cima, mentre le guide vi fissavano una croce. Nel 1802 e nel 1806 il vescovo finanziò altre due spedizioni; in quella del 1802, finalmente anche Hohenwart raggiunse la vetta principale. Invece, sia nel 1799 sia nel 1800, l'ormai anziano Wulfen dovette accontentarsi di assistere alla scalata insieme all'arcivescovo dal rifugio dell'Adlesruhe. Erano anni tempestosi e stupisce che il principe-vescovo avesse profuso tanto impegno (e tanto denaro) in questa impresa alpinistica e scientifica. Nel 1797 Klagenfurt era stata occupata dai francesi, che rubarono gran parte delle raccolte di Wulfen. Nonostante questo il vecchio sacerdote continuava a lavorare alla sua Flora norica, un work in progress che nel suo maniacale perfezionismo non gli pareva mai pronta per la pubblicazione, per la quale del resto gli mancavano i soldi. Rimase sano e attivo fino alla fine, quando una polmonite lo stroncò nell'arco di tre giorni nell'aprile 1805. Contava che avrebbe provveduto alla pubblicazione Schreber, al quale lasciò il manoscritto ormai completato, con le illustrazioni relative e esemplari d'erbario. Il resto delle collezioni passò invece a Hohenwart, che nel 1809 sarebbe diventato arcivescovo di Linz. Purtroppo Schreber non poté esaudire l'ultima volontà di Wulfen, sia per la situazione di guerra sia perché morì egli stesso pochi anni dopo, nel 1810. Così Flora norica rimase inedita fino al 1858, quando la Società botanico-zoologica di Vienna decise di finanziarne la pubblicazione, affidandola a Eduard Fenzl, professore di botanica dell'Università di Vienna, con l'assistenza di Rainer Graf, spiritualmente vicino a Wulfen come sacerdote originario di Lubiana; l'opera contiene anche una delle prime biografie di Wulfen. In mezzo secolo gli studi sulla flora austriaca avevano fatto molti progressi e l'opera conservava un valore quasi solo storico; in particolare, Fenzl e Graf considerarono obsoleta la parte dedicata alle crittogame e limitarono la pubblicazione alle angiosperme, sotto il titolo Flora Norica Phanerogama; benché tardiva, con le sue vivide descrizioni di 717 specie dell'Austria e delle Alpi orientali rimane una pietra miliare per la conoscenza soprattutto della flora alpina.  Wulfenia, Wulfeniopsis e altre rarità montane A Wulfen si deve la prima pubblicazione di circa 120 taxa di vegetali. Tra di essi spiccano ovviamente molte piante alpine: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), endemica dei monti della Carinzia e della Slovenia e dedicata al discepolo "a distanza" Karl von Zois che ne fu il primo raccoglitore; Primula glutinosa, un endemismo delle Alpi orientali presente anche in Italia tra Lombardia e Trentino; Saxifraga moschata, diffusa invece dai Pirenei al Caucaso; Androsace chamaejasme, presente oltre che sui monti europei, nella catena dell'Atlante in Marocco; la genzianella nana Gentiana nana (oggi Comastoma nanum), una specie di alta quota delle Alpi orientali. Lo ricordano nell'eponimo specie endemiche delle Alpi orientali di cui fu il primo raccoglitore: Primula wulfeniana, Alyssum wulfenianum, Sempervivum wulfenii, Androsace wulfeniana. E' invece originaria dei litorali mediterranei Euphorbia characias subsp. wulfenii, oggi molto coltivata nei giardini e ampiamente naturalizzata. Torniamo in montagna con Wulfenia carinthiaca, la specie tipo del genere Wulfenia (Plantaginaceae), scoperta da Wulfen nel luglio 1779 alla malga Kuehweger (1625 m.) sulle pendici del Gartnerkofel nelle alpi Carniche; von Jacquin gliela dedicò con queste parole: "Ho nominato questa bellissima pianta dal suo scopritore, uomo di grande merito botanico, cui dobbiamo tante belle e rarissime piante della Carinzia". Oltre che bellissima (speciosa, scrive von Jacquin) è anch'essa assai rara, come tutte le consorelle del genere Wulfenia, caratterizzato da una singolare distribuzione disgiunta in tre aree non contigue: le Alpi Carniche tra Austria e Italia, le Alpi Dinariche in Albania, i monti Nur nella Turchia meridionale. La stessa W. carinthiaca ha distribuzione disgiunta: nelle Alpi Carniche è presente in una ristretta area di appena 10 km² attorno al Passo Pramollo-Nassfeld Pass sia sul versante italiano sia su quello austriaco; più ampie le popolazioni dinariche, a cavallo tra Albania, Montenegro e Kosovo. Ha foglie a rosetta obovate, crenate e carnose dalle quali a metà estate, per pochi giorni, emergono alti racemi fitti di fiori campanulati blu-viola. Cresce su pietraie umide, nel sottobosco degli ontaneti e delle pinete di Pinus mugo (Alpi Carniche) e Pinus peuce (Alpi Dinariche) o nei pascoli ricchi di azoto nei pressi delle malghe appena al di sopra del limite degli alberi. W. baldaccii, simile alla specie precedente, ma di dimensioni minori, fu segnalata per la prima volta negli anni '30 del Novecento dal botanico italiano Antonio Baldacci. E' un endemismo dei Monti Prokletje nell'Albania settentrionale, dove cresce nelle fessure tra le rocce nei boschi di betulla o ai margini di essi. Le altre due specie, W. glanduligera e W. orientalis, crescono su monti più bassi e mesofili della Turchia sud-orientale, entrambe nelle fessure delle rocce, la prima nei boschi di Fagus orientalis, la seconda nelle foreste sempreverdi submediterranee. In passato erano assegnate al genere Wulfenia anche due specie himalayane. La distribuzione fortemente discontinua tra Mediterraneo e Himalaya, benché non unica, è piuttosto rara e negli anni '80 del Novecento ha spinto gli studiosi ad approfondire la questione. Paragonando esemplari di tutte le specie e i loro pollini, essi sono giunti alla conclusioni che le differenze sono tali da far assegnare quelle himalayane a un genere proprio, che è stato denominato Wulfeniopsis (simile a Wulfenia); si distingue da Wulfenia per il numero dei cromosomi, le caratteristiche del polline e i racemi molto più radi, con i fiori portati da un solo lato dell'asse, con corolla non bilabiata con quattro lobi anziché cinque. Gli sono assegnate due specie, W. amherstiana (Himalaya occidentale, dal Pakistan al Nepal centrale, da 1500 a 3000 metri di altitudine) e W. nepalensis (talvolta considerata una varietà della precedente, endemica del Nepal, tra 1500 e 2700 m). Dunque, di nuovo piante di alta montagna che non sarebbero spiaciute a padre Wulfen. Quando si spense novantenne nella sua casa viennese, uno dei centri culturali della capitale austriaca, von Jacquin era una delle personalità più riconosciute della botanica europea. Era barone dell'impero, membro di moltissime società scientifiche, fondatore della scuola botanica viennese, autore di molte opere ammirate per la precisione scientifica e la bellezza estetica. Eppure quando era arrivato a Vienna venticinquenne era uno studente di medicina squattrinato, che disperava di riuscire a trovare i soldi per laurearsi. Nato in Olanda, oltre alla protezione dell'influente archiatra van Swieten, poteva però giovarsi di un'eccellente preparazione, che mise a frutto in un'epica spedizione nei Caraibi; le disavventure non mancarono, ma i risultati furono così grandiosi da gettare le basi di una brillantissima carriera scientifica; divenuto professore di chimica e botanica all'Università di Vienna, diede mano a una serie di opere illustrate in grande formato, famose per la precisione scientifica delle descrizioni e la bellezza e l'accuratezza delle illustrazioni. Lo ricordano, oltre a centinaia di piante con gli eponimi jacquinii e jacquinianus, i generi Jacquinia (Primulaceae) e Jacquiniella (Orchidaceae).  Una serata musicale con Mozart Agosto 1786. Come ogni mercoledì sera, nella casa del direttore dell'orto botanico si riceve. E' uno dei centri culturali di Vienna, ma l'atmosfera è intima e familiare; se, grazie al colto padrone di casa, non mancano conversazioni erudite, ci sono anche giochi e divertimento, e certo buona musica, una delle passioni di famiglia. Il direttore è un eccellente flautista, il figlio minore Gottfried canta con voce di basso e compone, la diciannovenne Franziska è una delle migliori allieve del maestro Mozart. E' già così brava che egli ha scritto per lei l'impegnativa parte per clavicembalo del suo nuovo trio, che stasera sarà eseguito per la prima volta; gli altri interpreti sono lo stesso Mozart alla viola e il suo amico Anton Stadler al clarinetto. I posteri lo conosceranno come Kegelstatt Trio, o Trio dei birilli, perché sembra che Mozart l'abbia scritto durante una partita di questo passatempo, all'epoca molto amato dai viennesi. E' solo una delle numerose composizioni che il grande salisburghese dedicò a membri della famiglia von Jacquin; forse a partire dal 1783, si recava regolarmente nella loro casa sulla Rennweg, per impartire le lezioni a Franziska, era uno degli animatori delle serate del mercoledì e si legò di tanta amicizia con Gottfried (purtroppo destinato a morire ad appena 25 anni, qualche mese dopo Mozart) da permettergli di far passare per suoi diversi lieder, in modo che potesse far più colpo sulle ragazze; nelle sue lettere superstiti all'amico, manifesta grande affetto per tutta la famiglia, compresi l'"illustre genitore". Ovvero il protagonista della nostra storia, Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin (1727-1817), professore di botanica e chimica all'università di Vienna e direttore dell'orto botanico universitario, nonché uno dei botanici più stimati d'Europa. Quando era arrivato a Vienna nel lontano 1752, non era né Freiherr né von, ma lo spiantato studente di medicina olandese Nikolaus Jacquin. Come dice il cognome, la sua famiglia era di origine francese, ma si era trasferita a Leida dove il padre era il prospero proprietario di una fabbrica di tessuti e velluti; poté così assicurargli un'ottima educazione; di famiglia cattolica, fu mandato a studiare al ginnasio di Anversa, dove si appassionò grandemente allo studio dei classici, che poi avrebbe coltivato tutta la vita. Ma prima che potesse completare gli studi, lo colpi una duplice sciagura: il fallimento della ditta paterna, con la perdita di tutta la sua fortuna, e la morte del padre stesso. Per mantenersi, decise di diventare medico: completò lo studio propedeutico della filosofia a Lovanio, quindi tornò a Leida e si iscrisse alla facoltà di medicina. Per il momento, il suo interesse andava ancora quasi totalmente ai classici, tanto che progettava di scrivere un'antologia di poesia greca. Le sue ricerche lo portarono a frequentare la ricca biblioteca di Jan Frederik Gronovius, patrono di Linneo ma anche discendente di una dinastia di celebri filologi classici; fu così che strinse amicizia con il figlio di lui Laurens Theodor, che, a quanto pare, gli fece scoprire la botanica. Lo accompagnava ad erborizzare nelle campagna e a visitare giardini; e fu proprio in un giardino privato che, di fronte alla magnifica fioritura di un Costus speciosus (oggi Hellenia speciosa), decise di consacrare la sua vita allo studio delle piante. Prese a visitare con assiduità l'orto botanico di Leida e a seguire le lezioni del suo prefetto Adriaan von Royen, da cui apprese il sistema linneano. Per completare gli studi di medicina e chirurgia, si trasferì quindi a Parigi, dove seguì anche le lezioni di botanica di Antoine de Jussieu e le dimostrazioni e le erborizzazioni di suo fratello Bernard. Era ormai tempo di laurearsi, ma non aveva i soldi per le tasse d'esame. Disperato, pensò di scrivere a Gerard van Swieten, un amico di famiglia che era stato medico di suo padre, ed ora stava facendo carriera a Vienna come medico dell'imperatrice; il dottore lo invitò a raggiungerlo nella capitale austriaca, dove avrebbe potuto completare gli studi. Fu così che nel 1752 il venticinquenne Nikolaus Jacquin arrivò a Vienna senza un soldo in tasca, ma dotato di un'eccellente preparazione di base e animato dalla passione scientifica e dal desiderio di farsi strada. L'archiatra lo accolse in casa sua (un appartamento principesco agli occhi del giovane olandese). Il giovane conterraneo conquistò la sua stima e l'ammirazione dei compagni di studio, commentando Ippocrate dal testo originale; aveva un indubbio talento per le relazioni sociali e strinse amicizia con i più dotati tra di loro, come Anton von Störck, futuro pioniere della farmacologia sperimentale, Johann Georg Hasenöhrl, che sarebbe diventato protomedico del Granducato di Toscana con il nome latinizzato Lagusius, Joseph Schreibers, grande riformatore degli ospedali viennesi, di cui avrebbe sposato la sorella Katharina. Ma l'incontro decisivo avvenne nel giardino olandese di Schönbrunn, di cui Jacquin stava classificando le piante con il sistema di Linneo: fu notato dall'imperatore Francesco I che, su consiglio di van Swieten, decise di inviarlo nei Caraibi alla ricerca di piante, animali e curiosità naturalistiche per il giardino, il serraglio e le collezioni imperiali. A sua favore militavano, oltre all'eccellente preparazione come naturalista, la buona conoscenza del francese e la rete di parentele di cui godeva nelle Antille francesi e olandesi.  Un viaggio avventuroso di grande successo L'imperatore vergò di suo pugno dettagliate istruzioni, dalla cui lettura emerge chiaramente la natura non scientifica, ma squisitamente collezionistica della spedizione nei Caraibi; ciò a cui punta il sovrano è la rarità, l'esclusività: "Per quanto riguarda piante, alberi e fiori, egli [Jacquin] sceglierà personalmente le specie di fiori che sono rare e adatte al mio giardino e prenderà le radici, i bulbi e i semi, in base a come possano essere trasportati e moltiplicati. Tutti gli altri fiori che non si trovano in Europa e non sono né belli né di piacevole profumo, non devono sovraccaricare il mio giardino. [...] dovrà aver cura di non inviare nulla che abbiamo già, né [...] piante già conosciute in Europa, perché non desidero avere nulla di comune né che sia impossibile trasportare". Jacquin si preparò con scrupolo, non solo studiando le collezioni già esistenti, ma prendendo lezioni di disegno botanico dal pittore olandese Nicholas Meerburgh. Infine il 5 dicembre 1754 si mise in cammino insieme al giardiniere Ryk van der Schot. In vettura di posta, i due olandesi raggiunsero Trieste, quindi trascorsero i giorni di Natale a Venezia, dove furono prelevati da un vetturino che, via Bologna, li portò a Firenze, dove Jacquin doveva ricevere il denaro per il viaggio, contatti e altre istruzioni. A Capodanno proseguirono per Pisa e Livorno, dove per due settimane furono ospiti del marchese Ginori; fondatore della celebre manifattura di Doccia, quest'ultimo condivideva gli interessi scientifici dell'imperatore; fu il primo in Europa ad allevare le pecore d'angora e a Villa Buondelmonti faceva coltivare vaniglia, tè, caffè e varie piante esotiche. Seguendo le istruzioni imperiali, il marchese aiutò i naturalisti a completare l'attrezzatura e fornì due esperti cacciatori di uccelli di sua fiducia, Ferdinando Barculli e Giovanni Buonamici. Inoltre Jacquin conobbe l'abate Filippo Venuti, fondatore della Società botanica di Cortona e corrispondente di La Condamine, da cui ricevette molte informazioni sulle ricchezze naturali del Golfo del Messico. Furono dunque in quattro, due botanici olandesi e due uccellatori toscani, ad imbarcarsi il 21 gennaio 1755 alla volta di Marsiglia. Diversi contrattempi burocratici li trattennero in Provenza per tre mesi; Jacquin ne approfittò per stabilire accordi con la compagnia di trasporti Audibert, fare visita a La Condamine, raccogliere fossili e visitare l'orto botanico di Montpellier, dove incontrò Boissier de Sauvages; ottenne anche talee di quella che allora era una rarità, Bignonia (oggi Campsis) radicans, e le inviò sia a Vienna sia al nuovo amico Ginori. Finalmente il 21 aprile i quattro si imbarcarono su una nave mercantile; dopo uno scalo a Malaga, il 28 giugno sbarcarono nel porto di Saint Pierre in Martinica. Qui abitava Claude François Jacquin, figlio di uno zio del nostro e capo impiegato del forte; al momento dell'arrivo di Nikolaus in Martinica, la famiglia attendeva il ritorno di uno dei figli, che era andato a studiare a Parigi. Così quando il nostro botanico arrivò di notte, nella casa poco illuminata, fu accolto da grandi manifestazioni di gioia ed abbracci, finché la balia nera lo guardò in faccia e rivelò che il nuovo arrivato non era chi credevano. Jacquin e la sua squadra si misero immediatamente al lavoro; visitarono insieme varie località dell'isola, quindi si divisero; mentre Jacquin e uno degli uccellatori rimaneva in Martinica, l'altro e Van der Schot furono inviati a Grenada, per poi rientrare via Saint Lucia; tuttavia al loro rientro entrambi si ammalarono di febbre gialla; fortunatamente, al contrario a gran parte dei loro compagni di viaggio, guarirono. Già il 1 agosto partì per Marsiglia (e da qui per Vienna) il primo invio, sei casse con circa 1600 pezzi tra conchiglie, granchi, ricci di mare, coralli, fossili, pesci, insetti, monete, semi e talee di canna da zucchero. Nel frattempo, Jacquin aveva allestito un vivaio e un serraglio provvisorio, dove custodire gli animali e preparare le piante in vista dell'invio di esemplari vivi. Incominciò anche a predisporre un erbario, ma al ritorno da una delle sue escursioni constatò che era stato divorato dalle termiti. Così vi rinunciò, optando per accuratissime note di campo e schizzi ed acquarelli dal vivo; forse risale a questa esperienza il suo spiccato interesse per la rappresentazione visiva delle piante. Il secondo invio partì da Saint Pierre il 26 febbraio 1756; ad accompagnare in Europa gli animali e le 266 piante vive fu, come ho già raccontato in questo post, l'ottimo Ryk van der Schot, che aveva affiancato il suo capo anche come disegnatore. Il grosso era stato raccolto in Martinica e Grenada dalla spedizione, ma Jacquin era anche riuscito a procurarsi esemplari provenienti da zone mai visitate, come le Barbados. Il successo di questo invio, con quasi tutte le piante e gli animali giunti vivi a Vienna, si deve agli sforzi congiunti di botanico e giardiniere, che inventarono quasi dal nulla metodi efficaci per il trapianto, la preparazione e il trasporto a lunga distanza. La Martinica, con il vivaio nei pressi di Saint Pierre, era ancora la base operativa, ma tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio Jacquin e i due uccellatori si spostarono nell'isola di Sint Eustatius; l'isola era una colonia olandese e anche qui il nostro botanico poteva contare sull'aiuto e l'ospitalità di un congiunto: il comandante Jan de Windt, che aveva sposato una parente di sua madre; fu poi la volta di Sint Maartens, dove abitava un altro parente. Qui, mentre erborizzava presso la laguna salata di Simpson Bay, Jacquin cadde da una scogliera e finì su un Melocactus; riuscì però a recuperare abbastanza rapidamente grazie a impacchi di una qualche specie di Jatropa. Dopo poco meno di due settimane, il gruppo tornò a Sint Eustatius, dove il botanico si ammalò a sua volta di febbre gialla. Inviò immediatamente Barculli in Martinica ad occuparsi del vivaio; quindi, non ancora guarito del tutto, lo raggiunse insieme a Buonamici il 22 luglio. Era ora di occuparsi del terzo invio, che lasciò Saint Pierre alla volta di Livorno il 12 agosto. Più modesto dei precedenti, comprendeva due casse di curiosità naturali, pochi semi, una cassetta di erbe medicinali per van Swieten, qualche animale vivo (tra cui 4 scoiattoli volanti e 43 uccelli), e diverse piante, tra cui molti ananas, che erano stati personalmente richiesti dall'imperatore, cactacee, euforbie succulente e forse un mango. Ad accompagnarli questa volta fu l'uccellatore Buonamici. In America erano rimasti solo in due, Jacquin e Barculli, che si trovavano di nuovo a Sint Eustatius. Il 17 agosto si imbarcarono su una nave olandese diretta in Martinica, ma furono catturati da una nave inglese e portati a Saint Kitts: due mesi prima era infatti iniziato il conflitto passato alla storia come Guerra dei sette anni. Dopo sette giorni di detenzione, poterono tornare a Sint Eustatius, dove rimasero fino alla fine di ottobre. Era infatti iniziata la stagione degli uragani ed era impossibile viaggiare. Il 31 ottobre si imbarcarono di nuovo per la Martinica, ma furono nuovamente catturati dagli inglesi, che questa volta li portarono a Montserrat. Dopo pochi giorni, Jacquin poté finalmente raggiungere Saint Pierre dove scoprì che le passate disavventure gli avevano risparmiato guai peggiori: durante la sua assenza l'isola era stata totalmente devastata da un uragano. Così il suo quarto invio, che partì per Marsiglia il 14 novembre, consisteva di una sola cassa con pochi coralli, conchiglie e semi freschi. Ritenendo che Martinica non avesse altro da dare, il 7 febbraio 1757 Jacquin partì con Barculli alla volta di Curaçao; qui si sarebbero trattenuti otto mesi, esplorando le baie e l'interno in piroga. Ebbero anche la fortuna di conoscere un giovane francese, Joseph Alix, un eccellente tuffatore che raccolse molti ottimi esemplari di coralli e conchiglie. In generale, il soggiorno a Curaçao, dove Jacquin poté anche integrare le sue raccolte con acquisti da collezionisti, fu eccezionalmente produttivo: a maggio ben sedici casse di curiosità (tra cui un nido di colibrì interamente costituito di fiori, completo di genitori e uccellini) erano pronte a partire per l'Europa; ad accompagnarle fu Alix, che purtroppo morì di dissenteria durante il viaggio. Trovandosi così vicino al continente, Jacquin decise di proseguire per il Venezuela; tra il giugno e il luglio 1757 erborizzò con Barculli a Coro, Puerto Real de La Vega e la laguna di Sauca. Quindi rientrò a Curaçao per spedire il sesto invio, consistente in una cassa di curiosità e semi rari, che affidò al comandante di una nave olandese in partenza per Amsterdam il 27 agosto. Due giorni prima Jacquin e Barculli si erano imbarcati per la colonia francese di San Domingo nell'isola di Hispaniola, dove arrivarono il 21 settembre. Vi rimasero per quattro mesi; il botanico soffrì gravemente di dissenteria, ma continuò ugualmente ad erborizzare, raccogliendo almeno una cinquantina di specie. Il 4 gennaio 1758, con l'intenzione di raggiungere la Giamaica, i due viaggiatori lasciarono San Domingo sulla Parlament, una nave che batteva bandiera olandese; il giorno dopo incapparono in una flotta inglese, che trattenne la nave per qualche giorno in mare, poi la rilasciò, ordinando di raggiungere Port-au-Prince, la capitale della spagnola Haiti; ma prima di giungere a destinazione, fu catturata e saccheggiata da corsari inglesi, che derubarono tutto il derubabile e terrorizzarono le loro vittime per due interminabili giorni d'orrore. Jacquin perse i libri, i disegni, il diario di campo (per fortuna ne aveva inviato una copia a Vienna). Infine la nave fu rilasciata e il 10 gennaio raggiunse Port-au-Prince; durante la breve sosta nel porto spagnolo, Jacquin benché ancora malato fece buone raccolte. Il 17 gennaio, la Parlament, a bordo della quale ora c'erano 27 pirati prigionieri, ripartì, ancora nella speranza di raggiungere la Giamaica; due giorni dopo fu abbordata da tre vascelli pirati decisi a liberare i loro compagni; attenuto il loro scopo, rilasciarono la nave che il 22 gennaio giunse finalmente in Giamaica. Jacquin si recò immediatamente a Spanish Town per incontrare il governatore e ottenere il permesso di rimanere nell'isola ad erborizzare; ma il governatore era assente e dovette andare a Kingston a incontrarne il sostituto. Durante il viaggio di ritorno, il suo calesse si ribaltò e nell'incidente il cocchiere perse una gamba. Un pessimo inizio; forse per questo, dopo aver erborizzato per qualche giorno nei dintorni di Spanish Town, il 19 marzo Jacquin si imbarcò con Barculli su una nave negriera diretta a Cartagena. Fu un viaggio non meno orribile dei precedenti, tanto per lo scafo sovraccarico, che faceva temere ogni momento un naufragio, quando per l'angoscioso spettacolo dell'inumano trattamento inflitto dai negrieri ai giovani africani. Arrivato a Cartagena il 24 marzo, dopo pochi giorni Jacquin contrasse nuovamente la febbre gialla e fu in punto di morte. Il 25 maggio stava abbastanza bene da godersi lo spettacolo delle processioni del Corpus Domini. Fece ancora qualche escursione nell'interno, finché decise che era ora di tornare a casa. Avrebbe desiderato farlo per la via più breve, imbarcandosi su una nave diretta a Cadice, ma a lungo non riuscì a trovarne nessuna disposta a traportare il suo gran carico di animali vivi; stava quasi per rassegnarsi a imbarcarsi nuovamente sulla sciagurata nave negriera, quando in porto giunse il mercantile spagnolo El Marte, disposto a portare Jacquin e il suo serraglio in Spagna. Non a Cadice, però. Il 19 ottobre Jacquin e Barculli lasciarono Cartagena, ma li attendeva un viaggio difficile, funestato da tempeste e cambi di rotta; ci fu anche una lunga sosta all'Havana, in cui Jacquin, dopo inglesi, pirati e capitani negrieri, si trovò ad affrontare la curiosità delle signore della città, che ronzavano attorno al luogo dove aveva ricoverato le sue bestie e le sue piante "fino a tarda notte". Ripartito da Cuba il 4 gennaio 1759, El Marte toccava infine la costa europea a Ferreol il 25 febbraio. Non c'erano navi dirette a Bordeaux, e Jacquin dovette ancora sobbarcarsi un viaggio complicato che lo portò in nave a Bayonne, e poi via terra, attraverso la Francia e la Germania, fino a Ulm, dove poté imbarcarsi sul Danubio alla volta di Vienna. Vi giunse il 17 luglio 1759, dopo un'assenza di cinque anni e sette mesi.  Capolavori dell'illustrazione botanica Era la fine di un grande viaggio e l'inizio di un'ancor più importante carriera scientifica. Le straordinarie collezioni che il botanico olandese aveva inviato a Vienna avevano pienamente soddisfatto le aspettative del sovrano, che continuò a pagargli lo stipendio, permettendogli di dedicarsi alla pubblicazione delle raccolte botaniche; ansioso di farsi riconoscere dall'ambiente scientifico europeo, Jacquin si affrettò a pubblicare Enumeratio sistematica plantarum quas in insulis Caribaeis vicinaque Americae continente detexit, novas aut jam cognitas emendavit (prima ed. Leida 1760, seconda ed. Francoforte 1762), un'operina di poco più di quaranta pagine, con una lista di circa 300 specie di una settantina di generi, con sinteticissime diagnosi, rigorosamente classificate secondo il sistema lineano. Anche se l'area caraibica non era certo una novità per i botanici (ma lo erano i dintorni di Cartagena in Colombia), non poche erano nuove per la scienza; tra di esse Swietenia mahagoni, l'albero del mogano, opportunamente dedicato al suo protettore van Swieten. Enumeratio sistematica - una delle primissime opere ad utilizzare sistematicamente la nomenclatura binomiale - attirò l'attenzione di Linneo; da quel momento tra il giovane botanico olandese e il luminare svedese iniziò un fitto scambio epistolare. Nel corso degli anni, Jacquin gli avrebbe inviato circa cento lettere, molte delle quali contengono esemplari essiccati, disegni, tavole a stampa tratte dalle sue opere successive. La seconda opera di Jacquin è Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi, montibusque confinibus (Vienna, 1762), frutto delle sue erborizzazioni nelle campagne viennesi. Ma già nel 1763 fu in grado di pubblicare le sue piante americane in una veste molto più ambiziosa. Selectarum stirpim Americanarum historia è una sontuosa opera dedicata all'imperatore Francesco I, con oltre 300 pagine di testo e 183 tavole illustrate, tratte dai disegni eseguiti da Jacquin stesso e in parte da Ryk van der Schot durante il viaggio o nel giardino di Schönbrunn, dove nel frattempo un buon numero di piante aveva prosperato. Le esigue diagnosi del 1760 si sono dilatate in accurate descrizioni e in molti casi sono state aggiunte le località di raccolta; le specie nuove sono una cinquantina; tra le più notevoli, Elaeis guineensis, la palma da olio. Le illustrazioni, sebbene un po' rigide, spiccano per l'accuratezza e non mancano di pregio estetico; furono stampate in bianco e nero, ma sono noti tre esemplari dipinti a colori, disposti per l'imperatore e la sua cerchia. Nel 1763, grazie alla raccomandazione di van Swieten, Jacquin fu nominato professore di chimica, metallurgia e mineralogia dell'accademia mineraria di Schemnitz (oggi Banská Štiavnica) in Slovacchia; nel campo della chimica propugnò il metodo sperimentale e diede contributi originali (fu anche corrispondente di Lavoisier), ma il suo grande amore rimanevano le piante; creò un orto botanico, continuò ad erborizzare, a disegnare piante e a scrivere di botanica; frutto degli anni slovacchi è Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum, in quattro parti, pubblicate tra 1764 e il 1771; vi compaiono, senza un ordine particolare, piante viste durante il viaggio americano, ma anche osservate in Austria o in Slovacchia, in qualche giardino o ricevute da amici; le tavole sono nuovamente tratte da disegni dell'autore. Intanto a Vienna van Swieten si dava da fare per assicurare al suo protetto un incarico di maggior prestigio e più confacente alle sue aspirazioni. L'archiatra era in pessimo rapporti con il francese Robert Laugier, il primo titolare della cattedra di chimica e botanica dell'Università di Vienna, nonché primo prefetto dell'orto botanico universitario; con un'efficace azione di lobbing (e mobbing), riuscì a convincere l'imperatrice ad allontanarlo, costringendolo alle dimissioni. Così nel 1769 Jacquin lo sostituì ed applicò la sua incredibile energia a trasformare l'orto botanico viennese in uno dei maggiori d'Europa, nonché Vienna in una delle capitali della scienza botanica, soprattutto grazie a una serie di grandi pubblicazioni illustrate, a iniziare dal catalogo dello stesso orto botanico. In tre volumi, pubblicati tra il 1770 e il 1776, Hortus botanicus Vindobonensis presenta le piante più rare del giardino "costruito grazie alla munificenza regia della venerabilissima Maria Teresa quale meraviglioso ornamento dell'università patria e per la pubblica utilità". Ora che l'insegnamento e la direzione dell'orto botanico non gli lasciavano più il tempo per dipingere egli stesso, Jacquin affidò le illustrazioni a un pittore di grande talento, Franz von Scheidel (1731-1801), che disegnò e dipinse 300 tavole, 100 per ciascun volume, un capolavoro dell'illustrazione botanica, in cui alla precisione scientifica (spesso la raffigurazione della pianta a tutta a pagine è affiancata dai particolari significativi per l'identificazione) si uniscono la freschezza del tratto. Era la prova generale per un'opera ancor più ambiziosa, Florae Austriacae, sive plantarum selectarum in Austriae archiducatu sponte crescentium; in cinque volumi, usciti tra il 1773 e il 1778, ancora con 100 tavole per volume, la Flora austriaca, spesso definito "il più bel libro dedicato alla flora spontanea europea", detterà gli standard per le successive flore nazionali come Flora danica e Flora graeca: formato in folio, illustrazioni di grandissima qualità estetica, accurate descrizioni scientifiche, nomenclatura binomiale, sinonimi. Tra le specie descritte per la prima volta da Jacquin troviamo il biancospino Crataegus monogyna, Viola alpina, Draba stellata, Rhamnus saxatilis, e tre nuovi generi: Peltaria, Wulfenia e Scopolia. Era un monumento alla gloria imperiale non inferiore per sontuosità allo stesso Schönbrunn; l'imperatrice espresse il suo apprezzamento elevando alla nobiltà il botanico, che dal 1774 poté premettere il gentilizio von al suo cognome. Molto lavoro di raccolta fu fatto dallo stesso von Jacquin, che non disdegnava di arrampicarsi alla ricerca di piante montane, magari insieme al pittore Scheidel, autore anche di gran parte delle illustrazioni di Flora austrica. Ma come il pittore era ormai circondato da una vera e propria scuola (alla quale si formarono, tra gli altri, i fratelli Bauer), anche il botanico stimolò le raccolte di allievi e corrispondenti che gli spedivano piante dai vari paesi che costituivano il multietnico impero austriaco; tra i tanti, citiamo almeno Franz Xaver von Wulfen, esploratore della flora delle Alpi austriache. Oltre che di botanica, l'attivissimo von Jacquin scriveva anche di medicina e di chimica; intorno al 1780 fu lui a convincere l'imperatore Giuseppe II a inviare in America una seconda spedizione per ripopolare le serre di Schönbrunn; i risultati di quell'impresa, iniziata male ma conclusasi con un inatteso successo (ne ho parlato in questo post) furono anch'essi documentati da una grande opera illustrata: Icones plantarum rariorum, in tre volumi pubblicati tra il 1781 e il 1793, con 648 tavole, per lo più dipinte da Joseph Hofbauer, dai fratelli Bauer e Joseph Scharf. Mentre in quest'opera i testi, con le piante classificate secondo il sistema linneano, sono estremamente succinti, riacquistano importanza in quella che ne può essere considerata la continuazione, Plantarum rariorum horti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones et icones, in quattro volumi (1797-1804), che riprende la formula del catalogo dell'orto botanico di Vienna e di Flora austriaca, con 125 tavole per volume; i principali artisti sono Johannes Scharf e Martin Sedelmayer. Quando uscì quest'opera della sua vecchiaia, von Jacquin si era già ritirato dall'insegnamento e dalla direzione dell'orto botanico universitario, riuscendo però a garantire l'uno e l'altro incarico al figlio Joseph Franz, che già dal 1790 lo affiancava e dal 1797 lo sostituì. Da quello momento, visse in pensione, continuando però a scrivere finché l'età avanzata e quello che è stato definito marasmus senilis glielo impedirono. Corrispondeva con tutti i principali botanici del tempo ed era membro di numerose società scientifiche. Nel 1806 fu nominato barone (Freiherr) e insignito dell'ordine di Santo Stefano, Morì novantenne nel 1817; la sua ultima preoccupazione andò ancora alle piante e ai libri; sul letto di morte, circondato dai figli e dai nipoti, chiese ansioso "E' già fiorita la Stapelia?" Le Stapeliae, arrivate a Schönbrunn dal Sudafrica grazie a Franz Boos e Georg Scholl, erano state il suo ultimo amore, ma forse più che alle piante pensava alla sua ultima opera, una monografia sul genere Stapelia (Stapeliarum in hortus Vindobornensibus cultarum descriptiones figuris coloratis illustratae) che aveva iniziato nel 1806, pubblicandone quattro volumi; l'ultimo era ancora incompleto e sarebbe stato pubblicato postumo dal figlio nel 1819.  Arbusti caraibici Nella sua lunga ed operosa vita, il barone von Jacquin lasciò una profonda impronta nella botanica. Durante la sua gestione, le collezioni degli orti botanici di Schönbrunn e Vienna ebbero tale sviluppo da rivaleggiare alla pari con quelle di Londra e Parigi; fu di fatto il fondatore della scuola botanica austriaca, dando grande impulso alle ricerche nei territori soggetti alla corona asburgica, dalla stessa Austria, all'Ungheria, alla Boemia, alle terre adriatiche; creò spettacolari opere illustrate che dettarono un modello emulato ma mai superato. Pubblicò più di 30 opere di medicina, chimica, botanica. Il contributo di von Jacquin è ben riconoscibile nella nomenclatura botanica. Pubblicò più di 1000 taxa; i suoi lavori sulla flora caraibica divennero opere di riferimento, gli splendidi cataloghi delle collezioni viennesi fecero conoscere moltissime specie esotiche e Flora Austriae molte piante della flora alpina e centroeuropea. Lo ricordano gli eponimi jacquinii (circa 190 occorrenze) e jacquinianus (un'ottantina di occorrenze) e due generi, Jacquina e Jacquinella. Il primo riconoscimento arrivò molto presto, da parte di Linneo in persona. Jacquinia L. (1759) testimonia la sua stima per il più giovane collega, che lo teneva aggiornato sulle sue ricerche e lo consultava sulla catalogazione delle nuove specie, spesso inviando a Uppsala esemplari, disegni, fogli della sue opere illustrate che lo rallegravano sommamente (e deliziano gli studiosi di oggi). Lo svedese pubblicò Jacquinia nell'ambito di una tesi sulla flora della Giamaica, scegliendo molto opportunamente un genere soprattutto caraibico. Oggi assegnato alla famiglia Primulaceae (sottofamiglia Theophrastoideae), comprende una ventina di specie di arbusti e piccoli alberi; molte sono endemiche di una singola isola dei Caraibi; il centro di diversità è Cuba, con 12 specie, otto delle quali endemiche; a nord una specie, J. keyensis, raggiunge la Florida, mentre a sud J. armillaris si estende al Brasile. L'habitat tipico sono le macchie costiere, piuttosto aride e soggetto al vento e alla salinità; ne conseguono adattamenti come i rami più o meno pelosi e le foglie coriacee. La specie più settentrionale, J. keyensis, è un grazioso arbusto alto fino a tre metri, con rami molto intricati e profumatissimi fiori bianchi; la più meridionale J. armillaris fu pubblicata proprio da Jacquin che la vide in molti luoghi (Curaçao, Martinica, Cartagena) e fu colpito dal suo elegante portamento; il nome (armilla in latino significa bracciale) è una traduzione del nome creolo bois bracelet, dovuto all'abitudine degli indios di ricavare braccialetti dai semi appositamente perforati "a mo' di perle".  Orchidee epifite in miniatura Durante il viaggio americano, Jacquin aveva raccolto anche diverse orchidee, tra cui un'epifita raccolta "nelle foreste della Martinica" che chiamò Epidendrum globosum. Nel 1920, l'orchidologo tedesco Rudolf Schlechter lo separò da Epidendrum insieme ad altre due specie, creando il genere Jacquiniella. Oggi gli sono attribuite una dozzina di specie distribuite dal Messico al Sud America tropicale. Sono prevalentemente epifite e sono caratterizzate da piccole foglie carnose, spesso lateralmente appiattite, con infiorescenze o fiori singoli all'ascella fogliare. La specie più diffusa è proprio J. globosa (Puerto Rico, Messico, Caraibi, America centrale. Columbia, Ecuador, Peru e Venezuela) che vive nelle foreste tra 200 e 2400 metri, in ombra leggera; ha rami squadrati, penduli, molto cespugliosi, all'apice dei quali, all'ascella delle due ultime foglie, piccole, carnose e appiattite, spuntano uno o due piccoli fiori giallo-verdastri, seguiti da un frutto verde e globoso. E' un'orchidea miniatura come J. equitantifolia (diffusa dal Messico al Sud America) che invece ha lunghe foglie lanceolate carnose distiche, da cui emerge un'infiorescenza ramificata di piccoli fiori aranciati profumati nelle ore notturne. La specie più grande e forse più rara è J. gigantea, che vive nelle foreste montane intorno a 2500 metri nel Chapias (Messico) e nelle aree adiacenti del Guatemala; produce fusti lunghi circa un metro, ciascuno dei quali porta da quattro a sei foglie; i fiori solitari, privi di profumo e abitualmente autoimpollinanti, sono verdi soffusi di viola. Ognuno ha i suoi talenti. Quelli di Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e imperatore più di nome che di fatto, non erano né la politica né le armi, ma gli affari (per i quali è considerato addirittura un genio), le arti e le scienze. Fu un grande mecenate e lasciò la sua impronta più visibile nel parco di Schönbrunn, dove volle ci fossero anche un serraglio e un orto botanico ricchi di animali e piante esotiche. Su suggerimento dell'archiatra van Swieten, a crearlo furono due giardinieri olandesi, Adrianus van Stekhoven e Ryk van der Schot. Per popolare gabbie e aiuole, l'imperatore progettò di persona e finanziò una spedizione nelle Antille che ebbe grandissimo successo, certo grazie alla competenza e alle capacità organizzative del botanico von Jacquin, ma anche all'ingegno del giardiniere van der Schot che riuscì nell'impresa, rara all'epoca, di fare arrivare vive decine e decine di piante rare. Meritatissima dunque la dedica dell'esotico e sfavillante genere Schotia. 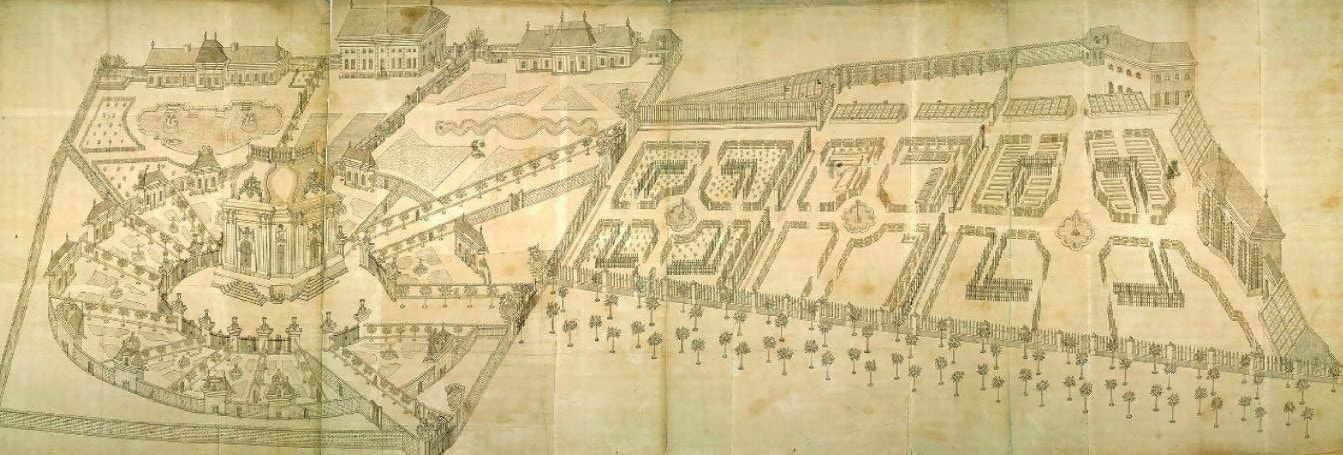 La nascita di un giardino imperiale Avere tempo libero può essere un ottimo affare. Francesco Stefano di Lorena, il marito francese dell'imperatrice Maria Teresa, anche dopo essere stato nominato imperatore come Francesco I, lasciò la cura dello stato alla consorte, che se ne intendeva molto più di lui, e si dedicò a consolidare il patrimonio familiare (abilissimo, lo separò da quello statale e lo moltiplicò, divenendo multimilionario grazie agli ottimi investimenti e a manifatture all'avanguardia) e alle sue svariate passioni. Patito cacciatore e coureur de femmes, buon violinista e mecenate di musicisti e compositori, amante del teatro, fu soprattutto collezionista) collezionava monete e medaglie) e protettore delle scienze. Quando divenne granduca di Toscana, acquistò per 40.000 scudi il ‘Cabinét de curiosités’ dell'erudito Jaen de Baillou, un'ampissima collezione di minerali, fossili, conchiglie, insetti ed altre curiosità naturali, e lo fece venire a Vienna insieme allo stesso Baillou come direttore della sua collezione privata, il primo nucleo del futuro Naturistorische Museum. Gli esemplari vennero sistemati in un palazzo sulla Wallnerstrasse (noto come Kaiserhaus) dove Francesco Stefano aveva i quartieri privati in cui poteva ricevere discretamente diplomatici e i suoi vari emissari, nonché gli scienziati che amava riunire attorno a sé; disponeva di una biblioteca e di un laboratorio ben attrezzato, dove venivano condotti esperimenti utili alle sue attività commerciali. Uno dei frequentatori più assidui era sicuramente l'archiatra van Swieten e probabilmente fu lui a suggerirgli di trasformare anche una parte del parco di Schönbrunn in un vero e proprio centro di ricerca, con un serraglio e un orto botanico. Il palazzo di Schönbrunn era inizialmente un casino di caccia, molto caro dall'imperatrice cui era stato ceduto dal padre, l'imperatore Carlo VI, quando era una giovane sposa; a partire dal 1743, la sovrana ordinò grandi ampliamenti per trasformarlo nella residenza estiva della famiglia imperiale, sontuosa come Versailles ma allo stesso tempo più intima e familiare. Della sistemazione dei giardini si occupò il marito, che si avvalse di diversi artisti fatti venire dalla Lorena. Era un giardino formale alla francese, con viali diagonali che confluivano al centro lungo un asse longitudinale. Di fronte alla facciata sud del palazzo, si allungava un vasto parterre con aiuole a disegni (parterre de broderie), delimitato lateralmente dai "boschetti", stanze verdi con siepi ed alberi potati in forme geometriche. Questa era la parte pubblica e di rappresentanza del parco. C'erano poi giardini riservati alla sola famiglia imperiale, tra cui proprio il settore a vocazione scientifica voluto da Francesco Stefano. Intorno al 1750 egli acquistò dalla comunità di Hietzing un terreno situato all'estremità occidentale del parco. In primo luogo vi fece allestire il serraglio; costruito nel 1751 su disegno dell'architetto lorenese Jean-Nicolas Jadot, ha pianta radiale; il centro è occupato da un padiglione da cui si godeva una vista a 360° sui viali a stella che portavano alle singole gabbie e voliere; è una leggenda che nel sotterraneo si trovasse un laboratorio imperiale segreto. Inaugurato con un grande ricevimento nell'estate del 1752 e, benché trasformato, ancora esistente, è considerato il più antico giardino zoologico del mondo. Nel 1753, iniziarono i lavori per l'annesso orto botanico. Su suggerimento di Van Swieten, fu assunto un esperto orticultore di Leida, la città natale dell'archiatra: Adrianus van Stekhoven (o, alla tedesca, Adrian Steckhoven, 1704/05-1782) arrivò a Vienna insieme al suo assistente Ryk (o Richard) van der Schot (1733-1790), nativo di Delft; portavano con loro 10.000 bulbi e una collezione di piante esotiche, tra cui una palma con una storia. Stekhoven sosteneva che nel 1684 l'avesse fatta venire dall'India lo Statolder Guglielmo d'Orange, poi Guglielmo III d'Inghilterra; all'epoca, la pianta aveva un'eta stimata di 30 anni. Nel 1702 fu donata al re Federico I di Prussia; nel 1739 il suo successore l'aveva donata a lui. Egli la trapiantò nel giardino viennese nel 1753 e nel 1765, con assidue cure, riuscì a farla fiorire e persino a fruttificare. Da quel momento fu per tutti la "palma di Maria Teresa". Scomparsa da molto tempo, non è mai stata identificata con certezza, anche se è stato supposto potesse trattarsi di Corypha umbraculifera, una palma monocarpica nota per la crescita lenta e per aver l'infiorescenza ramificata più grande del mondo. In tal caso, sarà morta poco dopo la prodigiosa fioritura. Ma torniamo al giardino che, creato da maestranze olandesi, è noto come "Giardino olandese". Aveva pianta grosso modo rettangolare; separato dal serraglio sul lato nord da una palizzata, era diviso in tre riquadri, ciascuno dei quali comprendeva quattro aiuole simmetriche, con una fontana centrale, nel punto d'intersezione dei sentieri; nel primo riquadro vennero piantati i bulbi portati dall'Olanda e altri fiori, in quello centrale orticole e piante da fiore, nell'ultimo specie delicate da proteggere in inverno, non ci è noto se in piena terra o in vaso. Al di fuori del giardino, lungo il lato occidentale, c'erano piante da frutto; altri fruttiferi, potati a spalliera, erano coltivati lungo il muro orientale. All'estremità del giardino venne costruita una grande serra, cui più tardi vennero aggiunte due ali; sul lato occidentale, c'erano quattro serre più piccole, forse più simili a cassoni vetrati, e sul fondo la casa del capo giardiniere. Nell'arco di un anno, il giardino fu pronto. Era certo ben organizzato, con le piante sistemate in modo scientifico, secondo il modello dell'orto botanico di Leida, ma appariva ancora molto vuoto, e un po' troppo casalingo e troppo simile simile a un orto. Francesco Stefano avrebbe voluto qualcosa di decisamente più imperiale. Stando alle memorie che Nikolaus Joseph von Jacquin dettò al figlio Joseph Franz, non gli sfuggì che quel giovanotto frequentava assiduamente il recentissimo giardino: ne stava infatti catalogando le piante secondo il sistema di Linneo, ancora ignoto negli Stati austriaci (del resto, Species plantarum è del 1753). Sentito il solito van Swieten, capì che era la persona giusta per popolare quelle aiuole e quelle gabbie troppo vuote. Gli propose di partire per le Indie occidentali a fare incetta di piante e animali esotici. Von Jacquin accettò, e il 9 dicembre 1754, munito di precise istruzioni imperiali e accompagnato dal solo aiuto giardiniere van der Schot, partì all'avventura. Mi riservo di raccontare questa spedizione in un altro post, per concentrarmi qui sul giardino e i suoi giardinieri. Basti ora dire che la spedizione si protrasse per cinque anni e toccò gran parte delle Antille; Von Jacquin si rivelò un ottimo organizzatore e inviò periodicamente a Vienna animali, piante e casse di curiosità naturali; il primo invio dalla Martinica giunse già nell'agosto 1755. All'inizio del 1756, era pronto un invio particolarmente prezioso: 266 tra alberi e arbusti, di 40 specie differenti, in gran parte ancora ignoti in Europa; mediamente gli alberi erano alti un metro, con un tronco del diametro di un braccio e più. Van der Schot li aveva accuratamente preparati al viaggio, estirpandoli dal terreno con una gran parte delle radici; le zolle, che potevano pesare anche 100 libbre, venivano poi avvolte in foglie di banano e assicurate con corde di Hibiscus tiliaceus. Inoltre, per limitare al massimo il fabbisogno d'acqua, le chiome erano state accuratamente potate, mantenendo la forma naturale. Nonostante questi preparativi, se nessuno se ne fosse preso cura durante il viaggio oceanico quelle piante sarebbero in gran parte perite. Ecco perché ad accompagnarle fu van der Schot in persona, che il 28 febbraio si imbarcò con il prezioso carico alla volta dell'Europa su un vascello dal nome ben augurante, l'Espérance. Oltre alle piante c'erano 27 uccelli esotici, un formichiere, un uistitì e dieci casse di conchiglie, pesci essiccati, fossili, minerali e oggetti etnografici. Le piante erano state preparate così bene e seguite con tanta cura che, ad eccezione delle Heliconia divorate dai ratti di bordo, arrivarono tutte sane e salve: uno straordinario successo per l'epoca dei velieri, quando la percentuale di piante vive che riusciva a superare i viaggi transoceanici era bassissima. Von Jacquin spedì a Vienna in tutto sette invii. Con l'ultimo, partito dall'Havana nel gennaio 1759, viaggiava egli stesso, insieme all'ultimo dei suoi compagni, l'uccellatore toscano Barculli. Grazie alla fortunatissima spedizione, il serraglio e il giardino olandese si trovarono d'un colpo a eguagliare se non a superare le collezioni dei giardini reali di Parigi o Londra. Nominato giardiniere imperiale e direttore del giardino di Schönbrunn, Van Stekhoven lo diresse abilmente per molti anni, intervenendo anche nel resto del parco, dove aggiunse tra l'altro una grotta artificiale al di sopra della bella fontana che gli dà il nome. Anche se nel 1765 l'imperatore morì all'improvviso, le collezioni continuarono a crescere; le conosciamo grazie al catalogo manoscritto redatto da Richard var der Schott tra il 1774 e il 1779. Finché, in una fredda giornata del novembre 1780, si produsse un increscioso incidente: mentre van Stekhoven, ormai anziano, giaceva a letto per un attacco di gotta e van der Schot era influenzato, uno degli aiuti dimenticò di ricaricare la stufa della grande serra; al mattino, il capo giardiniere accorse e completò il disastro caricandola troppo: così le piante che erano sopravvissute al gelo morirono per il caldo eccessivo. Non c'è da stupirsi se fu messo a riposo e sostituito da van der Schot, che diresse i giardini imperiali fino alla morte nel 1790, inaugurando anche una dinastia di giardinieri; suo figlio Joseph tra il 1794 e il 1804 fu il capo giardiniere dell'orto botanico universitario di Vienna. In precedenza, era stato uno dei membri della spedizione Märter, decisa da Giuseppe II proprio per rimediare i guasti dell'incidente del 1780. Oltre a lavorare nei giardini imperiali, padre e figlio furono attivi come progettisti di giardini in Boemia. Nel 1785 Richard van der Schot disegnò il parco all'inglese del castello di Veltrus per il conte Johann Chotek, mentre all'inizio dell'Ottocento il figlio passò alle dipendenze del principe di Liechenstein che lo mandò in America a fare incetta di piante per trasformare il parco di Lednice in stile paesaggistico.  Splendide fioriture Van Stekhoven è ricordato da una via di Vienna (Steckovengasse) ma da nessuna pianta, al contrario di van der Schot, onorato dal genere Schotia, istituito da von Jacquin con una dedica che ben testimonia la sua stima per l'antico compagno di viaggio: "Questo alberetto che nel mese di ottobre fiorisce copiosamente e in modo assai elegante nella serra calda del giardino imperiale di Schönbrunn costituisce un nuovo genere; perciò gli ho dato un nuovo nome, desunto dall'eccellente Richard van der Schot, giardiniere imperiale e prefetto del giardino imperiale di Schönbrunn, un tempo mio compagno di viaggio in America, grazie alla cui cura indefessa e all'eccezionale abilità in quel giardino sono oggi coltivate tante piante rare che ogni anno producono fiori". Von Jacquin espresse la sua stima anche scegliendo una pianta particolarmente bella, come lo sono tutte le quattro specie di questo piccolo genere di Fabaceae endemico dell'Africa meridionale. Sono alberi da piccoli a grandi, con vistose fioriture, scarlatte per Schotia afra, S. brachypetala e S. capitata, rosa per S. latifolia. I colori giusti per attirare i loro principali impollinatori, gli uccelli nettarinidi. In effetti producono enormi quantità di nettare, un richiamo e una risorsa anche per api e altri insetti, ma un problema quando vengono piantati in aree pavimentate. Il fogliame decorativo e il portamento aggraziato ne fanno ottime piante da ombra nelle aree non soggette a gelate; nei paesi d'origine hanno però molti alti usi: i semi di tutte le specie sono eduli, e i baccelli vengono raccolti ancora verdi e poi arrostiti; la corteccia di alcune specie veniva usata per produrre coloranti; corteccia, e talvolta foglie e radici, hanno proprietà medicinali. Qualche approfondimento nella scheda. A partire dalla seconda metà del Settecento, l'Università di Vienna acquisì grande rinomanza per la sua scuola di medicina. Il merito spetta all'olandese Gerard van Swieten, che, nominato archiatra dell'imperatrice Maria Teresa, trapiantò nella capitale austriaca gli insegnamenti del suo maestro Boerhaave, riformando profondamente il fino ad allora arretrato insegnamento della medicina. Tra i suoi meriti, anche l'introduzione della chimica e della botanica nel curriculum dei futuri medici e la fondazione dell'orto botanico universitario di Vienna. Il suo allievo Nikolaus von Jacquin, che tanto gli doveva anche a livello personale, volle ricordarlo dedicandogli Swietenia, il genere cui appartengono gli alberi da cui si ricava il bellissimo mogano.  Un medico riformatore A Vienna, al centro della piazza omonima, campeggia il gigantesco monumento all'imperatrice Maria Teresa d'Austria, voluto da Francesco Giuseppe per celebrare la sua antenata e insieme le glorie dell'impero austriaco. La sovrana è assisa sul trono, al sommo di un alto pilastro in granito, ciascuno dei cui lati è ornato da un timpano con un gruppo ad alto rilievo ed una statua indipendente, che rievocano i quattro settori in cui eccelse l'Austria dei lumi: la politica, l'amministrazione, le armi, le scienze e le arti. A rappresentare queste ultime nel rilievo il numismatico Joseph Hilarius Eckhel, lo storico György Pray e i musicisti Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart bambino; davanti a loro la statua dell'archiatra Gerard van Swieten (1700-1772), fondatore della scuola di medicina di Vienna, che dell'imperatrice non fu solo il medico personale, ma ascoltatissimo consigliere e anima di molte riforme non solo in campo medico. Eppure egli non era né austriaco né suddito imperale, ed aveva accettato il prestigioso incarico con estrema riluttanza. Olandese, era nato a Leida in una famiglia cattolica di origini nobili. Iniziò gli studi nella città natale in modo brillante, ma a 12 anni perse il padre, un affermato notaio che lavorava soprattutto per una clientela cattolica. Inviato dai suoi tutori a studiare filosofia a Lovanio, si appassionò di scienze naturali. Avrebbe voluto studiare medicina a Leida, ma al momento non ne aveva la possibilità economica. Così a 15 anni fu messo a bottega ad Amsterdam presso il farmacista Laurens Tatum; tuttavia nel 1717 contrasse il vaiolo e, una volta guarito ritornò a Leida; ne approfittò immatricolarsi nella facoltà di medicina, in quegli anni dominata dal grande Boerhaave, un medico famoso in tutta Europa, che insegnava medicina, chimica, botanica e dirigeva l'orto botanico universitario. Fu così folgorato dalla sua versatile sapienza e dal suo metodo innovativo (Boerhaave fu il primo a portare i suoi studenti al capezzale dei malati, creando di fatto la medicina clinica) che per anni, anche quando era già lui stesso medico, continuò a seguire le sue lezioni (si dice ne abbia persa solo una). Tra il 1718 e il 1720 completò la formazione come farmacista presso Nicolaas Stam, decano della corporazione dei farmacisti e ottimo chimico (suo padre David era stato il maestro di chimica di Boerhaave), ottenendo la licenza nel 1720. Senza interrompere gli studi di medicina, aprì una propria bottega a Leida e nel 1725 si laureò con una tesi sulle arterie e le loro funzioni. Per qualche tempo affiancò le due attività di farmacista e medico, ma del 1727 si concentrò sulla medica e prese anche ad impartire lezioni private di chimica e medicina, finché nel 1734 gli venne vietato dall'Università. Come medico aveva un'ampia clientela ed era molto stimato, tanto che nel 1738, quando morì Boerhaave, sarebbe stato il più indicato a succedergli: ma ciò era impossibile, in quanto cattolico. Ne aveva seguito le lezioni fino alla morte, e nel 1742 iniziò a pubblicare i suoi aforismi con i propri commenti (Commentaria in Hermani Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, "Commenti sugli aforismi di Boerhaave su come diagnosticare e curare le malattie"); l'opera, arricchita con la sua personale pratica clinica, l'avrebbe accompagnato per tutta la vita, fino all'ultimo volume, uscito nel 1772. La sua fama intanto aveva travalicato i confini dell'Olanda; nel 1742 morì l'archiatra imperiale e, su raccomandazione del futuro cancelliere von Kaunitz, che all'epoca amministrava i Paesi Bassi austriaci e aveva sentito parlare della sua competenza professionale e della sua indipendenza di pensiero, il posto fu offerto a van Swieten che inizialmente rifiutò, scrivendo a un amico che preferiva rimanere "un piccolo repubblicano piuttosto che portare un titolo pomposo che nasconde un'esistenza da schiavo". La diplomazia imperiale però continuò a lavorarlo ai fianchi, finché, dopo un anno e mezzo, nell'ottobre 1744, forse soprattutto considerando che, come cattolico, aveva poche prospettive di carriera in patria, cedette, e da repubblicano si fece monarchico. Subito dopo l'accettazione, fu chiamato a Bruxelles, per assistere la sorella minore di Maria Teresa, governatrice dei Paesi Bassi, mai ripresasi dopo aver dato alla luce un bimbo nato morto. Purtroppo van Swieten non poté salvarla, ma non perse perciò la fiducia dell'imperatrice. Nel maggio 1745, dopo aver venduto i propri beni olandesi, si trasferì a Vienna con la famiglia; infatti, nel frattempo si era sposato con Maria ter Beeck van Coesfelt, anch'essa figlia di un notaio e sorella di un antico compagno di scuola di Lovanio, e ne aveva avuto cinque figli; la sesta, chiamata Maria Teresa, in onore della sovrana, sua madrina, sarebbe nata a Vienna. Van Swieten, le cui idee innovative (nonché i modi borghesi) erano tutt'altro che graditi a cortigiani e maggiorenti austriaci, godette della stima e dell'assoluta fiducia della sovrana; oltre che archiatra, fu nominato prefetto della biblioteca imperiale e nel 1749 gli fu affidata la riforma della facoltà di medicina dell'Università di Vienna, all'epoca molto arretrata e dominata dai gesuiti e dalla corporazione dei medici. Come preside della facoltà, Van Swieten, oltre a tenere egli stesso conferenze di fisiologia e medicina generale nella biblioteca di corte, rinnovò il corpo insegnante; dotò l'università di aule e strutture adeguate; istituì le cattedre di medicina teorica, medicina pratica, anatomia, chirurgia, chimica e botanica; rinnovò totalmente la conduzione degli ospedali di Vienna, trasformati in veri e propri centri di ricerca in cui furono create classi di medicina strutturate, dove gli studenti completavano la loro formazione al capezzale dei malati, imparavano a redigere una diagnosi motivata e assistevano alle autopsie. Tra i suoi maggiori collaboratori in campo medico, un altro olandese, Anton de Haen (1704-1776), da lui chiamato a reggere la cattedra di medicina pratica, che fu, tra l'altro, il primo a introdurre il controllo regolare della temperatura corporea e l'uso del termometro. Nel 1751, come bibliotecario imperiale, van Swieten fu nominato presidente della commissione di censura, dalla quale esautorò i gesuiti, cercando, anche se non sempre con successo, di analizzare i libri sulla base di criteri razionali, come l'utilità e la rilevanza scientifica. Nel 1752 l'Università divenne un'istituzione statale e riforme furono introdotte anche nelle facoltà di teologia, filosofia e giurisprudenza. L'imperatrice, che lo ascoltava anche in altri campi, nel 1755 gli affidò un'inchiesta su un preteso caso di vampirismo avvenuto in Moravia; van Swieten dimostrò che si trattava di una superstizione e in Abhandlung des Daseyns der Gespenster ("Discorso sull'esistenza dei fantasmi") diede una spiegazione scientifica dei vari fenomeni all'origine del mito; il risultato fu un decreto imperiale che vietava antiche pratiche macabre come esumare e trafiggere o bruciare i cadaveri dei supposti vampiri. Si dice che Bram Stoker si sia ispirato a lui per il personaggio del cacciatore di vampiri van Helsing del suo romanzo Dracula. La creazione dell'orto botanico di Vienna si inquadra nella generale azione riformatrice di van Swieten. Prima di lui all'università di Vienna non si insegnavano né la botanica né la chimica; inoltre, l'università non disponeva di edifici adeguati. Gradualmente, durante la sua gestione furono creati un anfiteatro anatomico, un laboratorio chimico, una clinica di facoltà e appunto un orto botanico, istituito nel 1754 in un'area di un ettaro sul Rennweg, adiacente al palazzo di Belvedere. Concepito come Hortus medicus, era destinato all'insegnamento della botanica applicata a medici e farmacisti e vi era annesso il laboratorio di chimica. Il progetto e la sistemazione delle piante vennero affidati al francese Robert Laugier (1722-1793), primo titolare della cattedra di chimica e botanica fin dal 1749, e poi primo direttore dell'orto botanico, che fece sistemare le aiuole didattiche secondo il sistema di classificazione di Boissier de Sauvages basato sulla forma delle foglie. Laugier diresse il giardino per una quindicina di anni, finché van Swieten, che ne aveva scarsa stima (gli rimproverava l'insufficiente conoscenza del latino e, come amico e corrispondente di Linneo, certo poco apprezzava il sistema di Sauvages), riuscì a costringerlo alle dimissioni, convincendo l'imperatrice a tagliargli lo stipendio: aveva infatti pronto per rimpiazzarlo un botanico di ben altro valore: il suo conterraneo, allievo e protetto Nikolaus Joseph von Jacquin, secondo prefetto dell'orto botanico e titolare delle cattedre di chimica e botanica dal 1768. Gli ultimi anni di van Swieten furono funestati, oltre che da un serie di malattie (nel 1772, in seguito a un tumore, subì anche l'amputazione di una gamba), dallo scontro con il figlio maggiore di Maria Teresa, divenuto imperatore come Giuseppe II nel 1765 in seguito alla morte del padre Francesco Stefano di Lorena. Egli infatti imputava al medico olandese la morte delle due mogli e delle due uniche figlie: nel 1763 la prima moglie era morta di vaiolo insieme alla secondogenita neonata, nel 1767 sempre di vaiolo era morta anche la seconda, mentre nel 1770, l'adorata figlia maggiore Maria Teresa era morta di pleurite ad appena otto anni. Quale fosse la responsabilità del vecchio medico in queste tragedie non saprei, ma certo egli inizialmente si era opposto all'inoculazione del vaiolo, una pratica ancora molto rischiosa. Il vaiolo lo era anche di più: tra le vittime di questa malattia implacabile ben cinque dei sedici figli dell'imperatrice; solo dopo la morte della sedicenne arciduchessa Maria Giuseppina, van Swieten si convinse e scrisse a William Pringle, il medico di Giorgio III, chiedendo di inviare a Vienna un medico esperto per inoculare il vaiolo all'intera famiglia imperiale. La scelta cadde su un altro olandese, Jan Ingenhousz, che aveva già inoculato con successo i famigliari di Giorgio III. Dopo aver brillantemente espletato il suo compito, rimase a Vienna come medico imperiale e qui completò i suoi studi in cui gettò le basi della comprensione del meccanismo della fotosintesi. Va dunque ascritto a merito di van Swieten aver portato a Vienna, oltre a de Haen e von Jacquin, anche questo dotatissimo connazionale. Il figlio maggiore Gottfried si illustrò in altri campi. Dapprima diplomatico, poi prefetto della biblioteca imperiale e presidente della commissione di censura dopo il padre, è celebre soprattutto per i suoi interessi musicali. Ambasciatore a Berlino negli anni '70, commissionò sei sinfonie a Carl Philipp Emanuel Bach, che gli dedicò una delle sue opere più famose, la terza raccolta delle Sonate per intenditori ed appassionati; a Berlino inoltre raccolse molti manoscritti di Bach e Händel, che poi fece regolarmente eseguire nei concerti domenicali che si tenevano nella biblioteca di corte, influenzando profondamente tanto Mozart quanto Haydn. Nel 1780, proprio nell'intento di far conoscere e diffondere la musica degli antichi maestri, fondò la Società dei cavalieri associati, per la quale tra il 1789 e il 1790 Mozart arrangiò diversi opere di Händel, tra cui il Messiah, che il salisburghese diresse più volte al clavicembalo. Alla sua morte, fu van Swieten a pagarne il funerale, quindi organizzò la prima esecuzione del Requiem, tenuta come concerto di beneficenza a favore della vedova e dei figli. Van Swieten figlio ebbe stretti rapporti anche con Haydn, per il quale scrisse i libretti della Creazione e delle Stagioni, e con il giovane Beethoven, che gli dedicò la prima sinfonia.  Il mogano, un legname troppo sfruttato Nikolaus von Jacquin non mancava mai di ricordare coloro che in un modo o in un altro lo avevano aiutato nelle sue ricerche; non poteva certo dimenticare il suo maestro, colui che gli aveva aperto la strada di Vienna e aveva gettato lo basi della sua carriera scientifica. Per onorarlo degnamente, scelse una pianta speciale: quella da cui si ricava il più ricercato e bello dei legnami, il mogano. Linneo, come i botanici dell'epoca, pensava che avesse qualche affinità con i cedri e lo collocò nel genere Cedrela come C. mahagoni. Von Jacquin lo assegnò al nuovo genere Swietenia, come S. mahagoni (1760). Questo grande albero delle Antille all'epoca era l'unica specie nota, o almeno fino all'inizio dell'Ottocento si pensava che le variazioni che si riscontravano nel legname proveniente da altre zone fossero dovute al suolo o alle condizioni di crescita, finché nel 1837, studiando esemplari raccolti durante una spedizione nella costa pacifica del Messico, Zuccarini ne identificò una seconda specie di dimensioni minori che chiamò S. humilis. Infine nel 1886, George King, il sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta, ne identificò una terza specie, proveniente dall'Honduras e appunto coltivata in quel giardino, e la denominò S. macrophylla. Sono queste le tre specie del genere (famiglia Meliaceae), abbastanza simili tra loro, ma presenti in areali diversi e solo in parte contigui: S. mahagoni è esclusivo della Florida meridionale e delle Antille (Bahamas, Cuba, Giamaica, Hispaniola); S. humilis occorre lunga la costa pacifica dal Messico all'America centrale; S. macrophylla, infine, la specie di maggiore diffusione, vive invece lungo la costa atlantica di Messico e America centrale e si spinge in Sud America fino all'Honduras, alla Bolivia e al Brasile. Sono alberi da medi a grandi (il maggiore, S. mahagoni, può superare i quaranta metri, con un tronco dal diametro di due metri), piuttosto ramificati, con foglie pinnate, da decidue a semi sempreverdi, a seconda dell'area di crescita; i fiori, raccolti in infiorescenze lasse, sono piccoli, con cinque petali ovati da bianchi a verde giallastro; i frutti invece sono grandi capsule legnose più o meno ovoidali che si aprono in cinque valve e contengono numerosissimi semi alati. Gli europei probabilmente conobbero il mogano, o almeno il suo legname, fin dal loro arrivo nelle Antille. Si dice che sia fatta di mogano una croce, datata 1512, conservata nella cattedrale di Santo Domingo, così come alcuni arredi dell'Escorial del tempo di Filippo II. Gli spagnoli però lo utilizzarono soprattutto per le costruzioni navali, e anche nei possedimenti francesi delle Antille fu scarsamente sfruttato. A lanciarne la voga furono dunque gli inglesi, soprattutto dopo il 1721, quando un decreto del Parlamento britannico eliminò i dazi per il legname importato dalle Indie britanniche. Nel corso del secolo, divenne uno dei legnami più apprezzati per ebanisteria, mobili e finiture di prestigio, tanto in Gran Bretagna quanto nelle Tredici colonie; il 90% arrivava dalla Giamaica, il resto dalle Bahamas, con piccoli contributi da altre isole, cui, dopo la temporanea occupazione di Cuba durante la guerra dei Sette anni, si aggiunse anche quest'isola. Attraverso le colonie britanniche, ci è giunto anche il nome mogano. Mentre in spagnolo l'albero - ma anche il suo legname - veniva (e viene) chiamato caoba, un nome derivato da una lingua dei Caraibi, e in francese acajou, dalla lingua tupi, nelle Antille britanniche incominciò ad essere noto come mahogany, una parola dall'etimologia discussa. La spiegazione più diffusa, ma non certo accettata da tutti, la fa risalire a m’oganwo, un nome che gli sarebbe stato dato dagli schiavi neri giamaicani per la sua somigliano con un albero africano (Khaya ivoriensis), chiamato in yoruba oganwo, ovvero "re del legno". Come che sia, il commercio del mogano americano, che nell'Ottocento si estese anche alle altre due specie, divenne così imponente da mettere a rischio la sopravvivenza di questi alberi; il mogano delle Antille era già raro all'inizio del Novecento, e un secolo dopo anche quello centro e sudamericano era avviato sulla stessa strada. Oggi tutte e tre le specie sono incluse nella lista rossa delle piante minacciate; nel 1975 Swietenia humilis è stato inclusa nell'Appendice II CITES (la lista delle piante a rischio di estinzione senza una stretta regolamentazione), seguita nel 1992 da S. mahagoni e nel 2003 da S. macrophylla. Questa è di fatto l'unica specie oggi di una qualche importanza commerciale; dopo che nel 2001 il Brasile ne ha vietato l'esportazione, il maggior produttore è divenuto il Perù, da cui proviene circa il 74% della produzione mondiale, purtroppo in gran parte tagliata illegalmente nella foresta amazzonica. La coltivazione di S. macrophylla, in seguito alle crescenti restrizioni del commercio del mogano americano, alla fine del Novecento è stato introdotta in vari paesi asiatici (India, Bangladesh, Indonesia) e nelle Fiji, ma queste piantagioni sono ancora recenti, con alberi giovani: ecco perché il commercio illegale continua. La soluzione più sostenibile è dunque non acquistare prodotti ricavati dal legname di questi alberi minacciati. D'altro canto nelle Filippine, dove sia S. mahagoni sia S. macrophylla sono state introdotte all'inizio del Novecento, sono considerate specie invasive, con un impatto negativo sul suolo e la biodiversità naturale. Dunque anche l'introduzione al di fuori della loro area d'origine non è senza rischi. Nel 1787, Ramond de Carbonnères, che all'epoca è il segretario del cardinale di Rohan, capita un po' per caso nei Pirenei. Da quel momento lo scopo della sua vita sarà scoprire i segreti della formazione geologica della catena, che all'epoca costituiva un enigma; per svelarli, ne esplora per decenni la sezione centrale, con un'ossessione: riuscire a scalare quella che al tempo se ne riteneva la massima cima, il Monte Perdido o Mont Perdu. Vero padre della scoperta scientifica dei Pirenei, Ramond era anche un appassionato botanico e uno specialista della flora di alta montagna. La dedica del bel genere Ramonda, che annovera un endemismo dei Pirenei e due specie balcaniche, è assolutamente perfetta. 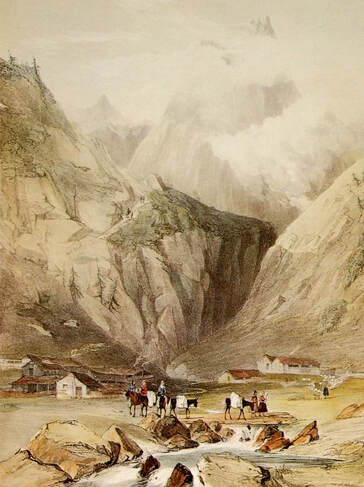 Da poeta a scienziato: un percorso di vita Nella primavera del 1787, quando per la prima volta arriva nei Pirenei, Louis Ramond (1755–1827) non sa ancora che quelle montagne diventeranno la sua passione, anzi la sua ossessione. Ha poco più di trent'anni, ma è come se avesse già vissuto almeno due vite. Nato a Strasburgo, una città-frontiera, è diviso tra due culture anche nell'identità personale, figlio com'è di un padre francese della Linguadoca e di una madre alsaziana di origine tedesca. Dunque, nulla di strano che sia tra i primi a scoprire il preromanticismo tedesco dello Sturm und Drang. Ha appena diciannove anni quando esce I dolori del giovane Werther di Goethe; la lettura di quel romanzo generazionale è una tale folgorazione che decide di diventare a sua volta scrittore e nel 1777 (ora ha ventidue anni) pubblica a sua volta Les Dernières aventures du jeune d'Olban, che, come il suo modello goethiano, si conclude con un colpo di pistola. Come Werther, anche Louis (che quell'anno si è anche laureato in legge) ha vissuto un amore impossibile, ma lascia che a suicidarsi per lui sia il suo eroe, e per consolarsi parte per la Svizzera; è alla ricerca di paesaggi che nutrano la sua ispirazione poetica e, come scrive in una lettera al padre, si mette in viaggio per "osservare e non per arrivare"; ci sono incontri con personalità importanti, come il patriarca dei naturalisti Albrecht von Haller, il biologo Charles Bonnet e il fondatore della fisiognomica Lavater, ma c'è soprattutto la scoperta delle alte montagne: scala diverse cime del Bernese, poi si sposta al San Gottardo e va all'esplorazione delle Alpi ticinesi. Poi, per tre anni, è soprattutto uno scrittore. Pubblica una raccolta di poesie, poi si trasferisce nella capitale dove dà alle stampe un dramma romantico e la traduzione di Sketches of Swisserland di William Coxe (Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse), che infarcisce di note e osservazioni tratte dal suo viaggio svizzero al punto da irritare l'autore. Il successo letterario a cui aspira non arriva: ci vorranno anni perché il gusto romantico conquisti Parigi; per i milieu letterari, Ramond è uno scrittore appena mediocre, più tedesco che francese. Ma la contestata traduzione ha un merito: attira l'attenzione del vescovo di Strasburgo, il cardinale di Rohan, che nel 1781 lo assume come segretario; per sette anni ne sarà il più ascoltato consigliere e gli sarà fedelissimo; sbriga i suoi affari, organizza le sue feste, lo accompagna in tutti i viaggi, viaggia per suo conto quando il cardinale preferisce rimanere nella prediletta residenza di campagna di Saverne, ai piedi dei Vosgi. Alla colorita corte del cardinale, conosce Cagliostro, che lo inizia alla massoneria e ne fa il suo discepolo nelle sedute di magia e ipnosi. Per adeguarsi al nuovo ambiente, cambia anche nome: ora si fa chiamare Louis Ramond de Carbonnières, pretendendo che si tratti di un vecchio nome che da tre secoli distingue un ramo della sua famiglia . Quando il cardinale viene arrestato in seguito all'affare della collana, Ramond- uno dei pochi del suo entourage rimasto a piede libero - si incarica di far sparire le lettere compromettenti; poi va in Inghilterra a cercare le prove che la collana è stata venduta dai truffatori e il cardinale è stato ingannato; anche grazie ad esse, Rohan viene assolto, ma il re lo manda in esilio all'abbazia di Chaise-Dieu in Alvernia. Ramond è con lui e approfitta di quella che per il suo padrone è una orribile seccatura per immergersi nella natura e dedicarsi alle passeggiate botaniche. Quando arriva l'inverno, il cardinale e il suo seguito sono autorizzati a trasferirsi a Marmoutier, in Touraine. Poi, gli viene permesso di viaggiare per "passare le acque"; così nella primavera del 1787, sua Eminenza lo manda in avanscoperta nei Pirenei. La scelta cade su Barèges, un villaggio a circa 1200 metri d'altitudine, annidato nelle montagne, lungo la strada che conduce al Col Tourmalet, ai piedi del Pic du Midi; all'epoca reputata per le sue acque solforose, è la stazione termale più elevata dei Pirenei. La comitiva del cardinale vi arriva alla fine di luglio, e già il 2 agosto Ramond scala per la prima volta il Pic de Midi: ai suoi occhi si mostra una gran parte dei Pirenei centrali, fino alla vetta culminante, il Monte Perdido/ Mont Perdu. Diverse escursioni seguiranno nei giorni successivi; la maggiore, dal 16 al 24 agosto, lo porta a percorrere ben 250 km e un dislivello di 13 km, da Barèges al ghiacciaio della Maladeta e ritorno. Non sono solo la passione alpinistica e il gusto romantico a spingerlo a percorrere il massiccio, solo o accompagnato da pastori locali; in gioco c'è anche una disputa scientifica. L'idea dominante all'epoca, confermata dall'ascensione al Monte Bianco di Saussure, era che le montagne più alte ed antiche fossero granitiche, mentre quelle più recenti e basse calcaree; secondo Dolomieu (un uomo che destava i sistemi) la catena centrale dei Pirenei faceva eccezione, essendo calcarea. Per verificare se abbia ragione, Ramond si propone di raggiungere il centro della catena, ovvero quel Mont Perdu che ha visto come un miraggio fin dalla sua prima ascensione. Ma come arrivarci nessuno lo sa. Così, quando, venuto l'autunno, tocca ripartire, egli si rassegna a rimandare il problema alla prossima occasione, Nel dicembre 1788, lascia il servizio del cardinale e si trasferisce a Parigi, deciso a fare della scienza la sua nuova professione. Pubblica Observations faites dans les Pyrénées, pour servir de suite à des observations sur les Alpes e segue le lezioni di Antoine Laurent de Jussieu e René Desfontaines al Jardin des Plantes. Ma a imporre una momentanea battuta d'arresto è la politica: nel settembre 1791 è eletto deputato all'Assemblea legislativa; esponente di spicco dei Foglianti, è strettamente legato a La Fayette e avverso ai giacobini. Nell'estate del 1792, mentre la situazione politica precipita, Ramond si allontana prudentemente dalla capitale e torna a Barèges. L'8 agosto è di nuovo sul Pic du Midi. Durante la Convenzione, rimane nei Pirenei, fissando la sua residenza prima a Barèges poi a Gèdre; continua ad esplorare la catena, anche se le tensioni tra Francia e Spagna ostacolano i suoi movimenti. Finché nel gennaio 1794 viene arrestato come "elemento controrivoluzionario" e condotto nel carcere di Tarbes; rimarrà agli arresti per più di sette mesi, fino a novembre, rischiando anche la condanna capitale. Se ne salva grazie ad alcuni amici, tra cui l'illustre botanico Desfontaines.  La difficile conquista del Mont Perdu Ora per Ramond de Carbonnières inizia una nuova vita, l'ennesima. Lasciatosi alle spalle l'ambizione politica, vuole essere solo scienziato. Così scrive a Philippe Picot de Lapeyrouse, colui che considera il suo maestro e la sua guida per la storia naturale dei Pirenei: "Non sono posseduto da alcuna ambizione [...]. Sono amico della natura e nient'altro. Non posso essere utile ai miei concittadini che sotto questa forma". Si stabilisce a Bagnères-de-Bigorre, ma Barèges, dove ora abita sua sorella che ha sposato il capo chirurgo del locale ospedale, continua ad essere il punto di partenza delle sue escursioni; arricchisce l'erbario, raccoglie campioni di rocce e fossili, disegna schizzi (è infatti anche un ottimo disegnatore), corrisponde con altri studiosi, tra cui Dominique Villars, grande esperto di flora alpina. Nel 1795, alla creazione della scuola centrale degli Alti-Pirenei a Tarbes, viene nominato professore di storia naturale, e si dedica al nuovo compito con grande serietà. Le sue lezioni entusiasmanti lo rendono presto popolare tra gli studenti, ai quali vuole trasmettere “non la scienza, ma il desiderio e il modo di apprendere”. Momento chiave di questo insegnamento sono le erborizzazioni e le escursioni in natura, anche di più giorni e anche in montagna. Non ha rinunciato al progetto di scalare il Mont Perdu; è convinto che l'unica via per raggiungere quella montagna proibita ("mai, da quando si dà un nome alle montagne, ce n'è stata una con un nome così appropriato") sia la valle d'Estaubé. Nell'estate del 1797 è pronto ad affrontare la sfida con due guide fidate e pochi allievi già esperti alpinisti, quando vede arrivare Picot de Lapeyrouse, che è venuto a Barèges a curarsi i reumatismi. Tra lui e Ramond c'è una disputa: entrambi concordano sulla natura calcarea della catena centrale dei Pirenei, ma mentre il primo pensa che non presenti tracce di fossili e dunque sia di orogenesi primitiva, il secondo ne dubita, convinto che l'ipotesi vada per lo meno verificata sul campo, e che la risposta la darà il Mont Perdu. Così l'11 agosto quello che parte da Barèges è un folto gruppo: Picot de Lapeyrouse, suo figlio Isidore, due allievi e il giardiniere della scuola centrale di Tolosa, due pastori che hanno già accompagnato Ramond in molte gite, Ramond stesso e quattro allievi della scuola centrale di Tarbes; uno di loro è Charles-François Brisseau de Mirbel, futuro padre della citologia vegetale. Da Gèdre il gruppo sale a Coumélie lungo un sentiero tortuoso; Ramond nota qui e là un fiore simile al colchico che annuncia già l'autunno. Lo ritiene un genere nuovo e lo battezza Merendera (oggi l'unico genere da lui creato non è accettato, ed è sinonimo di Colchicum); passano la notte in una grangia e Ramond ingaggia altre tre guide, due pastori di Coumélie e un cacciatore, che aveva fama di conoscere il Mont Perdu ("il fatto è che non ne sapeva niente più di noi"). All'alba del giorno successivo, procedendo lungo i pascoli, si dirigono verso la valle di Estaubé. In quel paesaggio imponente e severo, fioriscono in abbondanza i lunghi pennacchi di Saxifraga longifolia, di cui Lapeyrouse è stato il primo scopritore. Mano a mano che avanzano nella valle, il Mont Perdu sembra giocare a rimpiattino, sempre più nascosto da imponenti bastioni di roccia, fino a scomparire del tutto. Non si scoraggiano e continuano a salire, fino a giungere ai piedi del ghiacciaio mediano di Tuquerouye, dove incontrano un contrabbandiere che, finalmente, sembra saperne qualcosa, e consiglia loro di tornare indietro, ridiscendere e risalire da un'altra via; sono ore di marcia perdute, e Ramond propone ai suoi compagni una strada più diretta e audace: salire fino al ghiacciaio e attraversarlo. Il contrabbandiere approva, e presto si dilegua. Eccoli dunque risalire lungo la morena del ghiacciaio, fino a toccare la neve. La traversata è impegnativa, Lapeyrouse è sempre più in difficoltà, finché Ramond lo convince a fermarsi; lo lascia ad attenderli in compagnia della più fidata delle sue guide, mentre gli altri proseguono. Dopo un'ora di difficile marcia, ritrovano il contrabbandiere, caduto in un precipizio. Lo recuperano e lo uniscono a loro, anche se la disavventura nella quale ha perso, insieme alla piccozza, gran parte della sua sicurezza, semina la sconforto. Finché, superato il punto di massima inclinazione del ghiacciaio, la pendenza si addolcisce visibilmente e riprendono fiducia e slancio. Un grido di gioia annuncia il cambiamento di scena: la montagna, cinta da nubi, avvolta di ghiacci, separata da loro da abissi, si è degnata di mostrarsi, come "un Dio la cui presenza è sentita più che vista e che si manifesta in tutto ciò che lo circonda prima di rivelarsi". La cima è davanti a loro, ma è anche chiaramente irraggiungibile. Ramond e i suoi compagni decidono di esplorare il lago ghiacciato che si occupa una valletta ai piedi della montagna. Lo attraversano e sondano le rocce che lo circondano; dappertutto, trovano "vestigia di abitanti del mare. Sostanzialmente ostriche e una moltitudine di madrepore costituiscono la parte più appariscente di questi venerabili resti". Ormai è mezzogiorno, ed è tempo di ritornare. Pensare di trascorrere lì la notte, al freddo e senza viveri, per tentare la scalata il giorno dopo, sarebbe follia. Ramond, preoccupato per i suoi compagni, provati dalla salita, decide di scendere per la strada inizialmente indicata dal contrabbandiere, che nel frattempo si è ecclissato di nuovo. E' poco meno difficile e pericolosa. Ore dopo, più in basso, al Port de Pinède, ritrovano Lapeyrouse, che Ramond ha fatto avvertire del cambio di programma da una delle guide; gli mostra le sue scoperte che provano l'indubbia natura secondaria dell'asse dei Pirenei. Il vecchio scienziato è amareggiato e deluso e, anche se non cesseranno di corrispondere, continuerà a nutrire rancore verso il più giovane collega, cercando di sminuirne le scoperte. L'8 settembre, ancora con i suoi allievi e le due guide più fidate, Ramond ritorna al lago glaciale per tentare la scalata alla cima; devono di nuovo rinunciare, ma raccolgono altri fossili. Negli anni successivi, è impegnato in molte ascensioni lungo il massiccio, talvolta da solo, talvolta con Mirbel e altri allievi, o amici come Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans, professore di storia naturale alla scuola centrale di Agen. Nel 1801, racconta le sue ascensioni ed espone la sua teoria generale sulla formazione dei Pirenei in Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées, un libro di grande precisione scientifica ma anche di lettura appassionante, in cui dietro lo scienziato si avverte la mano del poeta romantico. Il Mont Perdu è ancora inviolato. Lo rimane fino al 6 agosto 1802, quando le due fidate guide di Barèges, Rondo e Laurens, inviati in avanscoperta da Ramond, riescono a raggiungere la cima. Tre giorni più tardi vi guidano Ramond, che poi racconterà l'impresa in Voyage au sommet du Mont-Perdu in uno stile che Henri Beraldi ha definito "molto veni, vidi, vici". Lo stesso anno la sua fama di scienziato è consacrata dall'ammissione all'Institut de France (la vecchia Accademia delle scienze) nella classe di scienze fisiche e matematiche.  Piante d'alta quota Dopo il colpo di stato di Napoleone, Ramond, molto stimato dal primo console, ha anche ripreso a fare politica. Dal 1800 al 1806 è deputato del corpo legislativo. Nei cinque mesi in cui avvengono le sedute, vive a Parigi; il resto dell'anno è ospite della sorella e del cognato a Barèges. Alle ricerche geologiche e botaniche, si sono aggiunti anche i rilievi barometrici, cui è stato iniziato dall'amico Bon-Joseph Dacier, conservatore della biblioteca imperiale. Nel 1806 Bonaparte lo nomina prefetto del Puy-de-Dome. Come funzionario, è serio ed efficiente come lo è stato come professore. Ma è ancora soprattutto uno scienziato, che fa rilievi barometrici dal balcone della prefettura, esplora i monti Dores, i monts Dômes e il massiccio del Sancy. Frutto di queste ricerche è Nivellement des Monts Dores et des Monts Dômes disposé par ordre de terrains (1815). Nel 1809 l'imperatore premia la sua fedeltà facendolo barone dell'Impero. Nel 1810, torna ancora una volta nei Pirenei e il 28 settembre scala per la 33 e ultima volta il Pic du Mid. La morte della sorella nel 1812, poi del cognato nel 1815, chiude definitivamente il capitolo Pirenei. Nel 1813 lascia la funzione di prefetto, e si stabilisce definitivamente a Parigi, con la giovane moglie, figlia dell'amico Dacier. Anche se durante i Cento giorni è nuovamente deputato, questo volta per il dipartimento di Puy-de-Dome, la Restaurazione lo lascia indenne, tanto che nel 1818 è nominato al Consiglio di Stato. Nell'estate nel 1821, torna in Alvernia e inizia alla geologia e alla botanica del massiccio centrale due giovani naturalisti parigini, Victor Jacquemont e Hippolte Jaubert. Ma è ancora dedicata ai Pirenei l'ultima memoria, Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi (1825). Muore a Parigi nel 1827. Anche se i suoi contributi più decisivi sono nel campo della geologia, Ramond è stato un appassionato botanico, fin dai tempi in cui ancora al servizio del cardinale di Rohan erborizzava a Saverne. Le narrazioni delle sue escursioni sono costellate di puntuali riferimenti alla flora; persino nei momenti più difficili, quando ciascuno di noi baderebbe più che altro a dove mette i piedi, non manca di osservare ed elencare le piante che si offrono al suo sguardo attento e innamorato. Il suo contributo principale alla botanica è ovviamente nello studio della flora di alta quota, là dove pochi erano andati ad erborizzare prima di lui. Gli si deve la scoperta di nove specie, sette delle quali endemiche dei Pirenei: Arenaria purpurascens, Asperula hirta (oggi Hexaphylla hirta), Festuca eskia, Leucanthemum maximum, Medicago suffruticosa, Scorzonera aristata, Pinguicola longifolia, scoperta durante una delle sue ascensioni al Mont Perdu. Le altre due sono Potentilla micrantha e Viola pirenaica, presenti rispettivamente nell'Europa centrale e meridionale e nelle montagne europee. Ad eccezione di Asperula hirta, pubblicata dallo stesso Ramond, furono tutte pubblicate da de Candolle, a cui egli aveva affidato le sue osservazioni e i fogli d'erbario. Ramond considerava il suo erbario l'oggetto più prezioso, il custode della memoria della sua vita: "Ora sono vecchio e mi riposo [...]. Diminuisco la mia biblioteca, e conservo solo ciò che è necessario per me e mio figlio, soprattutto il mio erbario, perché è la storia di mezzo secolo della mia vita. Adesso vivo con il mio erbario e i ricordi che lo accompagnano; al di fuori di questo, tutto mi è superfluo". Conservato in 68 sacchi di tela e donato dagli eredi alla Societé Ramond (creata nel 1866 per promuovere la scoperta naturalistica, storica, etnologica e sportiva dei Pirenei), dal 2003 è stato affidato al Conservatoire botanique nationale des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, che ne ha curato la pubblicazione on line a questo indirizzo.  Gioielli vegetali dai Pirenei e dai Balcani A celebrare il padre degli studi pirenaici non poteva che essere una pianta di quelle montagne. Nel 1805 Louis Claude Richard, nell'assegnare a un nuovo genere una pianta che Linneo aveva descritto come Verbascum myconi, la rinominò Ramonda pyrenaica, "così chiamata in memoria del celebre Ramond per i suoi meriti nell'osservazione delle piante pirenaiche". Qualche anno dopo Lapeyrouse nel suo Histoire Abrégée des Plantes des Pyrénées, forse memore dello sgarbo di Ramond, la ribattezzò Myconia borraginea. Troppo tardi. Il nome valido è quello di Richard, anche se ovviamente la specie ha recuperato il più antico eponimo linneano e oggi si chiama Ramonda myconi. E' una delle tre (o quattro) specie di questo genere della famiglia Gesneriaceae, diffusa soprattutto ai tropici, di cui, insieme a Haberlea e eventualmente Jancaea, è l'unico rappresentante europeo. Vestigio dell'epoca terziaria, quando il nostro continente godeva di un clima subtropicale, più caldo e umido, queste piante all'arrivo delle glaciazioni si sono rifugiate in enclave montane. R. myconi è stata a lungo l'unica specie conosciuta; è ristretta ai Prepirenei, ai Pirenei e alla catena costiera catalana, dove vive nelle gole calcaree e nelle valli umide di montagna. La sua scoperta risale addirittura al Cinquecento, quando venne raccolta nella montagna di Montserrat dal farmacista e botanico catalano Francisco Micó, che la comunicò a Jacques Dalechamps che a sua volta la pubblicò in Historia generalis plantarum sotto il nome Auricula ursi myconi. E' una piccola è graziosissima semoreverde rupicola, con foglie a rosetta e fiori viola che ricordano da vicino quelli della Saintpaulia. Verso la fine dell'Ottocento si aggiunsero altre due specie, scoperte in Serbia da Joseph Pančić, R. serbica e R. nathaliae. Entrambe vivono in habitat calcarei, ma hanno distribuzione diversa. R. serbica, scoperta da Pančić nel 1874 sul monte Rtanj, appartiene al bacino idrografico adriatico ed ha areale più ampio (Serbia, Albania; Montenegro, Macedonia, Grecia settentrionale, tra 200 e 1950 metri sul livello del mare); R. nathaliae, scoperta nel 1884 nella gola di Jelašnica presso Niš dallo stesso Pančić e dal medico di corte Sava Petrović, che la dedicarono alla regina di Serbia Natalija Obrenović, è ristretta alla Macedonia e ad aree adiacenti di Grecia, Serbia e Kosovo ed appartiene al bacino idrografico egeo. Le due specie sono molto simili, ma R. serbica ha foglie più romboidali con margini vistiosamente dentati o incisi, fiori più piccoli e meno numerosi portati su lunghi scapi, R. nathaliae foglie più arrotondate, fiori più grandi e scapi più brevi. Nel 1928 il botanico russo Pavel Černjavskij stava riordinando il suo erbario quando casualmente vi rovesciò sopra un bicchiere d'acqua; per rimediare al disastro, lasciò asciugare le carte e le piante per tutta la notte; al mattino dopo, scoprì che un esemplare di R. nataliae, che faceva parte della sua collezione da un anno e mezzo ed era totalmente disseccato, si era reidratato ed appariva vivo e vegeto. Pubblicò subito la scoperta sulla rivista della società botanica russa, con una conseguenza politica; da allora R. nataliae è stata scelta come simbolo della "resurrezione" della Serbia e del suo esercito dopo la Prima guerra mondiale. La rara particolarità di potersi disseccare completamente e di riprendersi alla prima pioggia, diffusa tra licheni, epatiche e muschi, ma rarissima tra le Angiosperme, è condivisa da tutte le specie del genere, anzi da tutte le Gesneriaceae europee; hanno sviluppato questa capacità per poter sopravvivere, nonostante la loro origine tropicale, in aree montane con estati secche e temperature invernali che scendono di molto sotto zero. Nel 1851, Theodor von Heldreich, all'epoca direttore dell'orto botanico di Atene, scoprì sulle pendici del monte Olimpo un'altra gesneriacea, di cui però non vide i fiori. Inizialmente Boissier la classificò come Haberlea heldreichii, poi, dopo la raccolta di esemplari fioriti, la trasferì a un genere proprio, Jancaea, in onore di Viktor Janka, curatore dell'erbario di Budapest ed esploratore della flora dei Balcani. Non tutti erano d'accordo: Alphonse e Casimir de Candolle la collocarono nel genere Ramonda, come R. heldreichii. Recentemente, l'appartenenza a Ramonda è stata supportata da dati molecolari; Plant of the World on line ne prende atto, riducendo Jancaea a sinonimo. Ma poiché la maggioranza dei repertori, inclusi il sito della Gesneriad Society e Flora of Greece on line, lo trattano ancora come genere a sé, così farò anch'io, soprattutto per poter dedicare un post a Janka. Per Robert Brown, Anton Pantaleon Howe (lui però lo scriveva Hove) era un "ben noto viaggiatore botanico". Per noi invece questo polacco capitato non sappiamo come né perché in Inghilterra è un illustre sconosciuto. Ha lasciato qualche traccia di sé quasi unicamente nella corrispondenza di Joseph Banks, grazie alla quale ne seguiamo le avventure in mezzo mondo, dalla Namibia all'India e poi dalla Polonia alla Crimea, scoprendo che forse dietro la facciata di botanico si nascondeva un'attività meno alla luce del sole. Gli mancava l'Australia, ma ci ha pensato appunto Brown, dedicandogli il genere australiano Hovea (Fabaceae). 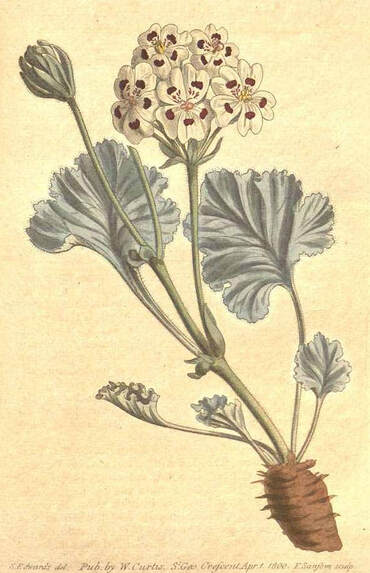 Un misterioso giramondo Tra i tanti cacciatori di piante inviati in giro per il mondo da sir Joseph Banks per arricchire il giardino reale di Kew, uno dei più oscuri e misteriosi è Anton Pantaleon Howe. Tanto misterioso che non ne conosciamo con precisione neppure il cognome, scritto anche Hove o Hoveau, che è la trascrizione inglese di un cognome ignoto che a orecchie britanniche suonava più o meno come Au. Il personaggio salta fuori dal nulla nel settembre 1785. Dopo la perdita delle colonie americane, la corona britannica cercava nuove colonie penali dove deportare i condannati. Oltre a Botany Bay in Australia, fu presa in considerazione anche la baia di Lüderitz, all'epoca nota con il nome portoghese Angra das Voltas, lungo la costa dell'attuale Namibia; se si fosse rivelata adatta, avrebbe offerto alle navi inglesi dirette in India e in Cina uno scalo alternativo all'isola di Sant'Elena e al Capo di Buona speranza, all'epoca ancora saldamente sotto il controllo della Compagnia olandese delle Indie orientali (VOC). Del progetto venne ovviamente informato Banks, il più ascoltato consulente dell'ammiragliato, che ottenne che alla missione partecipasse uno dei suoi raccoglitori; il candidato ideale doveva essere un esperto giardiniere con qualche conoscenza di botanica, dotato di buone capacità di osservazione. Probabilmente su suggerimento di William Aiton la scelta cadde appunto su Howe, di cui, in una lettera a Banks del 10 settembre 1785, il segretario della Royal Society Charles Blagden esalta anche il carattere allegro e le conoscenze mediche. Da una lettera di parecchi anni dopo dello stesso Banks, scopriamo che era polacco, forse di Varsavia, ma non sappiamo nulla dei suoi studi e della sua vita prima dell'arrivo in Inghilterra, di cui ignoriamo la data. Poiché in Namibia assunse anche il ruolo di chirurgo di bordo, possiamo supporre che avesse studiato medicina, pur senza laurearsi, in Polonia o altrove. Risulta invece che fosse stato assunto a Kew come giardiniere dietro raccomandazione di John Graeffer, il grande giardiniere che più tardi avrebbe realizzato il giardino inglese della Reggia di Caserta. Dato che Graeffer era tedesco, potrebbe aver conosciuto Howe all'estero; oppure il polacco potrebbe aver lavorato in precedenza per il vivaio di Gordon, di cui Graeffer era uno dei soci. Poiché l'area di Angra das Voltas si trovava a cavallo tra la zone d'influenza portoghese in Angola e olandese in Sudafrica, l'ammiragliato si mosse con la massima cautela e segretezza, sollevando anche qualche perplessità sull'ingaggio di uno straniero. Alla fine si convinse; così, a bordo della Grampus, la nave ammiraglia della piccola flotta guidata dal commodoro Edward Thompson, c'era anche Anton Howe come botanico, accanto al cartografo, il luogotenente Home Riggs Popham, e al nipote e figlio adottivo del comandante, il luogotenente Thomas Bolden Thompson. Della ricognizione vera e propria si sarebbe occupato l'agile sloop Nautilus, comandato dal capitano George Tripp. Per mascherare la vera meta, le provviste aggiuntive furono caricate sul Grampus, e la piccola flotta, salpata a settembre, si diresse nell'attuale Ghana, con l'obiettivo apparente di ispezionare le stazioni commerciali britanniche della costa occidentale dell'Africa. Tuttavia ad Apollonia il commodoro morì di febbri nel gennaio 1786: come ufficiale più anziano, Tripp assunse il comando del Grampus e ad aprile lo riportò in Inghilterra; nel frattempo le provviste erano state trasbordate sul Nautilus, che salpò in direzione sud al comando di Thomas Bolden Thompson, alla ricerca di Angra das Vueltas sulla base di imprecise carte portoghesi e di vaghe informazioni raccolte da navigatori inglesi e esploratori olandesi, che presentavano quell'area come fertilissima e ricca di potenzialità. A bordo c'erano anche Popham e Howe, nelle vesti di botanico e chirurgo di bordo. Non c'è da stupirsi se la missione fu un totale fallimento. Invece della terra fertile dal clima mite che si attendevano, gli inglesi si trovarono in un deserto "inospitale e nudo, che non ha eguali tranne nell'Arabia deserta", secondo le parole di Bolden Thompson. Non gli riuscì di trovare né Angra das Vueltas, né la foce del grande fiume indicato nelle carte, né fonti d'acqua. Al suo rientro in Inghilterra a luglio, la sua relazione non poteva che essere negativa. L'unico contento del viaggio probabilmente fu proprio Howe, che in quelle plaghe desertiche poté trovare piante ignote, raccogliendo semi, molte bulbose e 17 specie di Pelargonium, tra cui P. crassicaule, P. cortusifolium e P. ceratophyllum. Avendo dato ottima prova di sé, dimostrando "buon senso e carattere audace", come scrisse Banks, poco dopo il rientro in Inghilterra gli fu affidata una missione più delicata, a metà tra la botanica e lo spionaggio industriale: fu infatti inviato in India a studiare i metodi di coltivazione e a procurarsi semi del migliore cotone in commercio, quello di Surat nel Gujarat. A organizzare il viaggio fu l'Ufficio del commercio, su pressione dei produttori di tessuti di cotone di Manchester, che erano costretti ad importare parte della materia prima dall'estero; incrementare la quantità e la qualità del cotone coltivato nelle Antille britanniche era infatti strategico per l'industria britannica della nascente rivoluzione industriale. Howe partì per l'India nell'aprile del 1787 e, dopo uno scalo a Ceylon, dove fu derubato di raccolte e attrezzature, si trattenne nel subcontinente per circa due anni. Esplorò con molta cura l'area costiera tra Bombay e il Gujarat, raccogliendo piante (tra le altre Crotalaria juncea, una pianta da fibra citata in antichi testi sacri, e il mangostano, cui gli si attribuisce l'introduzione in Inghilterra); era un'ottima copertura per il vero scopo del viaggio, che tuttavia trapelò. Nelle sue lettere a Banks riferisce dei mille ostacoli che i funzionari della Compagnia delle Indie (che non gradiva la concorrenza del cotone delle Antille) cercarono di contrapporgli. Nonostante fosse riuscito a procurarsi semi di buona qualità, le sue richieste di denaro e le spese considerate eccessive finirono per seccare Banks e l'Ufficio del Commercio, che ordinarono a Howe di rientrare anzitempo. Imbarcatosi su una nave danese nel febbraio 1789, rientrò in Inghilterra ad agosto, dopo uno scalo a Città del Capo, nel corso del quale incontrò Francis Masson. Da questo momento le notizie che possediamo su Howe si fanno sporadiche. A un certo punto dovette lasciare la Gran Bretagna per la Germania, dove lavorò come medico, poi passò in Polonia dove fece raccolte di piante e cercò di creare un "istituto botanico". In una lettera a Banks inviata da San Pietroburgo il 20 settembre 1795, egli riferisce che aveva dovuto lasciare la Polonia e rifugiarsi in Russia in seguito all'insurrezione di Kościuszko (marzo-novembre 1794), durante la quale le sue collezioni erano andate distrutte; avendo incontrato lo zar l'anno prima e avendo relazioni con funzionari russi, era infatti considerato filorusso. E' stato ipotizzato, ma senza prove, che in questi anni avesse continuato a lavorato come agente dell'intelligence britannico. Il 15 agosto 1796, da Odessa, Howe scrisse la sua ultima a lettera a Banks: conteneva semi e una lunga descrizione dell'azalea pontica Rhododendron ponticum; da un frammento di diario pubblicato sul Botanical Magazione di Curtis nel 1799 (il resto è purtroppo perduto) possiamo ricavare qualche notizia sui suoi movimenti in questa fase: a giugno trovò esemplari di questa specie sulle rive del Dnestr nella tenuta del conte Potocki a Mohilow (attualmente Mohyliv-Podilskyi in Ucraina); il 4 luglio ne vide migliaia in una palude presso Očakiv; il 15 luglio ne trovò una valle interamente ricoperta a Trebisonda. Poi, per quasi vent'anni, nessuna notizia, fino al 1812, quando in una lettera a Knight, Banks ricorda che Howe portò l'azalea gialla dalla Crimea e sottolinea ancora una volta che era di origine polacca ed era un buon giardiniere che aveva lavorato per molti anni per i Kew Gardens. Forse all'epoca era tornato in Inghilterra, ma certo vi morì, come scopriamo da un annuncio fatto pubblicare dai suoi esecutori testamentari sulla Gazeta Krakowska il 25 novembre 1837: in seguito alla morte di Anton Pantaleon Howe a Bath nel gennaio 1830 e all'incapacità della vedova Joanna Howe per "sonnambulismo", si sollecitano potenziali eredi a comparire davanti a un tribunale londinese pena l'esclusione dall'eredità. Quattro anni dopo, anche Joanna (o Jane), morì a Kensington, all'età di 86 anni, come ci informa la sezione necrologi di The Gentleman's Magazine dell'ottobre 1841.  Australiane dai fiori blu Nel 1812, nel quarto volume della seconda edizione di Hortus Kewensis, Robert Brown dedicò a Howe uno dei suoi generi australiani, Hovea (Fabaceae), senza alcuna motivazione esplicita. Le fornisce invece pubblicando Hovea latifolia nel primo volume di The Botanical Cabinet di Loddiges (1817): "Il genere a cui appartiene questa pianta ha ricevuto il suo nome in onore di Mr. A. P. Hove, il ben noto viaggiatore botanico polacco. Grazie a lui sono state introdotte molte belle piante, e speriamo che egli voglia accrescerne il numero". Probabilmente Brown non lo conosceva di persona, ma gli erano note le piante da lui introdotte a Kew; è forse troppo dedurne che all'epoca Hove non fosse ancora tornato in Inghilterra e magari fosse impegnato in qualcuno dei suoi misteriosi viaggi. Nessun mistero sullo bellezza di Hovea, uno dei numerosi generi di leguminose endemici dell'Australia; comprende circa quaranta specie di suffrutici, arbusti ma anche piccoli alberi, distribute in tutti fli stati del paese, con vistosi fiori papilionacei viola, malva, blu, più raramente bianchi. Tra le specie più coltivate nei giardini australiani, e talvolta anche altrove, vale la pena di segnalare Hovea acutifolia, originaria dei margini delle foreste umide del Queensand e del Nuovo Galles del Sud; di veloce crescita, in primavera si ricopre di una massa di piccoli fiora da blu a viola-malva. Molto attraente anche H. trisperma, che cresce invece nelle boscaglie sabbiose dei dintorni di Perth e nei distretti di Darling e Stirling; è un arbusto dal portamento aperto che dall'inverno all'inizio della primavera produce lunghe cime terminali di fiori in varie sfumature di colore, che vanno dal blu scuro al lilla pallido al bianco. Ugualmente originaria delle aree semi aride dell'Australia occidentale è H. elliptica, un arbusto eretto con foglie ellittiche alternate e brevi cime di fiori viola all'ascella fogliare. Ci riporta invece nell'Australia orientale (e in Tasmania) H. heterophylla, un piccolo arbusto eretto o prostrato, che deve il suo nome alle varie forme delle sue foglie: da arrotondate a ellittiche alla base, da lineari a lanceolate in alto. I fiori malva hanno vessillo striato di giallo e carene viola scuro. Per un finire, anche se il nome del dedicatario è stato scritto indifferentemente Hove o Howe, fate attenzione a non confondere i generi Hovea e Howea, ovvero la cosiddetta kentia o kenzia, una palma! Dopo la tulipomania, che nel Seicento bruciò tanti capitali, nel Settecento infuriò la giacintomania. Tra le sue vittime, sir James Justice, un legale scozzese che dilapidò tutta la sua fortuna per coltivare piante rare, tra cui appunto i preziosi giacinti doppi che acquistava a caro prezzo in Olanda. Grande sperimentatore di tecniche di coltivazione, fu probabilmente il primo a far fruttificare gli ananas in Scozia, creando per loro una serra riscaldata all'avanguardia. Un successo che gli guadagnò la quasi immediata ammissione alla Royal Society. Nell'arco di pochi anni, alle prese con debiti sempre più enormi, fu costretto a vendere la tenuta di Crichton dove aveva creato il più raffinato giardino di Scozia. Seguirono processi, un divorzio, l'ignominia del carcere per debiti, l'espulsione dalla Royal Society per morosità. Alla sua morte, alla vedova e al figlio bambino rimase un capitale di 60 sterline, ovvero il prezzo a cui veniva venduto al momento della sua apparizione il giacinto 'Gloria florum suprema'. A ricordare Justice rimangono il notevole The Scots Gardiners Director, ma soprattutto il genere Justicia, oggi il più vasto della famiglia Acanthaceae.  Giacinti e giacintomania Il 22 ottobre 1730 la Royal Society ammise un nuovo membro, presentato dal presidente in persona sir Hans Sloane, dal capo giardiniere di Chelsea Philip Miller e da John Martyn, che due anni dopo sarebbe stato nominato professore di botanica a Cambridge. Il nuovo socio era un legale scozzese, sir James Justice (1698-1763), alto funzionario della corte di Edimburgo (Principal Clerk to the Court of Sessions), ma soprattutto appassionato giardiniere. Ad attirare l'attenzione di sponsor tanto prestigiosi erano stati i suoi esperimenti orticoli. Sfidando il rigido clima scozzese, nella sua tenuta di Crichton, a circa 20 km a sud di Edimburgo, egli si era fatto costruire una serra riscaldata all'avanguardia (tra l'altro, una delle poche all'epoca ad avere anche il tetto vetrato) dove era riuscito a fare fruttificare gli ananas. Vi coltivava anche banani, guaiave, piante del cacao e del caffè; era riuscito a far fruttificare anche queste ultime, che avevano dato semi fertili da cui erano nate pianticelle. Fu il momento di massima gloria di Justice, che per tutta la vita (anche quando, come vedremo, non ne aveva più diritto) fece sempre orgogliosamente seguire al suo nome la sigla FRS, Fellow of Royal Society. All'epoca aveva poco più di trent'anni e aveva cominciato i suoi esperimenti orticoli forse intorno al 1727. Apparteneva a una facoltosa famiglia di mercanti e legali scozzesi, la cui parabola - tanto per rimanere nei cliché - ricorda quella dei Buddenbrook. All'inizio, ovviamente, c'è un fondatore, in questo caso il mercante James Justice (morto nel 1711) che fu bailie (magistrato municipale) e prevosto di Edimburgo e acquistò la proprietà di Crichton. Il rappresentante della seconda generazione, anche lui James, entrò a fare parte della nobiltà di toga, aggiungendo un titolo baronale alla tenuta e divenendo Principal Clerk to the Court of Sessions, incarico che mantenne fino al 1727, quando vendette la carica e la riacquistò per il figlio; la terza generazione è appunto quella di James il botanico. Infine la dinastia si chiude con il quarto James, l'unico figlio sopravvissuto, militare noto come "Captain Justice", eccentrico quanto il padre (anche se la sua passione andava più alle fanciulle che ai fiori). La passione del padre James III per l'orticultura era nata in Olanda, dove era stato inviato a laurearsi in giurisprudenza, secondo una consuetudine abituale nella Scozia del tempo. Mentre non provava alcun interesse per la carriera legale, si innamorò dell'orticoltura e del vivaismo olandesi. Per impadronirsi delle tecniche di coltivazione più aggiornate, oltre a frequentare assiduamente i vivai di Haarlem, in un lungo grand tour orticolo dovette visitare anche la Francia ( dove si interessò soprattutto della coltivazione a spalliera di peschi e altri alberi da frutto) e l'Italia. Non conosciamo le date di questo viaggio, che probabilmente si protrasse per diversi anni. Al suo rientro in Scozia, Justice era un raffinato gentiluomo per padroneggiava l'inglese senza "scotismi", il latino, l'olandese e il francese, conosceva bene la letteratura botanica del tempo e le nuove tecniche orticole messe a punto nel continente. Era ansioso di sperimentarle per "migliorare" la tenuta di Crichton. Come il padre era infatti membro della Honourable Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture in Scotland, che si proponeva di migliorare l'orticoltura scozzese introducendo tecniche che aumentassero le rese. Certamente piantò alberi e introdusse migliorie nella gestione della tenuta, ma soprattutto si concentrò sulla coltivazione delle esotiche, facendo costruire per loro una serra all'epoca quasi avveniristica. Il suo interesse principale dovette però transitare ben presto alle piante da fiore, in particolare le bulbose. Nel 1730 infatti lo troviamo a Bruxelles, per studiare le tecniche di coltivazione di François Beaulinx, specialista nella produzione di tulipani Bizard da seme. Altri contatti nelle Fiandre e in Olanda erano Jan van Leuwen di Rotterdam, famoso per i suoi Iris persica azzurri, e soprattutto i vivai van Zompel e Voorhelm di Haarlem. Questi ultimi furono all'origine della giacintomania che infuriò in Olanda nella prima metà del Settecento. I giacinti Hyacinthus orientalis all'epoca erano abbastanza diversi da quelli che coltiviamo oggi. Quelli a fiore singolo avevano pannocchie piuttosto rade, con fiori piccoli, ancora simili alle forme selvatiche; occasionalmente nascevano piante a fiore doppio, che inizialmente non suscitarono alcun interesse, anzi i vivaisti si affrettavano a scartarle perché sterili. Nel 1684 il vivaista di Haarlem Peter Voorhelm cadde ammalato, lasciando il vivaio per qualche tempo abbandonato a se stesso; quando poté occuparsi della cernita dei giacinti, ne trovò uno doppio particolarmente bello; scoprì anche che ai suoi clienti piaceva ed erano disposti a pagarlo di più degli altri. Continuò a coltivarlo e a sviluppare nuove varietà. La prima ad aver successo e a scatenare la giacintomania fu 'Koning for Groot Brittanien' (così chiamata in onore di Guglielmo d'Orange, re d'Inghilterra come Guglielmo III), con fiori bianchi e cuore rosa intenso, una robusta varietà ancora segnalata da Loudon all'inizio dell'Ottocento. Al suo apparire, nel 1702, un singolo bulbo costava l'equivalente di 100 sterline. I prezzi erano così alti perché i giacinti doppi erano rari, ci volevano cinque anni per portarli a fioritura, e con il loro insieme di colori eccitavano il gusto del bizzarro, proprio come i tulipani variegati all'origine della tulipomania. La giacintomania raggiunse il suo apice negli anni '20-'30 del 1700, ovvero esattamente nel periodo in cui Justice frequentò l'Olanda prima come studente poi come acquirente di bulbi. I Voorhelm continuavano ad essere il vivaio leader di questa produzione, ma ora erano affiancati da molti altri produttori che ogni anno immettevano sul mercato centinaia di varietà. Tuttavia, avevano imparato la lezione dal crollo della bolla dei tulipani, e nei loro cataloghi offrivano un'ampia gamma di giacinti dai prezzi diversificati, riuscendo a mantenere alti quelli delle novità più pregiate. Così due produzioni dei Voorhelm (molto ammirate da Justice) 'Gloria Mundi', azzurro chiaro con cuore blu scuro, e 'Gloria Florum suprema', bianco neve con cuore scarlatto, al loro apparire furono venduti rispettivamente a 500 e 600 fiorini a bulbo, cioè 50 e 60 sterline. I prezzi raggiunsero il picco tra il 1733 e il 1736, per poi crollare quasi all'improvviso: il mercato ormai era saturo, le varietà veramente di valore erano introvabili, e per vendere i vivaisti furono costretti a tagliare i prezzi. Nei cataloghi del 1738 vediamo 'Staaten General' passare da 210 a 20 fiorini e 'Gekroont Salomon’s Jewel' da 80 a 3. 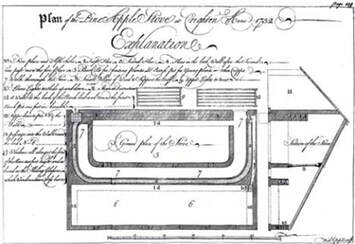 Rovinarsi per le piante In Olanda Justice si era innamorato dei giacinti e non se li fece mancare nel giardino di Crichton, in stile francese, considerato il più bello e raffinato della Scozia. Quanto avesse pagato i suoi giacinti e le innumerevoli altre bulbose che li affiancavano non sappiamo. Ma certo fu vittima, se non della sola giacintomania, della sua irresistibile passione per il giardinaggio. Non badava a spese per far venire bulbi dall'Olanda e per acquistare piante e semi tanto a Londra quanto in Scozia. I guai arrivarono presto; i debiti erano tanti che, per salvare il salvabile, il padre James II predispose un atto di successione a favore del nipote anziché del figlio e si risolse a vendere la tenuta. Nel 1738, poco più di un anno dopo la sua morte, la vendita fu infine conclusa dal nostro James III, con un ricavo di 7000 sterline. Egli tentò anche di impugnare l'atto paterno, ma vi rinunciò, vedendo che era insufficiente a tacitare i creditori. Pagati almeno una parte dei debiti, investì quanto gli rimaneva in una tenuta di minore estensione chiamata Ugston nella parrocchia di Channelkirk (Berwikshire) che da quel momento fu ribattezzata Justicehall. Anche qui piantò alberi e coltivò bulbose, tanto che uno studioso di storia locale ha raccolto la voce che facesse addirittura arrivare la terra dall'Olanda per offrire agli amati bulbi la terra natìa; la notizia è improbabile (come vedremo, tra i più importanti esperimenti di Justice vi era la produzione di terricci su misura per le varie coltivazioni), ma ci dice molto sulla fama di eccentricità del personaggio. A rovinare del tutto la sua reputazione, ai debiti si aggiunse lo scandalo: iniziò una relazione con una giovane domestica e la moglie chiese il divorzio. Ne seguì un'intricata vicenda processuale in cui Justice arrivò ad accusare un ex amico di aver tentato di assassinarlo. Erano condotte che la puritana società scozzese non era disposta a tollerare; così, nell'ottobre 1744 Justice se ne andò in volontario esilio nell'Inghilterra settentrionale, con il risultato di contrarre altri debiti. Tornato in Scozia nel novembre 1746, prese in affitto una casa con giardino ad Edimburgo; era sempre più perseguitato dai creditori (in una lettera li chiama "diavoli") e nel 1748 subì anche una breve incarcerazione per debiti, da cui fu liberato grazie alla malleveria di lord Milton, alto magistrato e suo lontano cugino; con il suo aiuto, cercò inutilmente di liberarsi dell'odiato lavoro in tribunale. Nel 1750 si sposò con la ragazza dello scandalo, che però presto si ammalò e dopo appena due anni lo lasciò vedovo. Seguì un terzo matrimonio, e nel 1755, ormai quasi sessantenne, gli nacque l'unico figlio superstite (il maggiore era morto nel 1750). Nel 1757, non avendo pagato da anni la quota associativa, subì lo smacco di essere espulso dalla Royal Society. Nel 1758 si trasferì nella sua ultima casa, nel distretto di Leigh, dove sarebbe morto nel 1763. Anche qui c'era un giardino, che riempì di fiori, tra cui una spettacolare collezione di auricola; erano piante di grande valore, su cui contava per garantire un gruzzoletto alla moglie e al figlioletto dopo la sua morte. Invece quando la vedova le mise in vendita, ne ricavò solo 20 sterline, un terzo dell'eredità che le rimaneva.  Una guida per i giardinieri scozzesi Nel 1754, a suo dire cedendo alle pressioni di amici ed estimatori, Justice si risolse a mettere per iscritto quanto aveva appreso dalle sue esperienze trentennali in ogni campo dell'orticoltura, trasfondendole in una guida all'orto famigliare e al giardino, The Scots Gardiners Director. Anche se l'identità dell'autore era un segreto di Pulcinella, inizialmente la pubblicò anonima (era pur sempre un rispettabile funzionario); il nome compare nell'edizione del 1759, intitolata The British Gardener's New Director; nell'edizione riveduta del 1764 (uscita postuma) tutte le remore sono cadute: sir James arriva a reclamizzare e porre in vendita alcune delle sue produzioni. Il libro è interessante da diversi punti di vista. Era una delle prime pubblicazioni del genere in Scozia (grazie ad essa, Justice è stato definito il padre dell'orticultura scozzese) ed ebbe un notevole successo, venendo ristampato anche in Irlanda. Era anzi la prima ad essere concepito appositamente per il clima e i terreni della Scozia, tanto diversi da quelli della più temperata e fertile Inghilterra. Soprattutto, non aveva nulla di libresco e si basava su esperienze di prima mano, esposte dall'autore in modo dettagliato e potremmo dire generoso. Così, le pagine di The Scots Gardiners Director sono per noi una specie di macchina del tempo per conoscere le pratiche orticole del Settecento, i successi e i fallimenti di sir James e il mondo del vivaismo olandese (egli vi riportò interi cataloghi delle loro produzioni, in particolare quelle dell'amico Joris Voorhelm, autore a sua volta di uno dei primi trattati sui giacinti). Il volume è diviso i due parti. La prima è dedicata all'orto famigliare; è un orto-frutteto, un walled garden recintato da muri che lo proteggono dal rigido clima settentrionale. Justice fornisce dettagliate istruzioni sull'esposizione ideale, sulla scelta dei fruttiferi più adatti, sulla coltivazione a spalliera e la potatura; spiega come allestire lettorini caldi (incluso uno per i funghi) e muri riscaldati dotati di intercapedini dove far passare aria calda per far maturare l'uva e altri frutti che non riuscirebbero a farlo nel clima scozzese. Non dimentico del suo primo successo, non trascura la coltivazione degli ananas e offre ai lettori due progetti di serre calde. La prima parte si conclude con la rassegna delle orticole e delle erbe aromatiche. La seconda parte (è una novità non trascurabile) è interamente dedicata alla coltivazione dei fiori; si intitola etimologicamente Anthologia, selezione di fiori, e occupa un po' di più della metà del volume. Mentre le piante da aiuola, ad eccezione di poche specie, sono trattate spesso sommariamente, a fare la parte del leone sono le bulbose, che Justice espone seguendo il ritmo delle stagioni, iniziando con l'aconito d'inverno, ovvero Eranthis hyemalis, e i bucaneve, per terminare con i colchici autunnali. E così, con dovizia di indicazioni sulle varietà, la coltivazione, la semina, la preparazione dei terreni, ecco sfilare le epatiche, a proposito delle quali Justice confessa un insuccesso: ripetendo le semine per molti anni, è riuscito a ottenere diversi colori e forme semidoppie, ma mai le varietà doppie disponibili in Olanda; gli economici crochi che l'amico Voorhelm (ne propone 12 varietà) vende a 1 fiorino per 100 bulbi; gli aristocratici iris persiani, che si acquistano a Rotterdam ed è impossibile riprodurre da seme, ma possono essere forzati in vaso per ornarne la casa all'inizio della primavera; i narcisi, di cui ci sono innumerevoli varietà e tipi, da piantare in massa 100 alla volta; i ciclamini rustici; il colchico di Spagna, ovvero Bulbocodium vernum; il dente di cane Erythronium dens-canis. Su Fritillaria meleagris si dilunga per illustrare le tecniche di semina che gli hanno permesso di ottenere sette varietà del tutto nuove entrate a far parte del catalogo Voorhelm; segue la corona imperiale F. imperialis, gloria dei vivai olandesi che la chiamano William Rex e ne offrono almeno quindici varietà. Tra le rarità dei loro cataloghi c'è anche quello che chiamano Lilium persicum, in cui riconosciamo F. persica. A questo punto entrano in scena i giacinti "una delle principali bellezze della primavera". Justice - dichiara subito che sono la sua pianta preferita - dedica loro moltissime pagine, con dettagliate istruzioni su come trattare i bulbi giunti dall'Olanda, su come allestire una root-room per conservarli e moltiplicare i bulbi, sulle semine e sul terriccio ideale, che egli prepara secondo una ricetta di sua elaborazione che comprende sabbia, letame maturo e compost di foglie. Ne aveva già parlato nel suo primo scritto noto, Directions for propagating Hyacinths, pubblicato nel 1743 nelle Transactions della Hourable Society of Improvers. Per i giacinti Justice ha speso capitali, ma anche ottenuto grandi successi; mentre i suoi conterranei, sono costretti a sostituire continuamente i bulbi, lui grazie al suo terriccio e alle perfette tecniche di coltivazione riesce a mantenere i fiori grandi come il primo anno; non parliamo poi delle semine, che gli hanno permesso di ottenere novità di pregio. Nel 1764 Voorhelm gliene dedicherà una commemorativa, 'Mijnherr Justice', un bianco singolo con tocchi di rosa. Justice spiega anche come forzare i bulbi in caraffe di vetro, una tecnica messa a punto pochi anni prima in Svezia e introdotta nel Regno unito dal corrispondente Philip Miller. Per pagine e pagine, egli si profonde quindi nella descrizione di dozzine di varietà; quelle a fiore singolo (10 bianchi, 10 rosa, 16 blu scuro e 20 azzurro chiaro) ammette di averle coltivate tutte; ovviamente va pazzo (e sappiamo fino a che punto) per quelle a fiore doppio, ma forse neppure lui avrà sperimentato tutte le 86 varietà offerte nel 1752 da Voorhlem e van Zompel, che però descrive puntigliosamente, certo in più di un caso per conoscenza diretta. Tra di esse le costosissime 'Gloria mundi' e 'Gloria florum suprema. Ma a suo parere "i più belli dei doppi per il loro colore ammirevole" sono i rossi, di cui menziona 9 varietà. Dopo i giacinti, tocca ai tulipani. Forse sono stati una passione giovanile, e non li trascura, ma è chiaro che il suo cuore va ai giacinti, tanto che non hai mai provato a riprodurli per seme. A paragone, dedica più spazio ai ranuncoli, di cui invece ha praticato la semina su larga scala, ottenendo parecchie pregevoli varietà. Lasciate le bulbose, come si è detto la trattazione si fa più scarna, con qualche eccezione, come le primule orecchie d'orso (Primula auricola); negli ultimi anni della sua vita, quando non disponeva più dei larghi spazi delle tenute di campagna, ma solo di un piccolo giardino urbano, hanno sostituito nel suo cuore i giacinti e per ospitarle degnamente ha persino inventato un apposito scaffale con ripiani doppi. Un'altra eccezione è l'astro della Cina Callistephus chinensis; si trattava in effetti di una new entry nei giardini europei. I primi semi erano approdati dalla Cina al Jardin des plantes di Parigi intorno al 1730 (se ne attribuisce erroneamente l'invio a padre Incarville, che però all'epoca viveva in Canada); qui se li era procurati Philip Miller che aveva incominciato subito a seminarli e a sperimentare la creazione di diverse varietà, ottenendo dopo molti anni le prime doppie. Probabilmente Justice ottenne i semi da lui e ne sperimentò la semina ripetuta, separando i semi delle piante più promettenti, fino a riuscire a produrre addirittura una forma doppia bicolore, che secondo la sua biografa Priscilla Minay rivaleggia con le migliori varietà moderne.  Un grande genere pantropicale Anche se ci è rimasta solo una delle lettere di Justice a Miller, scritta poco dopo l'amissione alla Royal Society, è probabile che i due abbiano corrisposto per molti anni; erano uniti dalle origini scozzesi e da un approccio molto simile all'orticoltura, fatto di prove ed esperimenti ripetuti con tenacia e caparbietà. Forse un conoscente comune era un terzo scozzese, il chirurgo William Houstoun; in un passo di The Scots Gardiners Director Justice mostra di conoscere le sue ricerche su Mirabilis jalapa, mentre Houstoun lo stimava abbastanza da dedicargli uno dei suoi generi di piante americane. Fatto proprio e validato da Linneo, Justicia è oggi il più vasto genere della famiglia Acanthaceae. Distribuito nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo, comprende al momento attuale oltre 900 specie di erbacee perenni, arbusti e suffrutici di morfologia piuttosto variabile; tra i tratti comuni, foglie con nervature molto evidenti e fiori tubolari caratterizzati da una corolla bilabiata con labbro superiore bilobato e labbro inferiore trilobato. Nella sua storia tassonomica, i confini di questo genere si sono più volte modificati. Nella prima metà del Novecento, prevaleva la linea di riconoscere come separati una serie di generi più piccoli, i più noti dei quali per giardinieri e appassionati sono Jacobinia e Beloperone. Nel 1988, uno studio di W. A. Graham ha inaugurato la linea opposta, con un vastissimo genere Justicia diviso in 16 sezioni e 7 sottosezioni, in cui sono confluiti molti generi minori. La soluzione continua a prevalere ed è stata confermata da studi recenti, ma è anche contestata sulla base di evidenze molecolari che dimostrano che Justicia nel senso di Graham è largamente parafiletico, ovvero artificiale. In attesa di cambiamenti che non mancheranno, godiamoci la bellezza di queste piante, apprezzate in natura da farfalle, api e colibrì e da tutti noi nei giardini o nelle serre (purtroppo, con l'eccezione parziale di J. americana, non sono rustiche). E' probabile che molti giardinieri e appassionati conoscano le due specie più note e coltivate sotto i vecchi nomi. La prima è Justicia carnea, in precedenza Jacobinia carnea, un arbusto di origine brasiliana (uno dei centri di diversità del genere) apprezzato per le spettacolari spighe di fiori tubolari rosa. La seconda è Justicia brandegeeana, in passato Beloperone guttata, nota nei paesi anglofoni con il curioso nomignolo shrimp plant, ovvero pianta gamberetto. A suggerirlo sono la forma e il colore delle brattee che sottendono i fiori sovrapposti come i segmenti della corazza di questo crostaceo. Comunque la si voglia chiamare, è un arbusto piacevole e dalle fioriture singolari, che dove il clima lo consente si protraggono per mesi. Tra le altre specie di questo numerosissimo genere, vale la pena di ricordare J. aurea, simile a J. carnea, ma con infiorescenze gialle; J. floribunda, un piccolo arbusto con fiori tubolari penduli bicolori gialli e scarlatti che qualcuno chiama molto impropriamente "fuchsia brasiliana"; la messicana J. spicigera, propria delle foreste aride, con brillanti infiorescenze aranciate, nota anche per le sue proprietà medicinali come depurativo e stimolante. Approfondimenti su queste e altre specie nella scheda. Esponente di spicco della scienza, della teologia e della politica svedese e finlandese della prima metà del Settecento, Johannes Browallius è poco noto al di fuori della Svezia e della Finlandia, tranne forse per l'abile difesa del sistema linneano contro gli attacchi di Siegesbeck. Più che per i suoi contributi originali (che scopriamo tutt'altro che secondari) all'estero è soprattutto un amico di Linneo o, magari, un ex-amico. Se sia vero o falso, scopriamolo insieme, anche seguendo le vicende delle denominazioni linneane delle specie del genere Browallia (Solanaceae) che si vuole riflettano gli alti e bassi di quella amicizia.  Linneo innamorato Nel dicembre del 1733, Linneo (all'epoca ventiseienne) fu invitato da uno dei suoi allievi ed amici, Claes Sohlberg, a trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, a Falun, in Dalarna, dove il padre era ispettore minerario. Era una buona occasione per visitare la miniera di rame, per approfondire gli studi di mineralogia cui si era già accostato durante il viaggio in Lapponia, e magari per fare qualche conoscenza utile alla sua carriera scientifica. Non si sbagliava: strinse amicizia con il giovane teologo Johannes Browallius (1707-1755) con il quale aveva molto in comune: erano coetanei, avevano studiato ad Uppsala e soprattutto erano entrambi assetati di conoscenza. Il nuovo amico lo introdusse presso il governatore del Dalarna Niels Reuterholm, per il quale lavorava come cappellano, informatore scientifico e precettore dei figli. Entusiasta del racconto del viaggio in Lapponia, il governatore commissionò a Linneo una spedizione analoga nella regione, che in effetti avrebbe avuto luogo nell'estate successiva (3 luglio-17 agosto 1734). Fu un’ancora di salvezza per Linneo, che nel frattempo era stato allontanato dall’università di Uppsala in seguito al brutto affare con Niels Rosén. Al rientro dal viaggio, al quale avevano partecipato tra l’altro Sohlberg e i due figli di Reuterholm, si stabilì a Falun, dove il governatore gli concesse di utilizzare il laboratorio della miniera e di aprire una piccola accademia privata, dove insegnava mineralogia; era una soluzione di ripiego e senza grandi prospettive. Secondo Browallius, la vera soluzione era un’altra: doveva andare all’estero, laurearsi in medicina (le università svedesi non erano abilitate a farlo) e, una volta laureato, tornare in Svezia ad esercitare la professione. Non aveva i soldi per il viaggio? Allora era il caso di trovare una fidanzata ricca. Sembra che gli abbia anche proposto vari partiti, ma senza successo. La freccia di Cupido, infatti, aveva già trafitto il cuore di Linneo. Tra coloro che seguivano le sue conferenze, che in quella piccola località di montagna di meno di 7000 abitanti destarono una certa sensazione, c’era anche il medico cittadino Johan Moraeus; Linneo cominciò a frequentarne la casa e si innamorò di una delle sue figlie, la diciassettenne Sara Elizabeth detta Sara Lisa. Squattrinato com’era, è strano che pensasse a sposarsi (anche se il dottor Moraeus era agiato, aveva sette figli, e Sara Lisa non era certo l’ereditiera favoleggiata da Browallius), ma sembra che a deciderlo a quel passo sia stata la morte della madre, deceduta ad appena 44 anni. In ogni caso, intraprese un serrato corteggiamento che conosciamo a grandi linee grazie al suo diario privato (laconico ma esplicito). Il giorno di Natale 1734 Linneo fu invitato a pranzo a casa Moreus. Il 2 gennaio 1735, per fare colpo, vi andò in visita vestito con il famoso costume lappone. Il giorno dopo, ripeté la visita approfittando dell'assenza dei genitori. Seguirono altre visite e incontri in casa di amici comuni, finché il 16 gennaio ("un giorno di immortale commemorazione", scrisse nel suo diario) Linneo fece la sua proposta a Sara Lisa e fu accettato. Il 20 gennaio chiese la mano al padre, che era molto perplesso: lui stesso medico, sperava per la figlia un matrimonio finanziariamente più promettente; ancora più contraria era la madre. Alla fine il dottore cedette, ma pose due condizioni: il matrimonio sarebbe avvenuto entro tre anni e nel frattempo Linneo doveva andare all'estero a laurearsi in medicina, in modo da poter mantenere la futura famiglia (i pareri di Perpetua… ovvero di Browallius). Il 22 gennaio i fidanzati si scambiarono gli anelli e i voti di fedeltà. Fu deciso che Linneo sarebbe andato a laurearsi a Hardwijk, la più economica delle università olandesi; insieme a lui sarebbe partito Claes Sohlberg, il cui padre avrebbe pagato il viaggio del figlio e di Linneo; Sara Lisa gli passò sotto banco i suoi risparmi, un centinaio di corone, e, dopo baci e abbracci il 20 febbraio il neofidanzato lasciò Falun per la Svezia meridionale dove avrebbe salutato la famiglia, per poi partire per l’Olanda.  Una leggenda botanica L'amicizia con Linneo fu determinante anche per Browallius, che da quel momento intensificò i suoi interessi scientifici. Ispirato dalla spedizione lappone dell'amico, nel 1735 e nel 1736 intraprese due viaggi scientifici che dalla Dalarna lo portarono in Norvegia. Si mantenne in corrispondenza con Linneo (che, ad esempio, informò anche lui che si sarebbe trattenuto in Olanda essendo stato assunto come medico personale e curatore del giardino di Clifford) e nel 1737 gli spedì uno suo testo in svedese sulla necessità di introdurre l'insegnamento scientifico nelle scuole superiori, che Linneo tradusse in latino e pubblicò in appendice a Critica botanica, l'opera in cui dettò le regole per la formulazione dei nomi delle piante. Ma a un certo punto, secondo la vulgata, sarebbe successo un fattaccio che avrebbe messo fine alla loro amicizia. La versione più nota è quella del Curtis's Botanical Magazine (1838) che riprende e amplia una notizia del Codex botanicus linnaeanus di Hermann Richter (1837). Ecco dunque i fatti: mentre si trovava all’estero, qualcuno informò Linneo che Browaliius aveva approfittato della sua assenza per corteggiare Sara Lisa ed era quasi riuscito a convincerla a lasciare il fidanzato che, a quando le diceva, non aveva alcuna intenzione di tornare in Svezia. Fu una delusione cocente per Linneo che troverebbe riflesso nelle denominazioni delle tre specie del genere Browallia che egli aveva incautamente dedicato all’ex-amico: B. elata ("alto, elevato, nobile") rappresenterebbe il momento più alto della loro amicizia; B. demissa ("basso, debole, pendente" ma in questo caso "scoraggiato") la rottura, mentre B. alienata, oltre all'incerta natura di questa specie, la successiva separazione tra i due. Un’altra versione meno popolare (la troviamo ad esempio nella Revue scientifique, 1865) sostiene che Linneo chiamò la prima specie di Browalllia a lui nota B. demissa; aveva bei fiori, ma il suo portamento ricadente ben rifletteva l’atteggiamento umile, dimesso, di Browallius nei suoi confronti; egli si mantenne umile e rispettoso anche quando divenne vescovo, così Linneo chiamò B. elata una seconda specie più alta; con il tempo, però, il vecchio amico insuperbì e incominciò a trattare Linneo in modo ingiusto; così, quando venne scoperta una terza specie piena di spine fu la volta di B. alienata, a suggellare la fine di un’amicizia. Quanto c’è di vero in queste storie? Nulla, secondo la biografia di Linneo di Theodor Magnus Fries e Banjamin Daydin Jackson, che ritengono che alla base di questa vera e propria leggenda metropolitana ci sia un equivoco. Effettivamente tra Browallius e Linneo ci fu se non uno scontro, una differenza di vedute, ma non riguardava la mano di Sara Lisa, bensì il livello del mare. In un importante articolo supplicato dall’Accademia svedese delle scienze nel 1743, l’amico di Linneo Anders Celsius (colui che inventò la scala centimetrica delle temperature) spiegò l'innalzamento delle terre emerse con la lenta diminuzione del volume delle acque oceaniche; Linneo appoggiò questa tesi; vi si opposero invece altri studiosi, tra cui appunto Browallius in saggio pubblicato postumo nel 1756 in cui vi contrappose una grande massa di misurazioni che dimostravano il contrario. Ma torniamo a Browallia e proviamo a verificare se il piccolo affaire de coeur regge alla prova dei fatti. Nel 1735 Philip Miller ricevette da Panama i semi di una pianta che coltivò a Chelsea e chiamò Dalea; presumibilmente in occasione del suo viaggio in Inghilterra dell’estate del 1736, ne fece parte a Linneo che decise di dedicare la pianta, appartenente a un nuovo genere, all’amico Browallius; il genere Browallia compare per la prima volta proprio in Critica botanica (maggio 1737) tra le denominazioni dedicate a “celebri botanici” senza altre indicazioni che “a Browallius svedese, 1737”; nessuna indicazione neppure nella prima edizione di Genera plantarum, uscita a Leida lo stesso anno. Contemporaneamente Linneo stava scrivendo Hortus cliffortianus (sul frontespizio compare la data di stampa 1737, ma in realtà uscì nel 1738) dove invece troviamo una lunga e sperticata dedica in cui il “chiarissimo teologo e maestro Johannes Browallius” viene dipinto come un erudito universale, versato in ogni ramo delle scienze naturali dalla litografia alla botanica alla zoologia. Al genere è attribuita una sola specie, di cui viene dato il nome descrizione; il binomiale compare per la prima volta quasi vent’anni dopo, nella prima edizione di Species plantarum (1753) e non è nessuno di quelli citati, ma banalmente Browallia americana. I famosi nomi Browallia demissa, B. elata, B. alienata compaiono in quest’ordine (dunque demissa precede elata) solo nella decima edizione di Systema naturae (1758-59); Linneo si è convinto che ci siano almeno due specie di Browallia, una che reca un solo fiore per peduncolo, che chiama B. demissa; un’altra con fiori riuniti in mazzi, che chiama B. elata; ce n’è poi una terza alquanto differente, B. alienata, che in precedenza aveva classificato come Ruellia paniculata. Non c’è bisogno di evocare né love story né la superbia di Browallius per spiegare questi nomi: B. americana (è tornata a chiamarsi così per la regola della priorità) è una specie molto variabile che può avere portamento ricadente (demissus) o eretto (elatus); quanto a B. alienata, aveva ragione il Linneo del 1753: il nome corretto è Ruellia paniculata (ed appartiene a tutt'altra famiglia). Aggiungiamo ancora un dato: il 12 febbraio 1737 Browallius sposò Elisabet Ehrenholm. Come abbiamo visto, dopo la partenza di Linneo, anche lui si mise in viaggio e ritornò a Falum solo nell'autunno o nella tarda estate del 1736. Quando sarebbe avvento il fattaccio? Possiamo ipotizzare che nell’arco di pochi mesi Browallius abbia corteggiato Sara Lisa, sia stato respinto, per poi fidanzarsi e sposarsi con un’altra, e Linneo sia venuto a saperlo solo nella seconda metà del 1737 o addirittura nel 1738? La biografia di Browallius pubblicata dall'archivio di stato svedese ammette una breve rottura, subito ricomposta, ma le lodi sperticate di Linneo all'amico rendono poco credibile anche questa ipotesi. Tanto meno è credibile che abbia covato il suo astio per vent’anni, dandogli libero sfogo quando ormai Browallius era morto e sepolto. Tanto più che, come vedremo tra poco, aveva un debito di riconoscenza non da poco nei suoi confronti; testimonianze dirette e corrispondenza stanno lì a dimostrare che l'amicizia, magari affievolita dalla distanza e dagli impegni di entrambi, non venne mai meno. 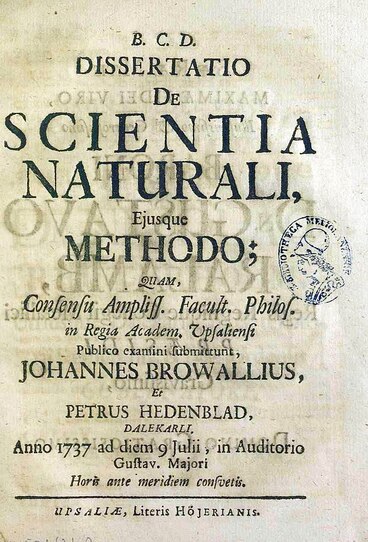 Uno scienziato, insegnante, pastore e politico molto impegnato Dissipata la nebbia delle leggende, veniamo al vero Browallius, una personalità di primo piano dell’Illuminismo svedese. Il 1737 per lui fu un anno di svolta; oltre a sposarsi, scrisse due importanti testi teorici che gli aprirono le porte dell'insegnamento universitario: il trattato De scientia naturali eiusque metodo, dedicato allo statuto e ai metodi delle scienze naturali, e un saggio in svedese di politica educativa in cui sosteneva l’utilità dell’introduzione dell’insegnamento della scienza nelle scuole, in particolare nei ginnasi (quello tradotto in latino da Linneo). Grazie ad essi, il cancelliere dell'Università di Abo/ Turku Ernst Johan Creutz ne caldeggiò la nomina a professore di fisica (un’etichetta che copriva un po’ tutte le scienze naturali): Browallius, versato in molte scienze, con un solido impianto teorico e aperto alla ricerca sperimentale, gli pareva la persona giusta per modernizzare l’insegnamento universitario aprendolo alle scienze esatte e naturali. La nomina di Browallius segnò per la Finlandia l'inizio di quella che è stata chiamata "età dell'utile", ovvero di un illuminismo che vedeva nella scienza lo strumento centrale per rinnovare l'economia e la società. Nominato professore nel novembre 1739, egli inaugurò il suo corso nel 1738 e mantenne la cattedra fino al 1746; le sue lezioni toccarono tutti i rami delle scienze naturali, nonché il loro intreccio con la teologia; seguì (o meglio scrisse, secondo l'uso del tempo) 49 tesi che toccano argomenti che spaziano dalla fisica sperimentale alla mineralogia, dalla chimica alla zoologia e alla botanica. Nelle sue lezioni insistette sull'utilità delle scienze applicate alla tecnica e all'economia; rifacendosi a Bacone, Newton e Linneo, il suo insegnamento aveva un carattere spiccatamente sperimentale. Lo sperimentalismo è particolarmente evidente nel campo della chimica, in cui il suo maggiore contributo furono le ricerche sull'arsenico, il suo ossido e il solfuro, che ne fanno il precursore del nipote Johann Gadolin (figlio di sua figlia Elisabet), considerato il fondatore della chimica finlandese. Riservò molta attenzione anche alla botanica. Come Linneo, accompagnava gli studenti in escursioni botaniche e lasciò manoscritta una flora finlandese; scrisse non meno di dodici trattati di argomento botanico, molti dei quali dedicati alla botanica economica. Ottenne che l'Università finanziasse ogni anno una borsa di studio per esperimenti botanici e coltivazioni sperimentali. Tra i suoi allievi il più noto è Pehr Kalm, che fu in un certo senso anche l'erede di questa impostazione scientifica fortemente ancorata all'economia. Sostenitore della prima ora del sistema linneano, di cui si può dire abbia visto la nascita discutendone con il creatore negli anni di Falun, Browallius esordì come scrittore scientifico nel 1739 con un trattato in sua difesa che gli diede anche una certa rinomanza all'estero, oltre a rendere all'amico un servizio incommensurabile. Linneo era tornato in Svezia alla fine del giugno 1738; andò subito a Falun, ma anziché rimanervi come assistente del suocero, come questi aveva progettato, decise di esercitare la professione a Stoccolma, dove avrebbe avuto più possibilità di lanciare la sua carriera scientifica, forte dei tanti scritti epocali pubblicati in Olanda e della crescente fama europea. Scoprì amaramente che i due pamphlet di Siegesbeck che presentavano il suo sistema come "pornografia botanica" gli avevano fatto intorno terra bruciata; come scrisse a Albrecht von Haller, forse con un po' di esagerazione, era diventato la favola della città, tanto che gli era difficile persino trovare un servitore disposto a lavorare per lui e nessuno gli avrebbe fatto curare neppure un cane. A suo tempo aveva promesso a Boerhaave di non farsi trascinare in una nessun disputa scientifica e non intendeva rispondere di persona; a farlo per lui fu dunque Browallius. In Examen epicriseos in Systema plantarum sexuale Cl. Linnaei, Anno 1737 Petropoli evulgatae, auctore Jo. Georgio Siegesbeck, pubblicato nel 1739, egli smontò punto per punto le critiche di Siegesbeck, dimostrandone l'infondatezza tanto scientifica quanto morale e teologica; un solo rilievo poteva essere mosso al sistema linneano: una medesima classe poteva riunire piante molto diverse; era però un difetto comune a tutti i sistemi artificiali, che sarebbe stato superato solo quando fosse stato possibile stabilire un sistema naturale, verso il quale il sistema di Linneo era un passo avanti, visto che conteneva più gruppi naturali di ogni sistema precedente. La serrata e lucida argomentazione (che certo fu discussa e preparata con lo stesso Linneo) ristabilì l'onore scientifico e personale del "principe dei botanici", tanto più che l'aveva scritta un teologo e un rispettato ecclesiastico. Browallius, infatti, affiancava all'attività scientifica e didattica un forte impegno pastorale: fin dal 1738 fu nominato vicario della parrocchia di Pikis, che forniva le prebende da cui dipendeva la sopravvivenza dell'Università; come predicatore, dovette imparare il finlandese e lo fece così bene e in fretta che presto fu coinvolto nella revisione della nuova Bibbia della chiesa finlandese. Nel 1740 presentò la tesi De coercitione hereticorum e fu dichiarato dottore in teologia; lo stesso anno fu promosso diacono e vicario della parrocchia di Turku. Nel 1746 lascò la facoltà di filosofia per assumere la cattedra di teologia; nel 1749 divenne vescovo della diocesi di Abo/ Turku. L'ascesa nella gerarchia ecclesiastica promosse la sua carriera politica. Benché il suo primo sponsor fosse stato Ernst Johan Creutz, noto esponente del partito dei berretti, Browallius si schierò con i "cappelli", la cui politica culturale includeva la promozione delle scienze ritenute utili e l'estensione dell'uso dello svedese a discapito del latino. Scelto come esponente del clero nel parlamento del 1746-47, sostenne vigorosamente le posizioni del partito dei cappelli, entrando a far parte di varie commissioni. Ancora più rilevante fu il suo ruolo nel parlamento del 1751-52 come membro del comitato segreto; nell'ambito della discussione sui principi dello stato nel memoriale Sui concetti fondamentali della forma del governo sostenne la sovranità popolare espressa in forma repubblicana, rifacendosi ai costituzionalisti inglesi e al pensiero di Locke. Nello stesso spirito, chiese che l'educazione del principe ereditario includesse fin dall'inizio l'avversione per l'autocrazia, "contraria alla legge di natura e all'economicità". Ovviamente, anche se ottenere qualche ascolto, queste posizioni non furono divulgate all'esterno del Consiglio segreto. In ogni caso, Browallius era probabilmente sulla strada di diventare arcivescovo, quando morì improvvisamente nel 1755, a soli 48 anni.  Fiori di zaffiro Browallia L. è un piccolo genere di erbacee annuali o perenni della famiglia Solanaceae, diffuse dall'Arizona alle Ande tropicali, passando per il Messico, l'America centrale e le Antille. Assai discusso il numero di specie attribuite, che a seconda degli autori varia da 6-7 a 19; è affine al genere monotipico Streptosolen, la cui unica specie S. jamesonii era un tempo classificata come B. jamesonii. Il diverso numero delle specie riconosciute è legato alla variabilità morfologica delle specie stesse (che, come abbiamo visto, trasse in inganno già Linneo) ma soprattutto a scoperte recenti in particolare nell'area peruviana, dove a partire dal 1995 alla lista della specie note è venuta ad aggiungersi una dozzina di specie scoperte dal team coordinato da S. Leiva Gonzales, il quale è il primo a riconoscere che "il genere richiede maggiori osservazioni sul campo, studi cito-genetici e molecolari per poter delimitare le specie". Le nuove arrivate non sono solo peruviane, tanto più che qualche specie sembra fatta apposta per eludere le ricerche dei botanici, come è il caso di B. eludens: fu descritta per la prima volta nel 1993 ed oggi ne sono conosciute popolazioni disgiunte in una singola località dell'Arizona sud-orientale e in poche località negli stati messicani di Chihahua e Sonora, dove sembra confinata ad habitat con estati temperate e umide lungo i confini delle boscaglie sempreverdi della Sierra madre occidentale. E' un'annuale strettamente legata al regime delle piogge, con un breve ciclo vitale; il che significa che negli anni di scarsa pioggia può scomparire ed essere più abbondante dove trova l'habitat giusto. Si distingue dalle altre specie per i fusti non ramificati e per i fiori bianchi. Per variabilità la campionessa sembra essere la specie tipo B. americana, che infatti ha collezionato una ventina di sinonimi: variano il portamento, eretto oppure decombente, le dimensioni, la presenza o l'assenza di peli ghiandolari, la forma e la dimensione delle foglie, il colore dei fiori (bianchi, azzurri, azzurri con una macchia bianca, malva, viola) solitari o riuniti in piccoli gruppi. Anche se non sono molto grandi, sono molto numerosi, rendendo questa specie decisamente decorativa; è dunque una pianta da giardino molto apprezzata, soprattutto in una delle sue varietà con fiori più grandi, spesso commercializzata sotto il sinonimo B. grandiflora. Come annuale da giardino, è coltivata anche B. viscosa, caratterizzata da fiori blu con centro bianco La specie più diffusa in case e giardini è però B. speciosa, originaria di Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Perù; è perenne, ma da noi è spesso trattata come annuale. Di portamento piuttosto cespuglioso e ramificato, adatta anche alla coltivazione in vaso e in cestini appesi, sta conoscendo una crescente popolarità per il colore insolito dei fiori blu-viola, cui deve il nome comune fior di zaffiro, l'abbondanza dei fiori, che può essere favorita da opportune cimature, e il lungo periodo di fioritura, che si protrae da giugno a settembre. Tra le varietà più note 'Blue Troll', di portamento compatto con fiori blu e centro bianco, e 'White Troll' con fiori bianchi. Viene anche commercializzata come pianta d'appartamento, spesso trattata con nanizzanti per mantenere il portamento compatto. L'ultima novità sono gli ibridi, caratterizzati da fioriture prolungate e da fiori particolarmente grandi e numerosi, come 'Illumination' (blu scuro) e 'Flirtation' (bianca) della serie Endless, indicati anche per aree in mezz'ombra. Nella primavera del 1788, il botanico francese André Michaux e suo figlio François André visitano la Florida occidentale dove sono accolti con squisita cortesia dal governatore Vicente Manuel de Céspedes. Memore di quell'accoglienza, qualche anno dopo Michaux gli dedica uno dei suoi nuovi generi americani, ma un errore di lettura o una svista del tipografo trasformano il buon governatore in Lespedez e il genere in Lespedeza. 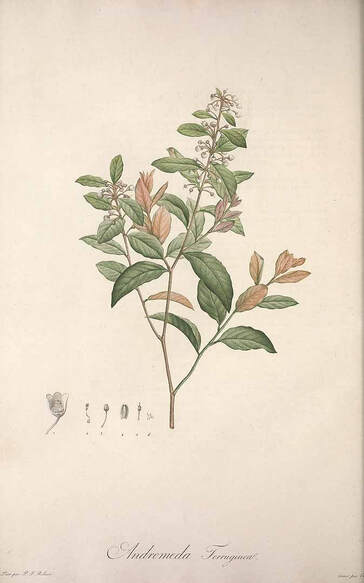 Un memorabile viaggio in Florida Inviato negli Stati Uniti come botanico reale alla ricerca di piante utili per ripopolare le foreste francesi, André Michaux era invece intenzionato ad andare oltre questo mandato: voleva scrivere una flora del Nord America, e per questo desiderava visitare tutte le zone accessibili, incluse la Florida spagnola e le Bahamas, nonostante la loro flora tropicale o subtropicale poco si adattasse all'introduzione in terra francese. Già nel 1787 aveva comunicato al Conte d'Angevilliers, direttore generale dei Bâtiments du Roi (da cui dipendeva la sua missione) la sua intenzione di visitare la Georgia e la Florida. Tensioni di frontiera bloccarono per qualche mese il progetto, finché alla fine del febbraio 1788, accompagnato dal figlio François André e da un servitore, egli salpò da Charleston alla volta di St. Augustine, la capitale della Florida occidentale. Agli ufficiali di porto dichiarò di essere stato autorizzato a studiare la storia naturale della provincia dal governatore, Vicente Manuel de Céspedes (o Zéspedes), al quale evidentemente aveva scritto, anche se il carteggio non ci è pervenuto. Condotto alla presenza del governatore, fu ricevuto con grande calore e cortesia. Solo qualche giorno dopo scrisse nuovamente a d'Angevilliers per ottenere il permesso ufficiale di fare raccolte botaniche in Florida. Di fatto, si era già messo al lavoro. Oltre a esplorare i dintorni della città, dove scoprì una nuova specie di Ericacea, Lyonia ferruginea, si era procurato un terreno dove creare un vivaio temporaneo e aveva affittato una canoa e due rematori. Il 12 marzo partì alla volta dell'Anastasia Island, dove fu ospite del mercante Jesse Fish che nella sua residenza, chiamata El Verge, aveva creato un giardino ricco di olivi, palme da dattero, limoni e aranci; Michaux nelle sue memorie lo definisce un paradiso. Era la prima tappa di un viaggio, parte in canoa, parte a piedi, parte a cavallo, che li portò in direzione sud, sempre erborizzando, ad esplorare la costa orientale della Florida lungo il Northwest River e l'Indian River fino all'altezza dell'attuale Bonaventure, dove giunsero all'inizio di aprile; oltre non era possibile andare, essendo ormai penetrati in territorio indiano. Durante il viaggio di ritorno affittarono dei cavalli per riportare le raccolte a St. Augustine e osservarono un incendio: sia gli indiani sia gli europei usavano applicare incendi per facilitare la caccia o per liberare terreni per il bestiame, una pratica altamente disapprovata da Michaux. Rientrato a St. Augustine il 17 aprile, Michaux fece subito visita al governatore, che nei giorni successivi volle visitare di persona le collezioni e invitò il botanico a pranzo. Quest'ultimo era impegnato a riordinare le raccolte (stando al suo diario, fino a quel momento ammontavano a 105 specie), a scrivere lettere in Francia e ai rappresentanti diplomatici francesi, anche per battere cassa, e a preparare la prossima escursione. Il 29 aprile era infatti di nuovo in partenza con gli stessi compagni, questa volta a cavallo, alla volta della residenza di Job Wiggins, che aveva accompagnato William Barton nella spedizione del 1774. Situata sulla riva orientale del St. Johns River, era un buon punto di partenza per esplorare il bacino del fiume, il maggiore della colonia; nei dintorni, Michaux trovò una nuova specie di graminacea, Stenopholis obtusata. Da quel momento il viaggio proseguì in canoa, toccando Mount Royal, una collina sabbiosa visitata e così denominata da John Bartram nel 1765, e Drayton Island sul lago George; quindi continuò lungo il St Johns River e nella strettoia oggi chiamata Salt Springs Run fino alla sorgente dove Michaux raccolse Illicium parviflorum, già osservato nei lori viaggi dai due Bartram ma ancora non descritto. Quindi il gruppo esplorò Silver Gleb Spring e proseguì fino alla confluenza tra il lago George e il St. Johns River, quindi lungo il fiume dove dopo qualche giorno si imbatté in correnti contrarie e grandi masse di alligatori; giunto all'altezza dell'attuale High Bank, avendo trovato poche specie nuove, Michaux decise di rientrare a St. Augustine. Il viaggio volgeva al termine. Dopo un'ulteriore visita al governatore e ad alcune famiglie influenti, i Michaux si imbarcarono con loro raccolte alla volta di Charleston; qui le talee prese in Florida furono trapiantate nel vivaio, mentre i semi di molte piante venivano spediti in Francia; tra le altre, Guilandina bonduc, Sophora tomentosa, Chiococca alba, Ceanothus microphyllus, Conocarpus erectus, Psychoria nervosa, Amyris eleifera, Zamia integrifolia, Tillandsia utriculata, Modiola caroliniana.  Ripopolare la Florida E' ora di sapere qualcosa di più dell'ospitale governatore Vicente Manuel de Céspedes (1721?-1794); appartenente a una famiglia di militari e militare egli stesso, prima di arrivare in Florida per circa un anno era stato governatore facente funzione a Santiago de Cuba; nel 1783 fu nominato primo governatore della Florida orientale che, dopo vent'anni di occupazione britannica, tornava sotto sovranità spagnola in forza del trattato di Parigi. Céspedes si trovò così a gestire una difficile transizione. Il problema principale era quello del popolamento. La popolazione era molto mista: c'erano spagnoli provenienti dalla madre patria, cubani, minorchini (Minorca nel Settecento era passata più volte dalla sovranità spagnola a quella britannica e viceversa, e molti erano di lingua inglese), francesi, italiani, greci, britannici che durante l'occupazione inglese erano subentrati agli spagnoli che avevano preferito lasciare la colonia. Il timore era che con il tempo gli anglofoni potessero prendere il sopravvento o che gli Stati Uniti decidessero di invadere il paese; venne così fissato l'obiettivo di aumentare la popolazione, fino a eguagliare nell'arco di 25 anni quella della Georgia. La corona fissò regole molto stringenti per i nuovi immigrati, la principale delle quali era che dovevano essere di religione cattolica; anche gli stranieri erano ben accetti, purché fossero appunto cattolici e imparassero la lingua spagnola. Céspedes, da parte sua, cercò di favorire i nuovi arrivi, garantendo dieci anni di esenzione dalle tasse, terre, aiuti come bestiame, sementi, attrezzi. Buona parte del territorio era disabitato, e le terre non mancavano, ma la questione del ripopolamento si incrociava con quella delle proprietà. Alcune, i cui proprietari ispanici avevano preferito lasciare la Florida, erano rimaste vacanti al momento dell'occupazione inglese, altre erano state abbandonate dagli inglesi al ritorno degli spagnoli. Céspedes propose che tutte le proprietà vacanti e non rivendicate entro una certa data fossero confiscate dalla corona, per essere ridistribuite ai nuovi immigrati, in particolare i cosiddetti floridanos, ovvero quelle persone che si erano stabilite a Cuba dopo l'occupazione inglese della Florida, di cui voleva incoraggiare il ritorno nella penisola. Un'ultima questione riguardava gli schiavi neri. Poiché nella Florida spagnola non c'erano né piantagioni né miniere, erano pochi; inoltre, nel 1693, il re Carlo II aveva emanato un decreto che concedeva la libertà agli schiavi fuggiti dall'America britannica, purché accettassero la religione cattolica. Così si era formato un notevole insediamento di neri liberi a nord di S. Augustine; godevano della libertà personale, non erano discriminati e formarono persino un reggimento di milizia. Altri schiavi fuggiti si erano rifugiati presso gli indigeni Creek e Seminole. Durante il ventennio di occupazione, i coloni britannici avevano introdotto l'economia di piantagione (si coltivavano cotone, indaco, canna da zucchero) e con essa schiavi neri portati dall'Africa. Al ritorno degli Spagnoli, essi chiesero di essere liberati in osservanza alla legge di Carlo II, mentre i loro proprietari, che ora si era stabiliti in Georgia o nelle Caroline, ne chiedevano la restituzione; Céspedes, anche se temeva che molte conversioni fossero di comodo, li trattenne in Florida. Buona parte del territorio era inesplorato; gli abitati si concentravano lungo la costa, con centro principale a St. Augustine (Jacsksonville e Miami non esistevano ancora) e non si spingevano oltre il Río de Mosquitos, forse a sud dell'attuale Cape Canaveral. Gli inglesi avevano poi creato una serie di piantagioni lungo il St Johns River, il più lungo e importante della regione anche per i commerci, anche se, per le sue acque basse e paludose, era navigabile solo in canoa. Si capisce dunque perché il governatore si sia mostrato così amichevole verso Michaux e abbia incoraggiato la sua esplorazione. Nel 1784, ordinò un censimento, seguito nel 1786 da un secondo più dettagliato. La conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche geografiche e umane, delle sue risorse, erano per lui un dovere d'ufficio, come dimostra il suo unico scritto noto, Descripción de la Florida Oriental: su clima, terreno, productos, ríos, barras, bahías, puertos, números y calidades de la gente que la habitan, un manoscritto inedito oggi conservato nell'Audiencia de Santo Domingo dell'Archivio General de Indias, da lui inteso come una vera e propria guida per indirizzare la politica immigratoria. Il documento inizia con una una descrizione geografica della Florida orientale, soffermandosi sull'estensione, il clima, le forme del territorio; si trattano poi i fiumi principali, i laghi, le lagune costiere, sempre indicando gli eventuali popolamenti e la loro consistenza, i pochi nuclei urbani. Dopo aver trattato in modo abbastanza generico le risorse naturali (che sono comunque abbondanti e promettenti), Céspedes conclude con la parte più politica: le sue indicazioni per incrementare il commercio (che a suo parere deve avvenire soprattutto da e verso Cuba) e per favorire l'immigrazione, terminando con le Reglas y condiciones para pobladores tanto extranjeros como naturales di cui abbiamo già parlato. L'incarico di Céspedes terminò nel 1790; dovette quindi ritornare a Cuba, dove sappiamo che morì nel 1794 e fu sepolto nella cattedrale dell'Avana.  Un errore... di sbaglio Michaux non dimenticò mai la cortesia con la quale era stato accolto dal governatore Céspedes, che la sua lotta con l'avara e poco sollecita amministrazione francese prima e dopo la rivoluzione gli facevano apprezzare anche più. Così nella sua Flora boreali-americana non poteva mancare di rendergli omaggio, dedicandogli uno dei suoi nuovi generi. Il libro fu pubblicato postumo nel 1803 a cura del figlio François André e questo forse spiega il fattaccio: tanto il nome del genere quanto quello del dedicatario sono infatti sbagliati. Il genere si chiama Lespedeza, non Cespdeza o Zespedeza (le due forme sotto le quali conosciamo il nome del governatore) e del dedicatario si dice "Per il sig. Lespedez, governatore della Florida, cortesissimo nei confronti dei miei viaggi". Eppure anche François André era della partita... ma, come si dice in questi casi, la colpa è del proto che avrà scambiato la lettera iniziale C con L. Lespedeza Mich. è un genere di una quarantina di specie della famiglia Fabaceae, con una distribuzione nettamente disgiunta: una trentina vivono nelle zone temperate e subtropicali dell'Asia orientale e in Australia, mentre le altre sono originarie del Nord America orientale. Il numero delle specie e la loro corretta individuazione hanno dato filo da torcere ai botanici a causa sia dell'estrema variabilità delle specie, sia della tendenza a produrre con facilità ibridi naturali. Il genere, caratterizzato dai fiori papilionacei (ma molte specie hanno anche fiori cleistogami, cioè autofecondanti, privi di petali) e da baccelli tipici di questa famiglia, è piuttosto vario: comprende infatti erbacee perenni, arbusti e rampicanti. La specie più nota e coltivata nei giardini è senza dubbio L. thunbergii, uno splendido arbusto originario della Cina e del Giappone con eleganti rami arcuati che alla fine dell'estate si trasformano in una cascata di fiori rosa-porpora. L'americana L. capitata è invece famosa per altre ragioni: già gli indiani ne usavano le foglie per preparare tisane medicamentose; oggi è usata in fitoterapia per le sue proprietà drenanti, diuretiche e antiossidanti, che la rendono particolarmente indicata per migliorare le funzioni renali. Come molte leguminose, anche le piante di questo genere hanno radici dotate di noduli che ospitano batteri in grado di fissare l'azoto, arricchendo così il terreno. In Asia diverse specie sono usate come foraggere e appunto per il sovescio. Le loro forti radici sono utili anche per arginare il terreno, contenendo gli smottamenti. Ma queste belle qualità possono anche presentare un rovescio della medaglia, come dimostra la storia dell'asiatica L. cuneata. Questa pianta è stata introdotta in diversi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti dove venne piantata per la prima volta nel 1896 nel Nord Carolina per bonificare i terreni di miniere abbandonate, e anche come foraggiera; grazie alle radici molto profonde, non solo trattiene il terreno, ma riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità. Ne sono anche state sviluppate diverse varietà. Eppure tanto vigore ha un rovescio della medaglia: una singola pianta può produrre 1000 semi all'anno, dove si insedia invade gli spazi delle piante native, inibisce la crescita dei semenzali degli alberi, produce sostanze chimiche che inibiscono la crescita di altre piante. Negli Stati Uniti è già un problema, in Europa non ancora, ma l'Unione europea l'ha inserita nella lista delle piante invasive e ne ha vietato la commercializzazione. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
July 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed