|
L'orto botanico di Madrid rimase a lungo una roccaforte del sistema di Tournefort. Bisognò attendere la morte del primo cattedratico José Quer nel 1764 perché finalmente si aprisse alla nomenclatura e alla classificazione linneane, grazie al suo successore Miguel Barnades. Anche lui catalano, ma formato a Montpellier, era molto più aperto del suo predecessore ed educò ai nuovi principi una generazione di validi botanici, il più famoso dei quali è José Celestino Mutis. Per i suoi studenti scrisse Principios de botánica, in cui si dimostra buon conoscitore degli apporti dei botanici europei e adotta una posizione ecclettica che accanto a Linneo valorizza anche i tentativi di classificazione naturale della scuola francese, in particolare di Michel Adanson. Era la prima opera di botanica scritta in castigliano; ciò comportò la creazione di un intero vocabolario, per il quale Barnades, al semplice adattamento dal latino, spesso preferì attingere alla lingua parlata. Lo ricorda il genere sudamericano Barnadesia, omaggio dell'allievo José Celestino Mutis. Il primo manuale di botanica in lingua castigliana Come si è visto in questo post, il Reale orto botanico di Madrid, sito inizialmente a Migas Calientes, nacque nel 1755; già nel 1757 furono attivi corsi di botanica per i futuri medici e farmacisti, tenuti dal primo professore e direttore del giardino José Quer e dal secondo professore Joan Minuart. Entrambi catalani e allievi di Jaume Salvador, si erano formati nel credo tournefortiano cui improntarono anche il loro insegnamento. Tutto cambiò nel 1764 quando Quer morì e fu sostituito da un altro medico catalano, Miguel Barnades (1708-1771) che, avendo studiato a Montpellier dove era stato allievo di Boissier de Sauvages, aveva una formazione più aggiornata. Anche se non era un linneano di stretta osservanza, apprezzava sia la nomenclatura binomiale sia il sistema artificiale di Linneo, di cui riconosceva la praticità e l'efficacia didattica. Convinto assertore dell'utilità della botanica non solo per la salute pubblica, ma anche per l'economia, attraverso l'agricoltura, l'allevamento, le applicazioni industriali, per permettere al maggior numero possibile di studenti di appropriarsi dei principi della botanica decise di divulgarli in un'opera in lingua volgare, Principios de botanica: sacados de los mejores escritores y puestos en lengua castellana (Madrid 1767), come egli dichiara esplicitamente: "Il desiderio di rendere più facile alla gioventù spagnola lo studio metodico della botanica mi spinge, o lettore, a presentarti la spiegazione dei principi di questa scienza naturale in lingua castigliana". L'opera si apre con un profilo storico della botanica che dimostra quanto Barnades si tenesse aggiornato e quanto fosse privo di pregiudizi e aperto all'innovazione. Dopo un excursus sull'antichità e gli arabi, egli si sofferma sul Cinquecento, l'epoca dei restauratori, sul Seicento, l'epoca degli ordinatori, e sul proprio secolo, l'epoca dei riformatori. Tra i moderni, elogia in primo luogo Linneo, raccomandando in particolare Filosofia botanica e Genera plantarum; cita positivamente anche il suo maestro Sauvages, Ludwig, Duhamel de Monceau, Haller, Adanson e Oeder. Si noti che Familles de plantes di Adanson era stato pubblicato nel 1763-64; di Elementa botanicae di Oeder era uscito l'anno prima il primo volume, mentre del secondo si attendeva la pubblicazione, come Barnades aveva saputo dell'autore stesso, evidentemente uno dei suoi corrispondenti. L'approccio del botanico catalano era dunque eclettico e poteva conciliare la classificazione artificiale di Linneo con quella naturale di Adanson, a proposito della quale faceva notare che individuare gruppi di piante affini era particolarmente utile per la botanica farmaceutica perché "le piante della stessa famiglia naturale e anche più dello stesso genere naturale" hanno spesso proprietà simili. Dopo un capitolo dedicato all'utilità della botanica, il libro prosegue con capitoli sulla botanica in generale, le piante e le loro divisioni, le parti delle piante, distinte in durevoli, secondarie e temporanee (quelle attinenti alla fruttificazione, dal fiore al frutto al seme), la fruttificazione (definita "clandestina") di felci, muschi ed alghe. Il breve capitolo conclusivo, sulla traza ovvero l'habitus o aspetto generale, era inteso come preludio a una seconda parte che avrebbe dovuto insegnare a riconoscere in modo chiaro e distinto le piante e a nominarle in modo corretto; questo secondo volume tuttavia non fu mai scritto. Il maggiore contributo del libro di Barnades consiste indubbiamente nel tentativo di creare un'intera terminologia; nel descrivere in modo analitico le varie parti delle piante, egli introduce centinaia di neologismi. Al semplice adattamento della parola latina, in genere egli preferisce un equivalente nella lingua comune; ad esempio, per le infiorescenze troviamo le seguenti equivalenze: corymbus = maceta; umbella = copa; cyma = cimero; panicula diffusa = panoja; panicula coartata = mazorca; thyrsus = toba; racemus = racimo; spadix = tamarra; spatha = garrancha; spica = espiga; verticillus = rodajuela. E' una scelta estrema, che corrisponde al desiderio di avvicinare alla botanica anche chi non aveva alcuna familiarità con il latino, ma che ebbe poco seguito. Rimanendo al nostro esempio, gli unici termini ancora usati nella terminologia botanica spagnola sono espiga e racimo, non a caso i più vicini alla forma latina. Solitamente si considera il manuale di Barnades troppo teorico per avere lasciato una traccia permanente, ma certamente contribuì al vero merito del medico e botanico catalano: aver gettato le basi della moderna botanica iberica aprendo la strada alla metodologia linneana, che sarà poi assai approfondita dai suoi successori Casimiro Gomez Ortega e Antoni Palau y Verdera. Tra i suoi allievi, il più noto è José Celestino Mutis, con il quale strinse amicizia durante il suo soggiorno a Cadice e che poi lo seguì a Madrid, dove la sua attività didattica dovette iniziare in modo ufficioso prima della nomina a professore all'Orto botanico, visto che Mutis lasciò la Spagna nel 1760.  Una dedica americana Si deve proprio a lui (con la complicità del figlio di Linneo) l'omaggio al botanico catalano del genere Barnadesia, descritto dal primo ma pubblicato dal secondo in Supplementum Plantarum (1781) con questa breve annotazione: "In memoriam Botanici Hispanici Barnadez dixit Mutis". Questo genere della famiglia Asteraceae, esclusivamente sudamericano, comprende 22 specie di arbusti e piccoli alberi, distribuite dalla Colombia all'Argentina, per lo più andine, tranne una singola specie che dal sudest del Perù si spinge fino al Brasile. Tra le caratteristiche distintive, la presenza di spine lungo i fusti e all'ascella delle foglie, i lunghi peli unicellulari presenti in tutte le parti del capolino e le corolle bilabiate dei fiori del raggio e talvolta anche di quelli del disco. I colori prevalenti delle corolle sono il rosa e il viola; alcune specie producono grandi quantità di nettare, il che ha fatto pensare siano impollinate da colibrì. L'analisi del DNA di Bernadesia e altri generi affini ha segnato un'importante tappa negli studi filogenetici sull'evoluzione delle piante. Nel 1987 un team guidato da Jansen e Palmer scoprì che in questi generi è assente una particolare mutazione (inversione) del DNA, presente invece in tutte le altre Asteraceae (oltre 20,000 specie) e assente nelle altre angiosperme. Ciò significa che questo gruppo (che proprio in base a questa scoperta è andato a costituire la sottofamiglia Barnadesieae - 10 generi e 85 specie) è il più antico delle Asteraceae, precedente la mutazione che si ipotizza sia avvenuta tra 38 e 42 milioni di anni fa. Le Barnadesiae sono piante molto attraenti soprattutto al momento della fioritura, ma sono raramente coltivate al di fiori dei paesi d'origine: piante d'altura delle Ande tropicali di cui si è detto che ogni giorno si sperimenta l'estate e ogni notte l'inverno, vivono in condizioni estreme difficili da riprodurre ad altre latitudini o in serra.
0 Comments
Negli anni che precedono immediatamente la rivoluzione francese, si intrecciano due storie che sembrerebbero non avere nulla in comune. Da una parte c'è il marinaio francese Nicolas Baudin, che l'origine borghese esclude da una carriera di comando nella marina reale; sceglie allora la marina mercantile, tanto più che è nipote di un armatore di Nantes dai traffici non sempre limpidi. Dall'altra parte, c'è una spedizione di botanici austriaci, che fallisce per la defezione di metà dei suoi membri. Finché, nell'isola di Haiti, dove forse è venuto a contrattare un carico di schiavi, il marinaio incontra il capo dei botanici e ne riceve una soffiata che cambierà per sempre la sua vita. Perché le piante non basta raccoglierle, bisogna anche che qualcuno le porti a casa. E magari le faccia arrivare vive. Questa diventa la specialità del capitano Baudin, che comanda una dopo l'altra ben tre Jardinière (ovvero serre viaggianti). Tutte, puntualmente, finite male. Su queste e altre navi navighiamo su e giù per l'Atlantico e l'Oceano Indiano, mentre i botanici erborizzano nelle Americhe, in Sud Africa e a Mauritius. Alla fine, a portare a casa un genere valido sono un austriaco e un francese: il giardiniere viennese Franz Bredemeyer, dedicatario di Bredemeyera (Polygalaceae), e il botanico Pierre André Ledru, dedicatario di Drusa (Apiaceae).  Come un capitano di marina si appassionò di botanica Il 9 termidoro dell'anno VI (27 luglio 1798) la folla parigina assiste a un grandioso spettacolo: muovendo dalla sede del Museo di storia naturale, un corteo di carri ornati di ghirlande raggiunge il Campo di Marte, dove verranno pronunciati numerosi discorsi e i musicisti del conservatorio offriranno un concerto. E' questo il modo scelto dal Direttorio per esporre coram populo i tesori trafugati durante la campagna d'Italia, in un'operazione propagandistica che trasforma un saccheggio in un atto di libertà: quei tesori, anziché essere gelosamente nascosti nei palazzi e nei conventi per il godimento di pochi privilegiati - si proclama - sono ora messi a disposizione di tutti nei musei della Repubblica, per il progresso delle scienze e delle arti. Il corteo è strutturato in tre divisioni: la prima è riservata alla storia naturale, con sei carri carichi di piante e animali esotici; la seconda alla scienza e alla tecnica, con altri sei carri ricolmi di libri, manoscritti, medaglie, spartiti; la terza, il clou dell'intera manifestazione, ai capolavori dell'arte: tra gli altri sfilano la quadriga di san Marco, la Venere capitolina, lo Spinario, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, quadri di Raffaello, Tiziano, Domenichino, Giulio Romano, per un totale di 300 tra statue e dipinti. Se questi ultimi sono stati strappati ai palazzi italiani, non è certo così per molta parte degli oggetti naturali: qualcosa arriva dall'Egitto, dove in quel momento si trova Napoleone, ma il grosso proviene dalle Antille, ed è stato aggiunto al corteo all'ultimo momento, su suggerimento di Antoine-Laurent de Jussieu. In un certo senso, sono anche quelli prede di guerra: è il bottino del viaggio di Nicolas Baudin ai Caraibi, un successo che di lì a un anno garantirà a questo marinaio di lungo corso il comando della più importante missione scientifica della Repubblica: la "spedizione Baudin" nelle Terre Australi. In attesa di raccontarla in un prossimo post, facciamo conoscenza con questo personaggio, le cui vicende si sono curiosamente intrecciate con quelle della "spedizione Märter", promossa dall'Austria di Giuseppe II. Nicolas Baudin (1754-1803) era nato nell'isola di Ré in una famiglia relativamente agiata; prese il mare a quindici anni, a bordo di uno dei vascelli dello zio materno Jean Peltier Dudoyer, un armatore che aveva iniziato la sua carriera armando navi negriere e aveva interessi sia in America sia nell'Oceano indiano; per molti anni Baudin navigò sulle navi sia dello zio sia della Compagnia delle Indie; quando scoppiò la guerra d'indipendenza degli Stati Uniti, Peltier Dudoyer fu uno degli armatori che fornirono navi e rifornimenti alle colonie ribelli; il nipote si trovò coinvolto in prima persona e si comportò con onore, tanto da essere promosso capitano. Nel 1780 gli fu assegnato il comando della fregata Apollon incaricata di trasportare truppe al Capo di Buona Speranza per sostenere gli olandesi contro i britannici; un compito squisitamente militare, tanto che il comandante del porto di Brest gli ritirò il comando per assegnarlo a un nobile (solo questi ultimi potevano diventare ufficiali della marina militare). Baudin per il momento abbandonò ogni speranza di farne parte e continuò a comandare navi mercantili. Nel 1785 come capitano della Caroline, anch'essa armata da Peltier Dudoyer, trasportò in Louisiana l'ultimo gruppo di Acadiani di Nantes; a New Orleans (all'epoca ancora francese, e ancora Nouvelle Orlèans) alcuni mercanti lo incaricarono di trasportare varie merci a Mauritius (all'epoca ancora francese e ancora Ile del France) a bordo della Joséphine (detta anche Pepita o Josepha). Forse per contrattare un trasporto di schiavi dal Madagascar nel viaggio di ritorno, egli fece scalo a Haiti, dove incontrò il botanico austriaco di origine tedesca Franz Joseph Märter (1753-1827). Facciamo un passo indietro per raccogliere questo secondo filone della nostra storia. Nel 1783 il direttore dell'orto botanico di Vienna Nikolaus von Jacquin convinse l'imperatore Giuseppe II ad inviare in America una spedizione alla ricerca di piante esotiche per i giardini di Schönbrunn. La capeggiava appunto Märter, professore di storia naturale al Theresianum, accompagnato da un altro botanico, Matthias Leopold Stupicz, dal pittore Adam Moll e dai giardinieri Franz Boos e Franz Bredemeyer. Imbarcatosi a Le Havre ad agosto, insieme al nuovo console imperiale negli Stati Uniti, il gruppo raggiunse Filadelfia dopo un viaggio di quaranta giorni, in cui sperimentò tre tempeste e Märter scoprì il proprio tallone d'Achille: un irrimediabile mal di mare. A Filadelfia egli incontrò William Bartram e avrebbe voluto senz'altro iniziare le raccolte prima dell'inverno, ma gli mancavano i libri e le attrezzature, che viaggiavano su un'altra nave. Poté così mettersi all'opera solo a novembre. Mentre tutti gli altri raggiungevano Charleston in nave, egli attraversò a cavallo Pennsylvania, Maryland, Virginia e le due Caroline, accompagnato dal medico e zoologo Johann David Schöpf, che aveva partecipato come volontario alla guerra d'indipendenza da parte britannica e aveva deciso di fermarsi nel paese per studiarne la fauna. Arrivato a Charleston nel gennaio 1784, Märter inizialmente pensò di inviare nelle Bahamas Stupicz e un giardiniere, mentre lui con gli altri esplorava le due Caroline e la Florida, ma, rendendosi conto che Stupicz non parlava quasi l'inglese, lo mandò nella Carolina del Nord, dove vivevano numerosi tedeschi. Mentre Moll e Bredemeyer rimanevano a Charleston, egli si imbarcò con Schöpf e Boos per le Bahamas, soffrendo di nuovo atrocemente il mal di mare. Fu così costretto a ritornare a Charleston, mentre nei mesi seguenti Boos, spesso in condizioni difficili, esplorò diverse isole, rientrando a Charleston verso la fine dell'anno. Nel frattempo Bredemeyer era stato inviato a Vienna con un primo trasporto; il viaggio, iniziato nel giugno 1784, si protrasse per cinque mesi con la perdita di molte piante. Poco dopo il suo arrivo, insieme all'aiuto giardiniere Schücht, egli fu rimandato in America per ricongiungersi alla spedizione, la cui situazione si era fatta piuttosto critica. All'inizio del 1785, Boos era a Charleston gravemente ammalato; Moll e Supicz, che in realtà si erano imbarcati proprio nella speranza di emigrare negli Stati Uniti, diedero le dimissioni uno dopo l'altro, per stabilirsi a Charleston, il primo come insegnante di disegno e incisore, il secondo come medico. A sua volta Märter aveva contratto la malaria. A maggio lo lasciò anche Boos, che partì per Europa con una parte delle collezioni: più fortunato di Bredemeyer, ebbe un viaggio breve e senza contrattempi, consegnando piante e animali in perfette condizioni. Poco dopo la sua partenza, Märter si imbarcò per la Martinica, fissata come punto d'incontro con Bredemeyer e Schücht. Ma il mal di mare lo tradì ancora una volta e dovette sbarcare a Guadalupa. Riuscì poi a raggiungere Haiti, dove nell'agosto 1785 finalmente arrivarono anche i due giardinieri. Tutti e tre erano malati; il più grave era proprio Märter, che fu bloccato per sei mesi e a lungo dovette anche essere ricoverato nell'Hôpital de la Charité a Cap-Français. Fu in queste circostanze che conobbe Baudin. Lo sfortunato botanico (che probabilmente lo aveva saputo da Bredemeyer) lo informò che il suo antico compagno Boos era stato inviato ad erborizzare al Capo di Buona Speranza ed era in attesa di un imbarco per Mauritius. Proprio la meta del nostro intraprendente capitano che non perse l'occasione, dirigendosi immediatamente al Capo. Almeno, questa è la storia vulgata: le date non coincidono perfettamente. Comunque, prendiamola per buona. Le collezioni americane di Franz Boos avevano fatto una tale impressione all'imperatore, che aveva deciso che, anziché tornare in America a dare supporto all'inconcludente Märter, era meglio andasse direttamente in Sud Africa, per poi passare a Mauritius. Boos partì da Vienna nell'ottobre 1785 insieme all'aiuto giardiniere Georg Scholl. Dopo un lungo e penoso viaggio, funestato dallo scoppio a bordo di un'epidemia che aveva fatto più di trenta morti, erano arrivati al Capo solo nel giugno 1786; furono generosamente ospitati dal colonnello Gordon, che comandava la guarnigione della Compagnia delle Indie olandesi; egli fece loro conoscere Francis Masson, con il quale esplorarono Swartand e il Karoo, fino ad allora non molto battuto dai botanici europei, raccogliendo non poche novità. Baudin arrivò al Capo nel febbraio 1787 e imbarcò Boos e una parte delle sue collezioni, mentre Scholl, secondo le istruzioni ricevute, rimaneva in Sud Africa. A marzo erano a Mauritius, dove Boos incontrò il governatore Ceré, che era già in corrispondenza con Vienna cui nel 1783 aveva inviato piante e semi. Boos gli consegnò i doni dell'imperatore e si trattenne a lungo a Pamplemousses, stringendo ottime relazioni con i botanici e gli appassionati che ruotavano attorno a quel magnifico orto botanico, ricevendo molte piante provenienti non solo a Mauritius, ma dall'intera Asia. Poté anche visitare l'Île Bourbon (ovvero La Réunion) ed esplorare le montagne dell'interno con il botanico Joseph Hubert. Intanto si era accordato con Baudin per noleggiare la Joséphine per trasportare a Vienna le sue collezioni, rese preziose dai contributi dei nuovi amici delle Mascarene. Nel dicembre 1787 la Joséphine-Pepita (che, tanto per aumentare la confusione, Boos aveva ribattezzato Pepinière, "vivaio") riprese il mare. Come ci informano i giornali dell'epoca, raggiunse il porto austriaco di Trieste il 18 giugno 1788. Il suo carico, che comprendeva anche qualche zebra viva, fece sensazione. Gli animali e le piante presero la via di Vienna, dove rientrò anche Boos. Durante quei lunghi mesi di viaggio, capitano e botanico avevano fatto amicizia. Boos illustrò a Baudin le tecniche migliori per preservare le piante e gli animali durante i lunghi viaggi oceanici; per Baudin fu la scoperta di una nuova vocazione: quella di raccoglitore-naturalista.  Avventure quasi corsare Il riuscito trasporto delle collezioni di Boos era senz'altro un ottimo biglietto da visita; Baudin sperava gli assicurasse il comando di una nuova spedizione di cui si andava vociferando: niente meno che la prima circumnavigazione austriaca del globo. Nel frattempo, al comando della nave commerciale Jardinière (ovvero "serra viaggiante", un nome non scelto a caso, visto che nel vaiggio di ritorno avrebbe dovuto imbarcare Scholl e le sue piante) partì per Canton, non è troppo chiaro se per conto proprio o della Compagnia imperiale delle Indie. Forse temendo guai con l'amministrazione cinese, viaggiava infatti sotto bandiera statunitense. Giunto a Canton, spedì il suo secondo in America per un traffico di pellicce, ma la Jardinière naufragò nelle Marianne settentrionali, di fronte all'isola di Asuncion. E' l'inizio di una serie di vicende rocambolesche: Baudin andò a Mauritius a procurarsi un'altra nave, che battezzò Jardinière II; il nome non portò fortuna: il 15 dicembre 1789 un ciclone colpì l'isola e la nave andò distrutta in porto. Allora Baudin si imbarcò come passeggero su una nave della Compagnia reale delle Filippine; di passaggio al Capo, poté prendere con sé solo una piccola parte delle collezioni di Georg Scholl. La nave era diretta a Cadice, ma non vi giunse mai. Lo scafo era in uno stato così deplorevole che si dovette fare rotta per le Antille e fare scalo a Trinidad, dove la collezione venne sbarcata. Baudin si imbarcò su un'altra nave e arrivò in Martinica, dove scrisse a Vienna per spiegare la situazione e riproporsi come comandante della progettata spedizione in Estremo oriente. Forse era giunta la volta buona. Nel gennaio 1792 la corte di Vienna gli concesse il titolo di capitano della Marina imperiale e gli affidò il comando di una nuova Jardinière che, oltre a prelevare Scholl e le sue collezioni, avrebbe dovuto esplorare le Indie Orientali e la Nuova Olanda (ovvero l'Australia). Per accompagnarlo furono designati Franz Bredemeyer e l'aiuto giardiniere Joseph van der Schot che ad aprile si imbarcarono a Genova alla volta di Malaga. Ma i tempi erano cambiati: in Francia la monarchia era crollata, e pochi giorni dopo la loro partenza, il 20 aprile 1792, la Convenzione dichiarò guerra alla Prussia e all'Impero. Baudin all'improvviso diventava un nemico; raggiunta anch'egli Malaga, dapprima pensò di abbandonare la spedizione e cercò di negoziare il suo rientro nella marina francese; avendo avuto un rifiuto, continuò i preparativi, mentre Austria e Gran Bretagna chiedevano alle autorità spagnole il suo arresto e il sequestro della nave. Nella confusa situazione politica di quei mesi, in cui la Spagna tentava la difficile strada della neutralità, dopo una breve detenzione fu rilasciato e riprese possesso della nave. Lasciati i botanici a terra, il 1 ottobre la Jardinière salpò; ma Baudin, anziché tornare in Francia, cercò di realizzare da solo il programma scientifico inziale. Eccolo al Capo di Buona Speranza, dove caricò una parte delle collezioni di Scholl (che si accorse troppo tardi che ora la nave batteva bandiera francese); quindi si diresse verso la Nuova Olanda ma incappò in due cicloni successivi che la costrinsero ad attraccare a Bombay per riparazioni. La navigazione volse ora verso occidente, toccando il Golfo persico, il mar Rosso, la costa orientale dell'Africa, dove vennero raccolti esemplari di animali e piante, e terminò di fronte a Table Bay, dove la terza Jardinière si arenò durante una tempesta. Baudin si salvò e, a quanto pare, riuscì a recuperare almeno qualcosa delle sue raccolte, visto che anche queste finirono a Trinidad, dove passò durante il viaggio di ritorno, passeggero di una nave americana. Rientrato in Francia, nel marzo 1796 Baudin incontrò Antoine Laurent de Jussieu e gli suggerì di organizzare per conto del Museo nazionale una spedizione a Trinidad per recuperare le collezioni (sue o austriache, ormai poco importava...). Il direttorio accettò la proposta e il 30 settembre 1796 Baudin partì alla volta delle Antille al comando della Belle-Angelique. Lo accompagnava una piccola équipe scientifica: il botanico André Pierre Ledru, il giardiniere Anselme Riedlé, gli zoologhi René Maugé e Stanislas Levillain. Ma la nave era così inadatta a tenere il mare che alle Canarie Baudin dovette abbandonarla e sostituirla con una nuova nave, la Fanny, con la quale nell'aprile 1797 raggiunse Trinidad. Qui scoprì che l'isola era da poco passata nelle mani degli inglesi, che rifiutarono di consegnargli le collezioni. Baudin non era tipo da tornare in Francia a mani vuote. Nelle Antille c'erano diverse isole neutrali, come la portoghese São Tomé e la danese Saint Croix. Baudin e i suoi naturalisti le esplorarono e fecero buone raccolte di piante e animali; quindi a Saint Croix la Fanny venne sostituita con un vascello più agile, ribattezzato Belle-Angelique, a bordo della quale visitarono Porto Rico, quindi proseguirono per la Francia, dove giunsero nel giugno 1797, pochi giorni prima del grande corteo da cui abbiamo preso le mosse, giusto in tempo per esibire i loro trofei nella divisione di storia naturale. Quello stesso giorno, anche grazie ai buoni uffici del cugino Marie-Etienne Peltier - che dal 1794 batteva i mari come "corsaro della Repubblica - Baudin ricevette il comando della nave corsara Virginie; il 4 agosto fu reintegrato nella marina militare con il grado di capitano di vascello, e partecipò ad alcuni episodi della guerra contro l'Inghilterra. Ma la vera rivincita se la sarebbe presa nell'ottobre 1800, quando gli venne affidato il comando della grandiosa spedizione nelle Terre australi, più nota come "spedizione Baudin". In queste vesti lo ritroveremo in un prossimo post. E con lui tre dei naturalisti della Belle Angélique che lo seguirono nella nuova avventura, per perdervi la vita.  Epilogo: e vissero felici e contenti Molti sono i personaggi di questa storia affollata ad aver ricevuto l'onore della dedica di un genere botanico, anche se ne rimane valido uno solo. Ad aprire le danze è lo stesso capitano Baudin. Per ben due volte, De Candolle gli dedicò un genere Baudinia, ma entrambi sono ridotti a sinonimi: Baudinia (Myrtaceae) di Melaleuca e Baudinia (Goodeniaceae) di Scaevola. Si consola con l'eponimo di Limonium baudinii, una specie della Tasmania raccolta durante la sua celebre spedizione. Veniamo ora ai suoi compagni austriaci, raccontando ancora qualcosa delle loro vite dopo il turbinoso incontro con il capitano francese. L'ottimo Franz Boos (1753 - 1832) dopo il ritorno a Vienna fece carriera. Nel 1787, quando von Jacquin lasciò l'incarico, fu nominato direttore dei giardini e dell'orto botanico di Schönbrunn, cui nel 1790 si aggiunse la direzione del serraglio imperiale e del cosiddetto "Giardino olandese". Fino al ritiro nel 1827, continuò anche ad essere capo giardiniere e nel 1816 insieme al figlio Joseph Boos, anch'egli un valente professionista, pubblicò un catalogo delle piante selvatiche e coltivate di Schönbrunn. Nel 2001 il botanico austriaco Speta ha voluto ricordarlo con il genere Boosia, generalmente non accettato (è sinonimo di Drimia). Gli è stata anche dedicata una via nel quartiere di Hietzing. Dopo aver visto involarsi una parte delle sue collezioni per l'inganno di Baudin, Georg Scholl (1751-1831) rimase ancora in Sudafrica per diversi anni (il suo soggiorno ne durò in tutto dodici), ancora ospite del colonello Gordon. Le sue raccolte diventavano sempre più imponenti e sempre più difficili da trasportare, come ci informa Francis Masson nelle sue lettere a Joseph Banks. Di tanto in tanto, riusciva a spedire a Vienna bulbi e semi, tra cui quattro spedizioni tra il 1790 e il 1792 che, attraverso il console austriaco in Olanda, raggiunsero Vienna via Amsterdam. Solo nel 1799 gli fu possibile lasciare il paese, ritornando a Vienna con la collezione di piante vive sudafricane più importante d'Europa (ora capiamo meglio perché Banks, appena tornata la pace, si sia affrettato ad inviare al Capo il suo raccoglitore James Bowie). L'esemplare più sensazionale era una Fockea capensis, una specie così rara che a lungo si credette fosse estinta in natura. E' tuttora possibile ammirarla nella serra di Schöbrunn, grazie alla previdenza di un giardiniere che, durante la seconda guerra mondiale, lo salvò portandoselo a casa. Con i suoi 600 anni valutati, è considerata la più vecchia pianta in vaso del mondo. Quanto a Scholl, tornò a lavorare a Schönbrunn, quindi dal 1802 divenne capo giardiniere al Belvedere. Nel 1811 il figlio di von Jacquin gli dedicò Schollia (sinonimo di Hoya) e sempre nel 2001 Speta Geschollia (ugualmente sinonimo di Drimia). Lo ricorda l'eponimo dell'Aizoacea sudafricana Ruschia schollii. Nonostante la grande ricchezza e l'importanza storica delle collezioni di Boos e Scholl, la maggior gloria botanica è però riservata a Franz Bredemeyer (1758-1839), ricordato da un genere valido e da una decina di eponimi. Lo abbiamo lasciato ad Haiti al momento del ricongiungimento con Märter. Nel febbraio 1786 questi inviò lui e Schücht in Venezuela, dove contava di raggiungerli appena recuperata la salute. I due passarono da Porto Rico, che furono i primi botanici a visitare, quindi visitarono Caracas e il porto di La Guaira, dove avrebbe dovuto raggiungerli Märter. Nel frattempo questi aveva di nuovo cambiato idea e li richiamò, ma i due giardinieri ormai agivano in modo indipendente (e molto più efficace). Pur dovendo fare i conti con difficoltà economiche, carte sbagliate e i sospetti delle autorità spagnole, che temevano fossero spie, decisero di esplorare il più possibile quel paese tanto affascinante quanto quasi inedito per la botanica. Acquistarono dei muli e assunsero un assistente; a settembre viaggiarono a est di Caracas, visitando Guatire, Caucagua e la foresta pluviale nei pressi di Capaya (nell'attuale stato di Miranda); da marzo a maggio dell'anno successivo si spostarono verso ovest nell'attuale stato di Aragua e nei Llanos. Nell'aprile del 1788 si imbarcarono a La Guaira alla volta di Curaçao, dove noleggiarono la goletta americana The Commerce che li avrebbe riportati in Europa insieme a molte piante che fecero sensazione per l'aspetto decisamente esotico e tropicale. Li aveva preceduti di circa un anno lo stesso Märter. Invece di raggiungere i due giardinieri in Venezuela, era passato in Giamaica; qui aveva visitato le Blue Mountains, dove lo incontrò il botanico svedese Olof Schartz; secondo la testimonianza di quest'ultimo, era di nuovo malato, nonché depresso per la disgrazia in cui era caduto presso la corte di Vienna, che gli attributiva tutta la colpa del fallimento della spedizione. Nel maggio 1787 imbarcò totalmente a sue spese una collezione che secondo le sue dichiarazioni ammontava a non meno di 3000 esemplari, tra cui 1800 piante vive. Giunto a Londra, le fece svernare in serra; qui e in Olanda acquistò anche molti uccelli impagliati. Poté così presentarsi a testa alta all'imperatore che dovette perdonarlo, se lo nominò professore di botanica e storia naturale all'Università dei Paesi Bassi austriaci, fondata l'anno prima. Su sua raccomandazione, Bredemeyer venne nominato direttore dell'annesso orto botanico. Per entrambi, un incarico di brevissima durata. La rivoluzione del Brabante dell'ottobre 1789 li costrinse alla fuga. Una nuova occasione si presentò per Bredemeyer quando, come abbiamo anticipato, venne nominato naturalista della missione della terza Jardinière. Già sappiamo che l'avventura sfumò e il povero giardiniere rimase a terra, mentre Baudin partiva senza di lui. Non gli restava che tornare a Vienna. Nel 1793 divenne supervisore dei frutteti e dei parchi di Schönbrunn; in seguito si occupò dei giardini degli arciduchi, che nel 1802 accompagnò ad erborizzare in montagna. Al pensionamento di Boos, divenne a sua volta direttore dei giardini e del serraglio di corte. Sotto la sua direzione, furono allestite la "Casa delle giraffe" e una collezione di piante parassite. Divenuto consigliere imperiale e membro di molte società orticole, inclusa la Horticultural Society di Londra, morì ottantenne nel 1839. Le specie tropicali raccolte in Venezuela divennero una delle maggiori glorie delle serre di Schönbrunn, destando l'ammirazione di Humboldt, che fu spinto anche da quello spettacolo al suo viaggio in Sud America, dove non avrebbe mancato di ripercorrere le orme di Bredemeyer e Schücht. Willdenow, il direttore dell'orto botanico di Berlino, conosceva bene Bredemeyer, delle cui note si servì ad esempio per descrivere le piantagioni di cacao del Venezuela, ombreggiate da alberi di bucaré (Erythrina poeppigiana) dagli smaglianti fiori rossi tra cui volavano eserciti di pappagalli dalle piume multicolori. Fu sicuramente lui a suggerire l'acquisto dell'erbario di Bredemeyer, 180 fogli del quale si trovano ora al Museo botanico di Berlino-Dahlem. Non stupisce dunque che sia stato proprio Willdenow a dedicargli il genere Bredemeyera, sulla base di una pianta raccolta da Franz Bredemeyer nei pressi di Caracas. Oggi a questo genere della famiglia Polygalaceae sono attribuite 18 specie, distribuite dal Messico al Paraguay settentrionale. Sono liane legnose o piccoli arbusti con foglie semplici, fiori con cinque sepali, due esterni e tre interni, con ali petaloidi; la corolla ha cinque petali (due laterali, la carena, e due rudimentali): i frutti sono capsule con semi protetti da un arillo con peli più lunghi dei semi stessi. La specie tipo descritta di Willdenow B. floribunda, diffusa dal Venezuela al Paraguay, presenta cospicui grappoli di fiori bianchi; è una specie officinale, con proprietà disintossicanti, cui la medicina tradizionale attribuisce efficacia contro i morsi dei serpenti. Tra le diverse specie che si fregiano dell'eponimo bredemeyeri o bredemeyerianus, vorrei ricordare almeno la spettacolare Bomarea bredemeyeriana: con i suoi grappoli di fiori a campana aranciati fu probabilmente una delle piante la cui vista colpì al cuore Humboldt. E Märter? forse qualcuno si domanderà. Sappiamo che la collezione d'uccelli fu da lui donata alla loggia massonica Zur true Eintracht (frequentata anche da Mozart e Schikaneder che ne avrebbero tratto ispirazione per l'uccellatore Papageno del Flauto magico) e andò dispersa quando il cattolicissimo imperatore Francesco bandì la massoneria nel 1794. Non ci è noto il destino della collezione botanica, forse meno favolosa di quanto Märter pretendesse. In condizione di professore "giubilato", ovvero in pensione, nel 1796 egli pubblicò una seconda edizione assai accresciuta di un libro sugli alberi austriaci che aveva pubblicato prima della spedizione (Verzeichniß der östreichischen Bäume, Stauden und Buschgewächse); l'anno successivo fu la volta di una monografia sulla batata dolce. Nel 1797, quando venne riaperta l'Accademia dei cavalieri teresiani, gli fu assegnata la cattedra di silvicoltura. La coltivazione di alberi da frutta e da legname era infatti ormai il suo interesse principale, tanto che nel 1799 aprì un vivaio con 300 piante da frutto; l'avrebbe venduto nel 1806 per motivi di salute, così come nel 1803 per la stessa ragione aveva dato le dimissioni dal Theresianum. Per altro morì più di vent'anni dopo, nel 1827, a 73 anni. Giuseppe II lo considerava streitsüchtig, ovvero polemico. A me pare piuttosto inconcludente. Sta di fatto che nessun botanico ha mai pensato di dedicargli, nonché un genere, neppure una specie. Fu invece nientemeno che de Candolle a dedicare un genere al solo botanico francese di questa storia, André Pierre Ledru (1761-1825), uno dei naturalisti della Belle Angélique. Sappiamo che era un sacerdote, da poco consacrato quando scoppiò la rivoluzione, cui aderì senza esitare, prestando giuramento alla Costituzione civile del clero. Nella fase più convulsa della controrivoluzione vandeana, come prete giurato si trovò in pericolo di vita; si trasferì così a Parigi, dove presumibilmente entrò in contatto con gli ambienti del Museum national e in particolare con Antoine Laurent de Jussieu (nel suo erbario si trovano esemplari donatogli da lui, comprese alcune piante coltivate al Trianon da suo zio Bernard de Jussieu). Grazie a queste frequentazioni, fu scelto come botanico della spedizione nelle Antille, durante la quale fece notevoli raccolte a Tenerife, Porto Rico e in diverse isole. Al suo rientro, tornò in provincia, divenendo insegnante, anche se non abbandonò mai del tutto la botanica, visto che allestì un orto botanico privato e possedeva un notevole erbario, ora conservato al Museo di Le Mans. De Candolle, che all'epoca lavorava ancora al Museum national, gli dedicò Drusa (Apiaceae), sulla base di un esemplare raccolto da Ledru (che egli definisce "ragguardevole botanico") a Tenerife, lungo la strada che conduce a La Orotava. La sua unica specie D. glandulosa è una piccola rampicante pelosa e appiccicosa, con fiori minuscoli e curiosi frutti dotati di ali dentate. Singolare la sua distribuzione: oltre che nelle Canarie e in Marocco (dove si ritiene introdotta), si trova in alcune stazioni della catena Cal Madow in Somalia. Negli anni decisivi in cui il Chelsea Physic Garden, grazie alla generosità di Hans Sloane e alla sapienza orticola dell'inarrestabile capo giardiniere Philip Miller, si trasforma da hortus medicus, ancora per lo più riservato alle piante medicinali, in un grande orto botanico di acclimatazione delle esotiche, a guidarlo come dimostratore e praefectus è il farmacista Isaac Rand, cui si devono una gestione accorta, i primi cataloghi, l'apertura agli artisti che vengono a ritrarre dal vivo le piante delle sue aiuole. Lo ricorda il genere Randia (Rubiaceae), omaggio di Houstoun validato da Linneo. 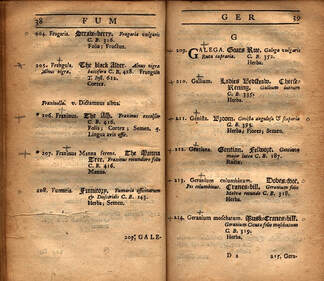 Una gestione accorta ed efficente Nel 1718, alla morte di James Petiver, prese il suo posto come dimostratore del giardino dei farmacisti di Chelsea il suo collega Isaac Rand (1674–1743) che già da qualche anno lo affiancava nelle attività didattiche. Rand era figlio d'arte e godeva di ottima reputazione come botanico. Il padre James Rand faceva parte della commissione che nel 1674 aveva deciso di proteggere il giardino con un muro di cinta; il figlio ne rilevò l'attività e intorno al 1700 gestiva una farmacia sull'Haymarket. Doveva essersi appassionato di botanica durante l'apprendistato, ed è citato da diversi botanici della generazione precedente per il suo occhio di lince, capace di scovare piante fino ad allora mai notate anche in zone molto battute. In Almagesti botanici mantissa (1700) Plukenet lo ricorda per aver scoperto nei Tothill Fields a Westminster la pianta che oggi si chiama Rumex palustris e lo definisce "farmacista londinese diligentissimo indagatore delle piante e botanico di belle speranze". A Doody invece segnalò un'altra specie di Rumex, R. maritimus, che cresceva nei luoghi umidi vicino a Burlington House. Adam Buddle gli attribuisce la scoperta di Mentha dumetorum (sin. M. pubescens) lungo le rive di certi stagni presso Marybone e Petiver quella di Oxybasis glauca (sin. Chenopodium glaucum) che battezzò in suo onore "blito quercino di Rand". Di Buddle e dei colleghi Doody e Petiver doveva essere compagno di scorribande botaniche, che evidentemente avevano per teatro la stessa Londra e le immediate vicinanze, quelle dove insieme allo stesso Petiver guidava gli herborizing degli apprendisti farmacisti. Nella società dei farmacisti divenne presto un elemento di primo piano; nel 1707 lo troviamo tra i membri della commissione incaricata di valutare il mantenimento del giardino, per fare sopravvivere il quale fece una donazione e affittò persino una parte del terreno. Assistente e successore di Petiver, si trovò poi alla guida del giardino in un momento decisivo della sua storia. Come ho raccontato in questo post, nel 1722 sir Hans Sloane prese il Physic Garden sotto le sue ali protettrici, cedendo in perpetuo alla Worshipful Society il terreno del giardino in cambio di un affitto simbolico e della fornitura di 50 esemplari d'erbario alla Royal Society. Lo stesso anno, su suggerimento dello stesso Sloane, fu assunto anche Philip Miller. Fu Rand a gestire il delicato cambio di gestione, e di vocazione, del giardino, che, da orto dei semplici dove si coltivava anche qualche esotica, in seguito all'obbligo di fornire ogni anno cinquanta esemplari di specie esotiche preferibilmente inedite veniva trasformato in giardino botanico di acclimatazione che guardava sempre più ai modelli di Leida e Parigi. Nel 1725 Rand divenne il primo direttore ufficiale del Chelsea Physic Garden e dal 1733 portò il pomposo titolo Horti Praefectus et Praelector Botanicus Chelseiani, in cui si uniscono le funzioni amministrativa e didattica: come già Petiver prima di lui, suo compito era infatti, oltre a guidare gli herborizing, tenere almeno due lezioni in horto al mese nella stagione estiva. Fu incaricato di stendere un progetto di miglioramento del giardino; approvato dalla Società dei farmacisti, ottenne il sostegno finanziario di Sloane, che convinse sia il Collegio dei medici sia la Royal Society a versare un contributo; ne seguirono grandi trasformazioni, con la costruzione di un’aranciera, che ospitava anche una biblioteca e una sala per le riunioni, di alloggi per il prefetto e il capo giardiniere, di una serra fredda e di due serre riscaldate con un sistema di riscaldamento dal basso. La prima pietra di questi nuovi edifici fu posta ovviamente da Sloane nel 1732. Tra i compiti di Rand c'era anche aumentare e documentare le collezioni. Teneva i contatti con altri orti botanici, in particolare con quello di Leida, con il quale intensificò il programma di scambi. Era lui a occuparsi della preparazione degli esemplari da consegnare alla Royal Society, il primo gruppo di cinquanta dei quali, debitamente etichettato, fu presentato nel marzo del 1723. Gli si deve il primo catalogo, 57 anni dopo la fondazione del giardino; pensato per la formazione degli apprendisti, elenca 518 specie officinali, specificando quali parti vanno utilizzate. Meno legato alla originaria vocazione di hortus medicus è il secondo catalogo, pubblicato nel 1739, in cui vengono elencate circa mille piante raggruppate in 749 generi Rand capì anche quanto potesse essere utile documentare le piante affiancando all'ormai tradizionale erbario immagini di buona qualità. Quando il medico Alexander Blackwell finì in carcere per debiti, incoraggiò la moglie Elizabeth a stabilirsi vicino al giardino e a frequentarlo liberamente, per ritrarre le piante esotiche dal vivo (il risultato fu A Curious Herbal che permise alla coppia di uscire dalla loro situazione disperata). Un altro artista protetto da Rand fu il tedesco Dyonisius Ehret che si legò anche più a Chelsea quando sposò la cognata di Philip Miller. Non ultimo merito di Rand fu riuscire a tenere a bada l'irrefrenabile capo giardiniere. Dopo la sua morte (1743) e quella dell'immediato successore Joseph Miller (prefetto dal 1743 al 1746), la Società dei farmacisti rinunciò a nominare un prefetto, affidando la gestione a un comitato che ben poco poteva di fronte all'esuberanza del testardo Miller. Rand si ricordò dell'amato giardino anche nel testamento, lasciandogli in eredità la sua biblioteca botanica, 22 volumi di erbario e un lascito di 50 sterline annue destinato al rinnovamento dell'erbario del dimostratore con esemplari freschi.  Gardenie spinose Rand era amico di Mark Catesby e fu tra i sottoscrittori di Natural History of Carolina; doveva godere almeno della stima di William Houstoun visto che - sebbene ancora vivo - risulta tra i dedicatari di uno dei 14 nuovi generi creati dal chirurgo scozzese in Plantae Houstonianae. Randia (Rubiacaeae) fu poi validato da Linneo; in precedenza un vasto genere pantropicale, è stato ristretto fondamentalmente all'America tropicale e subtropicale, dagli Stati Uniti meridionali all'Argentina, con un centinaio di specie di arbusti, liane e piccoli alberi. Continuano a farne parte anche tre specie australiane (le altre sono state state trasferite al genere Atractocarpus) che però appaiono abbastanza diverse da quelle americane. Per lo più dioiche, con fiori dei due sessi su piante diverse, sono arbusti o piccoli alberi sempreverdi o caducifogli, spesso armati di spine, con foglie opposte o raggruppate in verticilli agli apici dei rami. I fiori, uniti in cime o grappoli all'ascella delle foglie o solitari all'apice di brevi rametti, hanno calice troncato, dentato o lobato, tubo corollino cilindrico con cinque lobi, che in boccio si presenta ritorto. I frutti sono bacche succulente che contengono molti semi. Il centro di diversità è probabilmente il Messico, con una quarantina di specie. Ma qualcuna si spinge anche negli Stati Uniti meridionali, come R. aculeata, una delle più diffuse, con un areale che dalla Florida raggiunge la Colombia, passando per il Messico e le Antille. E' un piccolo albero, sempreverde o deciduo in base alla piovosità, con rami quasi orizzontali, molto spinosi, foglie verde brillante quasi ovali, bei fiori bianchi a stella con cinque lobi seguiti da bacche tondeggianti biancastre a maturazione (da cui il nome white indigoberry), molto apprezzate dagli uccelli, la cui polpa in passato veniva usata per produrre un colorante blu. Tra le australiane, merita una segnalazione R. moorei, un arbusto o alberello originario dell'estremità nordorientale del Nuovo Galles del Sud e delle aree adiacenti del Queensland. Anch'essa è spinosa, a volte anche lungo il tronco, ha foglie largamente ovoidali con apice acuto. Porta fiori bianchi molto profumati, raggruppati in gruppi di tre all'apice dei rami o lungo i rami stessi che le hanno guadagnato il nome di spiny gardenia, "gardenia spinosa". Le bacche, dapprima giallo aranciato, diventano nere a maturazione. Rara, è minacciata dalla progressiva distruzione del suo ambiente naturale, il sottobosco della foresta pluviale su suolo basaltico. La sua appartenenza al genere Randia è per altro discussa e ne è stato proposto lo spostamento in Xeromphis. Altre informazioni nella scheda. Si ritiene generalmente che il primo occidentale a creare una raccolta sistematica di piante cinesi sia stato il chirurgo e mercante James Cuninghame, che negli anni a cavallo tra Seicento e Settecento operò dapprima ad Amoy quindi a Chusan, raccogliendo circa 600 specie, diverse delle quali furono prontamente pubblicate da James Petiver e Leonard Plukenet. La penetrazione del commercio inglese in estremo oriente era ancora agli inizi, e presto gli inglesi abbandonarono questi avamposti dove gli scarsi guadagni non erano tali da compensare la rapacità dei funzionari cinesi. Dopo la relativamente fortunata parentesi cinese, per Cuninghame iniziarono i guai: inviato a Pulo Condore in Cocincina, fu tra i pochi sopravvissuti a un massacro e dovette subire due anni di penosa prigionia; né più solida era la situazione dell'emporio della compagnia a Banjarmasin nel Borneo, diretto per poche settimane da Cuninghame prima che fosse distrutto e gli inglesi espulsi del paese. Allo sfortunato chirurgo-mercante non rimase che ritornare in patria; ma non vi arrivò mai, probabilmente perendo in mare. Robert Brown volle ricordarlo dedicandogli una delle sue scoperte cinesi: lo splendido "abete cinese", ovvero Cunninghamia lanceolata. Che deve però dividere con un quasi omonimo, il "raccoglitore del re" Allan Cunningham. 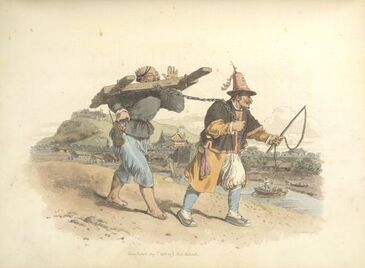 Una sequela di disastri Richard S. Morel l'ha soprannominato "il botanico più sfortunato dell'Asia"; in effetti, anche se sventure di ogni genere erano il corollario abituale delle vite dei cacciatori di piante dei tempi eroici, è difficile trovare una sequela di catastrofi che eguagli quelle che costellarono i viaggi di James Cuninghame (o Cunningham, ca. 1665–1709). Molto poco sappiamo della sua giovinezza. Cuninghame era scozzese e doveva essere nato intorno al 1665, visto che nel 1686, quando si immatricolò alla facoltà di medicina di Leida, risulta ventunenne. Presumibilmente non si laureò: infatti era chirurgo e non medico, ma non sappiamo né dove né come completò gli studi. Nella seconda metà del 1696 era di ritorno da un viaggio nelle Indie orientali, nel corso del quale doveva aver già raccolto qualche curiosità naturale. Fu così che entrò in contatto con Hans Sloane, all'epoca segretario della Royal Society, e strinse amicizia con James Petiver. Avendo saputo che si preparava a ripartire per la Cina, quest'ultimo gli consegnò una lista di piante desiderabili e gli raccomandò di cercare di procurarsi disegni o pitture di piante cinesi, nonché di raccogliere per lui ogni tipo di curiosità. Cuninghame lasciò l'Inghilterra alla fine del 1697, presumibilmente a bordo della Tuscan, che non apparteneva né alla Compagnia delle Indie né alla rivale New Company, ma a qualche mercante indipendente, i cosiddetti interlopers "intrusi" (si è fatto il nome di Henry Gough). Insieme a un'altra nave di cui non conosciamo il nome, nel gennaio 1698 la Tuscan fece scalo nell'isola di La Palma nelle Canarie, dove Cuninghame fece le sue prime raccolte (circa 150 esemplari, un decimo della flora dell'isola) e si produsse un grave incidente. Una parte dei marinai si ammutinò e disertò; per cercare di catturarli, il capitano inglese usò le maniere forti, finendo per scontrarsi con le autorità spagnole, con il risultato che la nave fu posta sotto sequestro e la ciurma messa agli arresti. Solo dopo qualche giorno, vennero rilasciati e la Tuscan poté riprendere il mare. A metà febbraio passarono l'equatore, quindi doppiarono il Capo di Buona Speranza, proseguendo senza fare scali fino a Batavia, dove gettarono l'ancora a giugno. Cuninghame ne approfittò per raccogliere altre 121 piante. A luglio erano ad Amoy (oggi Xiamen), uno dei pochi porti cinesi aperti agli occidentali. Il soggiorno nell'isola di Amoy si protrasse per sei mesi. Cuninghame (che era qui in veste di mercante, non di chirurgo) trovò il tempo per osservare e descrivere nel suo diario le tecniche di fabbricazione della carta, dell'ottone, del colorante rosso estratto dai semi di Gardenia jasminoides, l'estrazione del salnitro, i nidi commestibili di uccelli e l'ambra grigia. Ovviamente continuò le raccolte, mettendo insieme esemplari d'erbario di 176 specie e semi di 84. Inoltre raccolse una quarantina di "Miscellanea", incluso un esemplare del leggendario "agnello di Tartaria" o barometz segnalando che si trattava della radice di una felce (oggi identificata come Cibotium barometz). Infine commissionò a un artista locale circa 800 acquarelli della flora di Amoy. Di ritorno in Inghilterra verso la metà del 1699, egli poté presentare questo bottino ai suoi amici e ne fu premiato con l'ammissione alla Royal Society. Dopo meno di sei mesi, era di nuovo in partenza, questa volta come chirurgo di bordo della Eaton, una nave della Compagnia delle Indie inviata nell'isola di Chusan (oggi Zhoushan) nella speranza di crearvi una stazione commerciale. Durante il viaggio, la nave dovette fare scalo sia all'isola dell'Ascension, sia al Capo, visto che nell'erbario di Cuninghame si trovano esemplari provenienti da entrambe le località. Anche a Chusan egli continuò alacremente la sua attività di raccolta, estesa anche alle vicine Crocodile Islands; inviò inoltre alla Royal Society alcune lettere poi pubblicate sulle Philosophical Transactions, su argomenti come la coltivazione del tè o certi coralli e altre curiosità sottomarine. Nel 1702 la Compagnia delle Indie decise di abbandonare l'emporio di Chusan, che si era mostrato poco redditizio a causa dei forti dazi; Cuninghame, che doveva essersi ben comportato, fu promosso capo in seconda e inviato nell'isola di Pulo Condore (oggi Côn Sơn) nel Vietnam meridionale per aprirvi un insediamento. Venne costruito un forte e per proteggerlo furono ingaggiati mercenari Makassar. Nel marzo 1705 questi ultimi si ammutinarono, incendiarono la stazione e uccisero sedici uomini che cercavano di spegnere le fiamme. Gli inglesi chiesero l'aiuto delle autorità locali, ma queste, dopo aver catturato e giustiziato i Makassar, si rivolsero contro i britannici, completando il massacro. Solo Cuninghame e pochi altri sopravvissero. Allo sfortunato naturalista, ferito, fu imposta la gogna (kang) e fu trascinato di fronte alle autorità per una sorta di processo. Tre i capi d'accusa: aver stabilito l'insediamento di Pulo Condore contro la volontà del re di Cocincina; non aver presentato a quest'ultimo un tributo adeguato; essere in comunicazione segreta con la Cambogia, con cui la Cocincina era in guerra. Ogni difesa fu inutile; per due anni egli venne tenuto prigioniero con appena il necessario per sopravvivere. Rilasciato nell'aprile 1707, poté raggiungere Batavia. Forse per ricompensarlo di tante sofferenze, la Compagnia lo inviò a Banjarmasin in Borneo come capo di quella stazione commerciale. Tre settimane dopo il suo arrivo, anche quest'ultima venne attaccata e distrutta, sebbene con perdite umane minori rispetto a Pulo Condore, e la Compagnia delle Indie venne espulsa dal Borneo. A Cuninghame non restava che rientrare in Inghilterra. Nel gennaio 1709 scrisse l'ultima lettera a Petiver e Sloane, annunciando il suo rientro. Tuttavia non giunse mai a casa: probabilmente morì durante il viaggio di ritorno. Invece i manoscritti e le raccolte arrivarono sani e salvi a Londra. 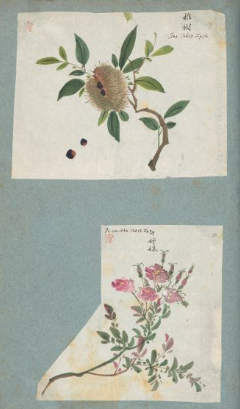 Una collezione di grande importanza storica A parte qualche esemplare occasionale, era la prima volta che un naturalista di valore faceva raccolte sistematiche in Cina. Nel complesso, gli esemplari inviati da Cuninghame ai suoi corrispondenti londinesi (in primo luogo Petiver e Sloane, ma anche il rivale Plukenet) ammontano a circa 600; vista la loro novità, Petiver e Plukenet fecero a gara per pubblicarli quanto prima. Tra le circa 1000 specie descritte da James Petiver nelle centurie dei Musei Petiveriani (1696-1703) figurano una cinquantina di esemplari raccolti da Cunninghame; accanto alle piante troviamo serpenti, conchiglie, farfalle e altri insetti. Nel 1703, nelle Philosophical Transactions lo stesso Petiver pubblicò un resoconto su una settantina di piante raccolte di Cunninghame a Chusan; infine in Gazophylacii naturae (1702–09), ne descrisse un'altra ventina, insieme a conchiglie raccolte all'Ascension e Pulo Condore, falene, coleotteri e un millepiedi delle Indie Orientali. Ancora più ampio è l'utilizzo dei materiali di Cunninghame da parte di Plukenet. In Amaltheum botanicum vengono descritte circa 400 piante risalenti alle sue raccolte di Chusan, circa metà delle quali sono anche raffigurate nel terzo volume di Phytographia. Infine, nel terzo volume di Historia Plantarum, John Ray descrisse 22 specie raccolte da Cunninghame ad Amoy. Tra le specie più notevoli, tra gli alberi troviamo in primo luogo quella destinata ad immortalare il nome di Cunninghame, Cunninghamia lanceolata, e Cryptomeria japonica; tra gli arbusti, Camellia japonica, Loropetalum chinense, Chimomanthus praecox, Hibiscus tiliaceus e Abelmoschus manihot, nonché il nespolo giapponese Eriobotrya japonica (recentemente riclassificata come Rhaphiolepis bibas). Grazie ai semi inviati a Petiver, ma anche a Uvedale, qualche specie dovette essere introdotta in coltivazione; potrebbe essere il caso di due specie di crisantemi osservati a Chusan. Gli erbari e la collezione di acquarelli, che Petiver definiva "herbarium nostrum sinicum pictum", dovettero passare a Petiver, e dopo la morte di questi, essere inglobati nelle collezioni prima di Sloane, poi del British Museum. Sotto il titolo Drawings of Chinese Flowers, Plants, and Fruits, in colours, by a native artist, at Emuy, i dipinti sono oggi custoditi alla British Library; recentemente digitalizzati, sono consultabili a questo indirizzo.  Un genere per due Nel 1791 si ricordò di questo sfortunato pioniere dello studio della flora cinese J. C. D. von Schreber, dedicandogli Cunninghamia (Rubiaceae). Trattandosi di un nome illegittimo e superfluo, non viene preso in considerazione, al contrario del secondo genere Cunninghiamia (Cupressaceae) creato nel 1826 da Robert Brown. In una pubblicazione più tarda, quest'ultimo ne spiega chiaramente la motivazione: "Il genere deve essere denominato Cunninghamia, per commemorare i meriti del sig. James Cunningham, un eccellente osservatore ai suoi tempi, da cui questa pianta fu scoperta"; ma aggiunge: "e in onore del sig. Allan Cunningham, l'assai meritevole botanico che accompagnò il sig. Oxley nella sua prima spedizione nell'interno del Nuovo Galles del Sud, e il capitano King in tutti i suoi viaggi di ricognizione della costa della Nuova Olanda". Insomma, Brown prese due piccioni con una fava e dedicò Cunninghamia a due differenti botanici quasi omonimi. Sul secondo, assai importante per la storia dell'esplorazione della flora australiana, sarà necessario tornare in altri post. Per ora, soffermiamoci sull'interessantissimo genere Cunninghamia. Con due specie, C. lanceolata, originaria della Cina meridionale, e C. konishii, forse endemica di Taiwan, ma presente anche in Indocina - ma per molti si tratta di una varietà della precedente, C. lanceolata var. konishii-, è considerato il genere più primitivo tra le Cupressaceae, tanto che alcuni botanici l'hanno assegnato a una famiglia propria (Cunninghamiaceae). Sono alberi di notevoli dimensioni (anche più di 50 metri), di portamento conico e piramidale, con rami tendenzialmente orizzontali ma pendenti alle estremità. Gli aghi, piatti, coriacei, verde scuro o glauco, si dispongono a spirale lungo i rami; la pagina inferiore (e talvolta anche quella superiore) è caratterizzata da due bande di stomi bianche o verde chiaro. Monoiche, hanno fiori maschili cilindrici raccolti in amenti all'estremità dei rami; quelli femminili sono strobili giallo-verdastro lunghi circa un cm. I frutti sono coni verdastri, da ovali a globosi, ricoperti da scaglie disposte a spirale. In Cina C. lanceolata è molto apprezzata per il legname, leggero, durevole, profumato e non attaccato dai parassiti. La sua coltivazione è anzi in costante crescita, andando a costituire circa un terzo delle piantagioni di alberi da legname e un quarto della produzione di legname della Cina. Introdotto in occidente a inizio Ottocento da William Kerr, in Europa rimane una pianta per intenditori, presente in pochi parchi e arboreti. Altre informazioni nella scheda. In anni decisivi per la storia della botanica inglese, tra fine Seicento e inizio Settecento, il farmacista James Petiver riesce a conquistare prestigio nella società colta grazie alla sua formidabile collezione di esemplari d'erbario, conchiglie, insetti, fossili e così via, seconda solo a quella del ben più ricco Hans Sloane. Raggiunge l'intento tessendo una straordinaria rete di contatti, con almeno un centinaio di corrispondenti tra Europa, Americhe, Asia meridionale e orientale, Africa occidentale e Sudafrica: studiosi e appassionati come lui, ma soprattutto persone comuni, giardinieri, capitani di marina, medici, chirurghi e sacerdoti che vivono nelle colonie e contribuiscono chi con un esemplare, chi con molti, pur di essere citati nelle sue Centurie e di partecipare al progresso delle scienze. Un modello di cui farà tesoro lo stesso Linneo, che lo ricordò con il monotipico genere Petiveria. 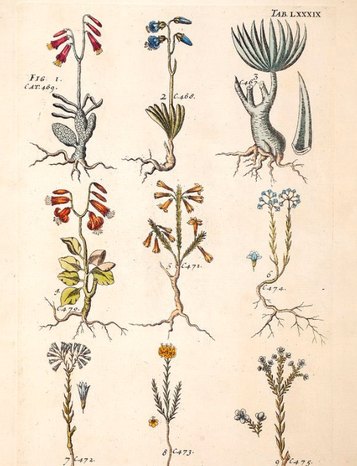 Come nacque una grande collezione Nel 1706, con la morte del curatore Samuel Doody, tra i farmacisti londinesi riprese l'eterno dibattito: aveva senso continuare a mantenere il costoso Physic Garden di Chelsea, o era meglio liberarsi di quell'impianto mangia-soldi? Per valutare la situazione finanziaria, venne formato un comitato che fu anche incaricato di prendere contatto con il proprietario del terreno, sir Charles Cheyne, per verificarne l'eventuale acquisto. Cheyne chiese una cifra irraggiungibile: 400 sterline. Nonostante ciò, il comitato si pronunciò a favore del mantenimento del giardino e per far fronte ai debiti indisse una sottoscrizione straordinaria, alla quale, per dare l'esempio, i suoi membri aderirono per primi. Il seguito tra gli altrui soci fu modesto, ma il giardino sopravvisse. Gran parte del merito va ascritto al membro più autorevole del comitato stesso, il farmacista James Petiver (1663-1718), che succedette a Doody come curatore del giardino, ma anche come "dimostratore di botanica". I suoi compiti principali erano due: da una parte, impartire lezioni di botanica pratica ("dimostrazioni") ai giovani apprendisti, da tenersi almeno due volte al mese nel Physic Garden nei mesi estivi; dall'altra, organizzare la Grande erborizzazione annuale, con la partecipazione di maestri ed apprendisti. Abbiamo già incontrato Petiver come amico di Doody e attivo membro del Temple Coffee House Botanical Club; è ora di conoscerlo meglio. Figlio di un merciaio di Rugby, poco dopo la morte di quest'ultimo dovette interrompere gli studi e sempre ne ebbe rammarico, soprattutto per non aver potuto acquisire una sufficiente padronanza del latino, all'epoca la lingua ufficiale delle scienza. Nel giugno 1677, quattordicenne, iniziò il suo apprendistato sotto Charles Feltham, il farmacista del St Bartholomew's Hospital di Londra. Intorno al 1680 conobbe Whatts e cominciò a frequentare il giardino di Chelsea, stringendo amicizia con Doody; a quanto risulta dal suo erbario, almeno dal 1683 prese regolarmente parte agli herborizing organizzati dalla Società dei farmacisti. Nel 1685, terminati i previsti otto anni di apprendistato, ottenne la licenza e tra il 1686 e il 1687 aprì una propria farmacia all'insegna della Croce bianca in Aldersgate Street (nei pressi dell'attuale Barbican Centre), che avrebbe gestito fino alla fine dei suoi giorni. A questo punto doveva già essersi fatto un nome come esperto botanico, visto che nel 1688, insieme all'amico Doody, viene ringraziato da John Ray per l'aiuto prestato per il secondo volume di Historia Plantarum. Probabilmente attraverso Doody, conobbe Sloane, rientrato dalla Giamaica nel 1689 con un'enorme collezione di naturalia, e incominciò a frequentare il Temple Coffee House Botanical Club, di cui diventò la personalità più nota dopo lo stesso Sloane. Forse incoraggiato dall'esempio di questi, decise di creare una propria collezione, che sarebbe stato anche il migliore biglietto da visita per garantire a lui, semplice farmacista "illetterato", l'accesso alla società colta londinese. Non aveva le enormi disponibilità finanziare di Sloane, ma poteva trarre profitto da un altro vantaggio: come farmacista e fornitore di farmaci di alcuni ospedali londinesi, nella sua bottega già affluivano spezie e piante medicinali da molte parti del mondo; era dunque in contatto con membri della Compagnia delle Indie e mercanti che praticavano il commercio internazionale. Come risulta dalle sue lettere, almeno dal 1690 Petiver incominciò a tessere quella formidabile rete di contatti che gli avrebbe permesso di essere il più importante collezionista del suo tempo dopo il ricchissimo Sloane. Uno dei suoi primi corrispondenti documentati è il chirurgo Samuel Browne, che lavorava per la Compagnia delle Indie orientali a Fort St George in Bengala (oggi Chennai). Non solo Browne raccolse per lui molte piante, che gli inviò in Inghilterra accompagnate da note con i nomi locali, ma a sua volta lo mise in contatto con altre persone: il reverendo George Lewis, collezionista di conchiglie, e soprattutto il missionario gesuita Georg Joseph Kamel, pioniere dello studio della flora delle Filippine. A sua volta Petiver fece da tramite tra Kamel e Ray, che pubblicò l’opera del missionario moravo in appendice al terzo volume di Historia Plantarum. Si tratta solo del nucleo iniziale di una vastissima rete di corrispondenti e contributori, che giunse a comprendere oltre cento persone: alcuni erano noti scienziati, come Boerhaave o Tournefort, oppure collezionisti e proprietari di grandi giardini come i fratelli Sherard, la duchessa di Beaufort o il vescovo Compton, ma la stragrande maggioranza era costituita da persone comuni: chirurghi, medici, capitani di nave, mercanti, sacerdoti, giardinieri che contribuirono chi con un esemplare, chi con dozzine e dozzine di piante, insetti e altri animali, conchiglie, fossili, spediti da vari paesi europei, dalla Cina, dall’India, dal Sud Africa, dal Sud e dal Nord America. È stato sottolineato che almeno un terzo di queste persone era legato in un modo o nell’altro al commercio triangolare, o in altri termini alla tratta degli schiavi. Oltre a Browne, i contributori più importanti furono Hendrik Oldenland, il curatore dell’orto botanico della VOC a Table Bay, e James Cunninghame, un chirurgo scozzese che lavorava per la Compagnia delle Indie nelle basi di Zhoushan e Amoy (oggi Xiamen) in Cina e fu il primo europeo a raccogliere un significativo erbario di piante cinesi. Per i suoi contributori, Petiver giunse a stilare prima liste di "desiderata", poi vere e proprie istruzioni stampate sulle modalità di raccolta, conservazione e spedizione, che costituiscono un modello e un'anticipazione delle indicazioni di Linneo ai suoi apostoli. Col tempo, la sua bottega di Aldersgate Street si trasformò in una specie di centro di interscambio, dove da tutto il mondo giungevano pacchi di esemplari, libri, lettere con richieste di consulenza ma anche di materiali. Per Petiver, infatti, il collezionismo di naturalia era anche un'attività lucrativa: se tratteneva per sé gli esemplari che considerava più prestigiosi o interessanti, altri li vendeva a caro prezzo ad altri collezionisti. 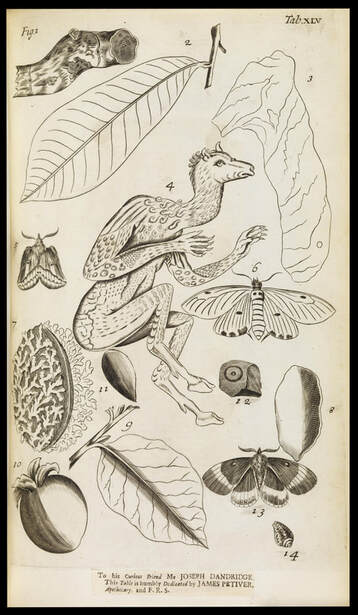 Collezionista e dimostratore Con la sola eccezione di un viaggio nei Paesi Bassi di cui parleremo più avanti, Petiver limitò le sue attività di raccolta diretta a qualche escursione in Inghilterra; oltre che nei dintorni di Londra, sono documentati viaggi nelle Midlands, in Essex, a Bath, a Bristol, nell'Essex e nel Suffolk. Il grosso delle sue collezioni arrivava però dai suoi corrispondenti che lo misero in contatto, letteralmente, con tutti i continenti (eccetto l'ancora inesplorata Oceania), permettendogli di accumulare una collezione che, oltre a centinaia e centinaia di altri esemplari, comprendeva almeno 5000 piante essiccate. A partire dal 1695, cominciò a pubblicare gli esemplari più curiosi, rari o significativi in una serie di cataloghi, dapprima senza immagini, poi illustrati, organizzati come "centurie", ovvero in serie di cento esemplari. Il primo è Musei Petiveriani centuria prima (1695), che descrive cento tra insetti, conchiglie, fossili e piante provenienti da Europa, America settentrionale, Africa occidentale, Asia meridionale e orientale; tra il 1698 e il 1703 seguirono altre cinque centurie, per un totale di seicento naturalia. Petiver pubblicò inoltre dozzine di brevi articoli nella rivista The Monthly Miscellany e molti contributi nelle Transactions della Royal Society, di cui divenne membro nel 1695 (nella stessa seduta dell'amico Samuel Doody). I suoi lavori più rilevanti sono la relazione sulle piante indiane ricevute da Browne An account of some Indian plants (1698) e due scritti di entomologia: Gazophylacium naturae et artis (1702–6), un catalogo illustrato degli insetti britannici, e Papilionum Brittaniae Icones, la prima rassegna completa dei lepidotteri inglesi che lo ha fatto salutare come «padre delle farfalle britanniche», che non di rado ha battezzato con il nome comune che portano ancora oggi. Petiver era anche un abile uomo d’affari e mise la sua competenza manageriale al servizio sia della Royal society, sia del Chelsea Physic Garden, anche se, di fronte ai suoi mille impegni professionali (oltre che del St Bartholomew, divenne anche farmacista della Charterhouse school and hospital), il suo incarico di dimostratore passava un po’ in secondo piano, tanto che presto dovette essere affiancato da Isaac Rand; il suo maggior merito fu sistematizzare e estendere le escursioni botaniche. Mentre in precedenza se ne teneva solo una all’anno, con Petiver e Rand il loro numero crebbe fino a sei, una al mese per tutta la bella stagione, a partire da aprile. Accompagnati dal dimostratore, gli apprendisti raggiungevano località come Hampstead Head, Putney e Greenwich per escursioni di una ventina di miglia; durante il pranzo, che di solito si teneva in qualche osteria, le piante venivano esaminate e identificate e ne venivano descritte le particolarità e le virtù medicinali. L’ultima escursione, detta General Herborizing, poteva durare due giorni, coprire una sessantina di miglia, era riservata ai maestri e ai loro ospiti, spesso membri eminenti dei Collegi dei medici e dei chirurghi, ed era anche un’importante occasione sociale. Anche il Chelsea Physic Garden poté beneficiare della rete di Petiver per un sensibile arricchimento delle collezioni. In particolare, nel 1711, per incarico di Hans Sloane, Petiver si recò in Olanda per trattare l’acquisto delle collezioni di Paul Hermann, messe all’asta dalla vedova; fu l’occasione per conoscere di persona Boerhaave e per rinnovare la collaborazione e gli scambi tra i due orti botanici. Tra il 1711 e il 1714, Petiver pubblicò sulle Philosophical Transactions una serie di articoli molto interessanti per chi studia la storia delle introduzioni delle piante esotiche, perché vi recensì le piante rare recentemente introdotte dal Nord America, dalla Cina e dalla Provincia del Capo e coltivate con successo nei giardini del vescovo di Londra a Fulham, in quello della duchessa di Beaufort e soprattutto a Chelsea. A partire dal 1716, la sua salute cominciò a declinare. Alla sua morte, nel 1718, le sue collezioni furono acquistate da Sloane, che ebbe a lamentare il grande disordine in cui erano tenute; ora sono in parte conservate nel Natural History Museum di Londra.  Un'erbacea... odorosa Anche Petiver fa parte del nutrito gruppo di naturalisti omaggiati da Plumier e Linneo con la dedica di un genere botanico. Il francese fece in tempo a vedere il primo catalogo della sua collezione, e lo loda per la ricchezza dei materiali e il buon ordine in cui sono disposti (il che contrasta con le lamentele di Sloane, ma anche con ciò che riferiscono alcuni viaggiatori che ebbero l'occasione di vederle di persona). Linneo attinse ampiamente alle pubblicazioni di Petiver sia per le piante esotiche, da lui documentate per la prima volta, sia per gli insetti, e apprezzava il fatto che in alcuni dei suoi contributi sulle Transactions il farmacista avesse abbozzato una classificazione naturale. Il genere Petiveria L. (appartenente a una famiglia propria, Petiveriaceae) comprende una sola specie, P. alliacea: caratterizzata come dice il nome da un forte odore di aglio, è una grande erbacea perenne cespugliosa, con foglie intere obovate e infiorescenze a spiga di piccoli fiori biancastri, cui nei paesi d’origine (gran parte dell’America subtropicale e tropicale, dalle Florida al Perù) sono attribuite innumerevoli proprietà terapeutiche; per l’odore, è però utilizzato anche come repellente. Qualche informazione in più nella scheda. E' con una pianta delle Alpi, Saussurea alpina, che nel 1810 de Candolle volle ricordare i suoi illustri compatrioti Horace-Bénédict e Nicolas Théodore de Saussure. Il primo dedicò tutta la sua passione di naturalista all'esplorazione di quella catena di montagne, contribuendo anche a lanciarla come meta turistica con la sua celebre ascensione del Monte Bianco; il secondo scoprì il ruolo dell'anidride carbonica e dell'acqua nel processo di fotosintesi. Ma le specie di questo vasto genere di Asteraceae non vivono solo sulle Alpi: il nucleo più consistente si trova in Cina, con oltre 250 specie. Uno scienziato innamorato delle montagne Il Monte Bianco, il "Gigante delle Alpi" che domina l'anfiteatro di montagne che circonda Ginevra, fin da bambino per Horace-Bénédict de Saussure (1744-1799) fu una presenza familiare, destinata a trasformarsi in ossessione. Nato in una famiglia patrizia ginevrina, nell'infanzia trascorsa per lo più in campagna acquisì il gusto per le libere scorribande nella natura e ben presto scoprì le montagne e l'alpinismo. Come racconta egli stesso nella sua opera maggiore Voyages dans les Alpes, all'età di diciotto anni aveva già percorso più volte tutte le montagne dei dintorni di Ginevra e a 19 trascorse due settimane nella "più alta baita" del Giura per visitarne le maggiori cime. Si era appena diplomato all'Académie di Ginevra con una tesi sulla trasmissione del calore. Da quel momento si dedicò con passione agli studi naturalistici; nel 1762, a soli 22 anni, ottenne la cattedra di filosofia (che includeva la fisica e le scienze naturali) alla stessa Académie, mantenendo l'incarico per 24 anni. Saussure aveva in un certo senso ereditato la passione per lo studio della natura dallo zio materno (marito della sorella della madre) Charles Bonnet, filosofo, entomologo, botanico, psicologo, seguace della teoria delle catastrofi, che gli trasmise tanto l'approccio sperimentale quanto una spiccata tendenza all'ecclettismo. Inizialmente, infatti, gli interessi del giovane Saussure andavano soprattutto alle piante, che amava raccogliere fin da bambino; alla fisiologia vegetale dedicò il suo primo saggio, Obsérvations sur l'écorce des feuilles et des petales, che contiene importanti osservazioni sulla funzione dei pori delle foglie. Tuttavia, anche se continuò ad erborizzare per tutta la vita e a pubblicare occasionalmente articoli di botanica e addirittura un'opera di sistematica (Systema plantarum secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus differentis, 1779) a partire dal 1764 il suo interesse dominante divenne la geologia, "chiave della storia del nostro pianeta". Determinante nella scoperta di questa vocazione fu l'incontro ravvicinato con il Monte Bianco. Nel 1760 egli si recò per la prima volta nel villaggio di Chamonix per visitare il ghiacciaio della Mer de Glace e forse per cercare piante per conto di un altro dei suoi mentori, Albrecht von Haller. Profondamente affascinato, promise a se stesso che un giorno avrebbe raggiunto la cima della grande montagna. Quell'anno, e ancora l'anno dopo, quando tornò a Chamonix, fece affiggere in tutte le parrocchie della valle un manifesto in cui prometteva "una considerevole ricompensa" a chi riuscisse a trovarne la strada. L'appello non ebbe alcun esito, ma ormai le montagne erano diventate il terreno di ricerca privilegiato di Saussure: da quel momento "non lasciai trascorrere un solo anno senza fare lunghe escursioni quando non dei viaggi per studiare le montagne". Nei decenni successivi, egli attraverserà le Alpi quattrodici volte attraverso otto diversi passaggi e farà sedici escursioni fino al centro della catena; percorrerà il Giura, le montagne della Svizzera, dell'Inghilterra, della Germania, dell'Italia, i vulcani attivi della Sicilia e delle isole adiacenti e quelli estinti dei Vosgi, sempre con "il martello da geologo in mano [...] scalando tutte le cime accessibili che promettessero qualche osservazione interessante e prelevando sempre campioni di minerali e rocce". Queste ricerche, non di rado difficili e sempre faticose, basate sull'osservazione diretta e sulla misurazione dei fenomeni, condotta anche attraverso una serie di strumenti di sua invenzione (il più celebre è l'igrometro a capello) dovevano fornire le basi per una Teoria della Terra, che purtroppo Saussure non giunse mai formulare compiutamente, affidandola a molti manoscritti e alle osservazioni contenute nei quattro volumi della sua opera più nota,Voyages dans les Alpes (1779-1799). Nelle esplorazione delle montagne si congiungevano una passione esistenziale e un'intuizione scientifica: "Le pianure sono uniformi, è possibile vedere la stratificazione delle terre e i loro diversi letti solo grazie a scavi, opera dell'uomo o delle acque; mezzi per altro insufficienti [...]. Al contrario, le alte montagne, infinitamente variate nella loro materia e nella loro forma, presentano tagli naturali, di grandissima estensione, dove si possono osservare con estrema chiarezza e abbracciare a colpo d'occhio l'ordine, la posizione, la direzione, lo spessore e persino la natura degli strati di cui sono composte". Di quel sistema di montagne, il Monte Bianco, per la sua grandissima mole e la sua posizione centrale, è la chiave di volta: "Il Monte Bianco è una delle montagne d'Europa la cui conoscenza pare poter fornire un maggior numero di informazioni sulla Teoria della Terra. Questa enorme roccia di granito, situata al centro delle Alpi, collegata a montagne di diverse altezze e diversa natura, sembra essere la chiave di un grande sistema". Scalare quella montagna, giungere su quella cima, per Saussure non era un exploit sportivo, ma un imperativo scientifico. Ma per vedere realizzata la promessa del 1760 dovette attendere ventisette anni. Un tentativo venne effettuato da quattro guide di Chamonix nel 1775, e un secondo da altre tre nel 1783, finché l'anno successivo due cacciatori di camosci si avvicinarono tanto alla cima da fare sembrare possibile la conquista della montagna. Nel 1785, Saussure stesso tentò la scalata dall'Aiguille du Goûter , insieme a numerose guide, allo scrittore e pittore Marc-Thédore Bourrit e al giovane figlio di quest'ultimo, ma dovette tornare indietro a causa dell'alta neve fresca. Finalmente, l'8 agosto del 1786, la cima fu raggiunta da una della guide che aveva partecipato a quel tentativo, il cacciatore di camosci e cercatore di cristalli Jacques Balmat, e dal medico Michel Gabriel Paccard. Subito avvertito da Balmat che andò a riscuotere la ricompensa, Saussure avrebbe voluto a sua volta ripetere subito l'impresa, ma il maltempo lo costrinse ad attendere un altro anno. L'otto luglio 1787 lo troviamo a Chamonix insieme alla moglie; ma deve ancora portare pazienza e aspettare che il tempo si rimetta, mentre controlla e ricontrolla la sua attrezzatura scientifica. Finalmente il 31 luglio torna il bel tempo e il mattino dopo, alla presenza di tutto il villaggio, la grande carovana (Saussure, un servitore e diciotto guide) si mette in cammino. La scalata, seguita dal basso con i cannocchiali puntati, richiede due giorni. La prima notte il gruppo bivacca al Mur de la Côte; il giorno dopo, superando punti difficili e crepacci con l'aiuto di scale, raggiunge il Gran Plateau dove si trascorre la notte in tenda e Saussure effettua alcune osservazioni. La fame, la sete, la stanchezza e il mal di montagna si fanno sentire. La mattina dopo l'ultimo tratto sarà faticosissimo. Saussure cammina preceduto e seguito da una guida che impugna una lunga pertica, cui si aggrappa per non cadere; tuttavia, esausto, rischia di svenire. Dopo una sosta e un ultimo sforzo, la cima è infine raggiunta alle 11.05. Qui, per quattro ore e mezza, Saussure può finalmente realizzare almeno una parte del suo programma scientifico: misura l'altitudine (con un errore di appena settanta metri, una precisione notevole per l'epoca), la temperatura a cui bolle l'acqua, l'igrometria dell'aria, la natura della neve, l'intensità del colore del cielo (per misurare la quale ha inventato l'ennesimo strumento, il cianometro); vorrebbe fare ben di più, ma il tempo incalza. Alle 15,30 dà ordine di iniziare la discesa, combattuto tra la gioia per la vista superba e la delusione: "Me ne andai con il cuore pesante per non aver potuto ricavare tutto ciò che desideravo. Perché, benché avessi cominciato dalle osservazioni più importanti, quello che avevo fatto mi sembrava poco rispetto a quello che avevo sperato". Dopo una terza notte trascorsa presso la "roccia del felice ritorno", poco dopo mezzogiorno Saussure e compagni raggiungono Chamonix accolti da una folla delirante. Mentre l'impresa di Balmat e Paccard si era svolta quasi in modo clandestino (per il timore della guida di vedersi soffiare la ricompensa), quella di Saussure suscita grande clamore durante e dopo. La sua Relation abregée circola in tutta Europa, l'epica scalata è ritratta dai pittori e raccontata nelle gazzette. Grazie a Saussure, tutti conoscono Chamonix e la sua montagna; è nato l'alpinismo come sport. Il che, ovviamente, era quanto di più lontano dalle intenzioni del naturalista ginevrino: come scienziato, probabilmente lo soddisfecero molto di più i sedici giorni che l'anno successivo trascorse a fare osservazioni sulla cresta del Colle del Gigante (in effetti, un'impresa scientifica straordinaria, la prima campagna di osservazioni continuate in alta quota, che gettò le basi della meteorologia alpina). Negli anni successivi, almeno finché la salute glielo permise, Saussure continuò a scalare e studiare le montagne, a fare rilievi geologici, a inventare strumenti. Scrisse gli ultimi volumi di Voyages dans les Alpes (il racconto dell'ascensione al Monte Bianco è contenuto nel quarto tomo, uscito nel 1799). Dopo un primo colpo apoplettico nel 1794, gli ultimi anni furono penosi, resi difficili anche dai rivolgimenti politici causati dalla rivoluzione francese.  Un pioniere della ricerca sulla fotosintesi Nel 1765, Horace-Bénédict de Saussure sposò Albertine Amélie Boissier, una delle più ricche ereditiere della città. Dal matrimonio, straordinariamente felice, nacquero tre figli: la maggiore Albertine (1766-1841), sposata con il matematico Louis Necker, fu una importante scrittrice e pedagogista, fautrice dell'educazione femminile; il minore Alphonse Jean François non si distinse particolarmente, mentre il vero erede scientifico del padre fu il secondogenito Nicolas-Théodore (1767-1845). Il padre, che non credeva nell'educazione impartita dalle scuole pubbliche (tra le sue tante attività c'è anche un progetto di riforma mai approvato) lo fece educare in casa, fino a quando il ragazo si iscrisse all'Università. Dal 1786 divenne l'assistente e il compagno di viaggio del padre, da cui apprese l'approccio sperimentale e la centralità della descrizione quantitativa dei fenomeni. Nel 1790, in occasione del prelievo di esemplari di aria a diverse altitudini tramite palloni di vetro, pensò di pesarli e scoprì che le differenze di peso erano esattamente proporzionali alle differenze di pressione barometrica, portando una conferma sperimentale alla legge di Boyle-Mariotte. Nel 1792 fu lui a dare il nome di dolomite (in onore di Déodat de Dolomieu) alla roccia di cui aveva ricevuto alcuni campioni dalla Carniola e di cui fece l'analisi chimica. Nicolas-Thédore si stava infatti ormai orientando verso questa disciplina, che, insieme alla fisiologia vegetale, divenne il suo campo d'elezione. Proprio per approfondire le sue conoscenze chimiche, nell'estate del 1793 andò in Inghilterra, ma una lettera della madre, preoccupata per la salute del marito e anche per alcune perdite finanziarie, lo richiamò in Svizzera. Tra il 1794 e il 1795, insieme al fratello minore, a causa delle tensioni politiche che scuotevano Ginevra. fu costretto a rifugiarsi a Rolle nel Vaud, dove curò l'edizione dell'ultimo volume dei Voyages dans les Alpes. Al suo ritorno a Ginevra, iniziò gli studi originali. Dal 1802 venne nominato professore di mineralogia e geologia dell'Università di Ginevra, un incarico onorario che mantenne fino al 1835, facendosi però supplire dal nipote Louis-Albert Necker, figlio di sua sorella Albertine. Poté così dedicarsi soprattutto a ricerche di laboratorio su questioni all'incrocio tra chimica e fisiologia vegetale: l'assimilazione del carbonio da parte delle piante (1797), l'influenza del suolo sulla loro nutrizione (1799), il ruolo dei sali minerali (1804). Questi studi fanno da preludio a Recherches chimiques sur la végétation (1804), in cui il processo di nutrizione delle piante è studiato con un approccio sperimentale e quantitativo. La teoria prevalente all'epoca era che le piante ricavassero dal suolo il carbonio che va a formare i loro tessuti. Coltivando le piante in acqua e chiudendole in contenitori di vetro con atmosfera controllata con aggiunta di anidride carbonica, Saussure dimostrò invece che le piante assorbono anidride carbonica dall'aria ed emettono ossigeno. Misurando i due gas all'inizio e alla fine dell'esperimento, poté provare che il peso del diossido di carbonio assorbito è approssimativamente uguale al volume dell'ossigeno consumato. Ne dedusse che l'aumento di massa delle piante durante la loro crescita non è dovuto unicamente all'assorbimento di anidride carbonica, ma anche di acqua. Studiò poi il consumo dell'ossigeno durante la germinazione e nelle piante coltivate al buio, concludendone che l'uso dell'ossigeno da parte delle piante è simile a quello degli animali durante la respirazione. Sulla base delle sue ricerche, Saussure giuse a formulare una prima sommaria equazione chimica del processo di fotosintesi (un nome al di là da venire). Altre ricerche, condotte sull'analisi qualitativa e quantitativa delle ceneri di varie piante, dimostrarono che per il loro nutrimento sono necessari, sebbene in piccolissime quantità, diversi sali minerali, che esse traggono dal suolo. Ma poiché la composizione chimica delle piante è diversa da quella del terreno dove vivono, Saussure ne concluse che le piante assorbono i nutrienti in modo selettivo. Notò anche l'importanza dell'azoto, ma non poté spiegare come le piante se lo procurino. Come si vede, si tratta di ricerche importanti non solo sul piano teorico, ma anche per le loro applicazioni in agricoltura. Eppure la loro importanza sfuggì ai contemporanei, finché non furono riscoperte e approfondite da Liebig, che dimostrò che le piante ricavano anche l'azoto dall'atmosfera. Un'accoglienza migliore ricevettero i suoi successivi studi sui processi biochimici, apprezzati fra gli altri da Pasteur. Qualche informazione in più su padre e figlio nella sezione biografie. Diversi altri membri di questa famiglia furono illustri scienziati, ma il più famoso di tutti fu ugualmente geniale e innovativo in tutt'altro campo; si tratta di Ferdinand de Saussure (1857-1913), pioniere della linguistica strutturale, bisnipote di Horace-Bénédict da parte del figlio minore Alphonse.  Un grande genere montano Nel 1810, il grande botanico Augustin Pyramus de Candolle volle celebrare i due illustri concittadini dedicando loro un nuovo genere di Asteraceae montane: "Ho dato a questo genere il nome Saussurea, in onore dei miei celebri concittadini i signori de Saussure padre e figlio, che hanno potentemente contribuito al progresso della fisica e della chimica e sono stati utili anche alla botanica, il primo con le sue osservazione sui pori della superficie delle foglie e sulla risalita della linfa, il secondo con le sue ricerche chimiche sulla vegetazione; desidero che il nome delle saussuree alpine ricordi a tutti i botanici che percorreranno le Alpi il nome di colui che ha descritto nel modo migliore questa vasta catena di montagne, mentre quelle delle steppe salate della Siberia ricorderanno gli esperimenti di Théodore de Saussure sull'assorbimento delle materie saline da parte dei vegetali". L'uno come gli altri membri di importanti famiglie del patriziato ginevrino, de Candolle e i Saussure appartenevano al medesimo ambiente sociale e soprattutto Horace-Bénédict non aveva mancato di far sentire la sua influenza sul giovane Augustin, anche se cercò di dissuaderlo dal dedicare il suo tempo alla botanica. Come sappiamo, anch'egli ne era stato appassionato in gioventù, quando percorreva le dolci montagne del Giura e le Prealpi svizzere tanto ricche di fiori, ma quando il suo terreno di ricerca erano diventate le alte cime, quella passione aveva finito per raffreddarsi: "Nella vegetazione di questo cantone [di Chamonix] c'è una monotonia insopportabile. Non so se la causa risieda nella struttura del paese, oppure nella natura del suolo, oppure nel freddo di questi ghiacci eterni, ma è sempre la stessa cosa". E così, come racconta de Candolle nelle sue memorie, cercò con accanimento di "arruolarlo" nelle scienze che più amava e di disgustarlo della botanica: "Ogni volta che lo vedevo mi ripeteva che questo studio non prometteva nessun successo, e non valeva la pena di occuparsene se non come passatempo". Ovviamente de Candolle non si lasciò convincere, ma neppure se ne ebbe a male. Come è attualmente inteso, Saussurea (Asteraceae) è un vasto genere soprattutto di perenni cespitose con una distribuzione molto ampia (America, Europa, Asia, più una specie australiana) per lo più in ambienti montani o steppici; l'area di maggiore diversità sono le alte montagne temperate dell'Asia (Asia centrale, Siberia, Himalaya, Tibet, Cina). Il centro di diversità si trova proprio in Cina, nella zona dei monti Hengduan con oltre cento specie, in gran parte endemiche. Con 289 specie, di cui 191 endemiche, è uno dei generi più ricchi di specie della flora cinese. Nella flora italiana abbiamo quattro specie, tutte alpine e piuttosto rare: S. alpina (tutto l'arco alpino, eccetto la Liguria); S. depressa (Alpi occidentali, dal San Bernardo al Rocciamelone); S. discolor (tutto l'arco alpino, salvo la Liguria, e l'Appennino settentrionale); S. pygmaea (Alpi carniche orientali e Alpi Giulie). S. alpina dà il nome al Giardino botanico alpino Saussurea, che sorge a 2173 metri d'altitudine nei pressi della stazione intermedia della funivia del Monte Bianco, sopra Courmayeur. Vuole anche essere un omaggio indiretto a Horace-Bénédict de Saussure, che non mancò di visitare (e descrivere in Voyages dans les Alpes) la località valdostana e questo versante della grande montagna. Le specie himalayane, molte delle quali a rischio per l'eccessiva raccolta in qualità di piante medicinali, hanno spesso infiorescenze totalmente avvolte da una candida peluria che le fa assomigliare a palle di neve. Molte sono ricercate dai collezionisti, ma di difficile coltivazione: in natura vivono ad altitudini comprese tra 3000 e 5500 metri, vegetano solo nella breve stagione estiva e richiedono estati fresche e terreni perfettamente drenati, senza dimenticare che spesso sono di lenta crescita e fioriscono una volta sola, per poi morire. Ne troverete alcune nella scheda. Nel Seicento, la lontana Danzica diventa uno snodo centrale del commercio olandese con la Polonia, la Prussia orientale e la Russia. Nella città casciuba si stabilisce una fiorente colonia di mercanti olandesi che commerciano, tra l'altro, la cocciniglia polacca, all'epoca ancora abbondante anche se sta già subendo la concorrenza della meno costosa cocciniglia messicana. Proprio a questo piccolo insetto deve la sua fortuna il ricchissimo mercante Jacob Breyne, che unisce all'abilità negli affari una sfrenata passione per le piante: quelle di casa, che studia e raccoglie nei suoi erbari, e quelle esotiche, che, trasportate dalle navi delle compagnie olandesi, l'EIC e la VOC, dai quattro angoli del mondo, si riversano sempre più numerose negli orti botanici di Leida e Amsterdam e nei "paradisi" (ovvero i giardini privati) dei magnati della giovane Repubblica delle province unite. In occasione dei ricorrenti viaggi nel paese d'origine della sua famiglia, Breyne li visita, osserva e annota le novità, e si porta a casa quello che può, ad arricchire il suo stesso "paradiso". Alle esotiche dedica non meno di tre libri, il primo dei quali, curatissimo nella veste editoriale e nell'apparato iconografico, affidato a pittori e incisori di vaglia, è un capolavoro dell'editoria botanica secentesca. Con questi libri, anticipando tutti, è spesso il primo a far conoscere novità sudafricane destinate a grande fortuna, come Pelargonium, Agapanthus, Mesembrianthemum. E' bravo anche a stabilire rapporti umani, creando una vasta rete di contatti che negli ultimi anni della sua vita si estende anche alla nuova potenza coloniale (e orticola) emergente: l'Inghilterra. Insieme al giardino, alla biblioteca, alle collezioni naturalistiche, la lascia in eredità al figlio Johann Philipp, che la allargherà ulteriormente e diventerà un membro riconosciuto dell'establishment scientifico internazionale. A ricordare entrambi, il loro splendido giardino e le loro opere che fecero conoscere tante piante rare, il genere Breynia (Phyllantaceae). 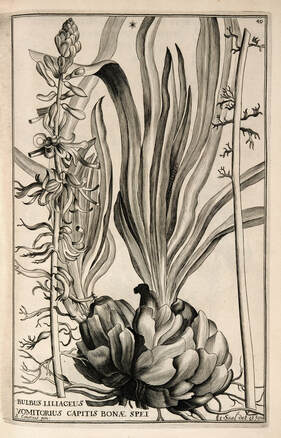 Un mercante olandese a Danzica Nel Seicento, la Repubblica delle Province unite aveva forti legami commerciali con Danzica, all'epoca il maggiore porto del Baltico, oltre che una città cosmopolita appartenente al Regno di Polonia ma con una forte presenza tedesca. I mercanti olandesi commerciavano soprattutto granaglie e l'apprezzatissimo colorante rosso ricavato dalla cocciniglia polacca, Porphyrophora polonica. La città casciuba era una piazza così importante che spesso, invece di avvalersi di agenti locali, per seguire gli affari sul posto vi mandavano un figlio cadetto. Questo destino toccò anche a Jacob Breyne senior, membro di una famiglia di mercanti che dal Brabante si era trasferita nei Paesi Bassi nel 1585, in seguito all'assedio di Anversa. A Danzica Jacob fece fortuna trasportando a Amsterdam e Leida piante medicinali e cocciniglia; si sposò con Anna Moorman, anch'essa appartenente a una famiglia di origine olandese, e nel 1637 ne ebbe un figlio: è il nostro Jacob Breyne (1637-1697), il primo protagonista di questa storia. Grazie alle buone disponibilità finanziarie del padre, egli ricevette un'ottima educazione e incominciò presto a interessarsi di scienze naturali, che del resto erano anche un ferro del mestiere per chi commerciava merci ricavate da animali e piante. Uno dei suoi professori al ginnasio accademico, Christian Mentzel, che vi insegnò dal 1648 al 1650, lo coinvolse nelle sue ricerche sulla flora locale, insegnandogli le tecniche per predisporre un erbario. All'inizio degli anni '50, il padre lo inviò a Leida da suo fratello Pieter per imparare le tecniche commerciali; Jacob junior ne approfittò per seguire le lezioni di botanica di Adolf Vortsius (1624-1663), prefetto dell'orto botanico, nelle cui aiuole egli incontrò la passione della sua vita: le piante esotiche. Dotato di un gran talento per i rapporti umani, strinse amicizie durevoli sia nell'ambiente universitario sia tra i ricchi possidenti che nei loro giardini (Paul Hermann li chiamò giustamente "paradisi") facevano a gara a coltivare le specie più rare e nuove portate ad Amsterdam dalle navi delle due compagnie olandesi, l'EIC (Compagnia olandese delle Indie occidentali) e la VOC (Compagnia olandese delle Indie orientali). Alla morte del padre nel 1655, Jacob Breyne si stabilì definitamente a Danzica, ma mantenne i contatti con l'Olanda, che visitava periodicamente. Allargò il giro d'affari della famiglia, estendendolo anche all'Inghilterra. Senza però dimenticare la passione per le scienze naturali: nella sua bella casa nella centralissima via Długa creò una notevole collezione di naturalia e una fornitissima biblioteca; in una delle sue proprietà (non ne conosciamo l'ubicazione) creò anche un orto botanico privato, ispirato ai paradisi che tanto aveva ammirato nei Paesi Bassi. Riprese anche a esplorare la flora locale; all'inizio, doveva essere poco più di un passatempo. Visitava i dintorni della città e sistemava le piante che veniva raccogliendo in un erbario con i nomi in olandese e talvolta qualche annotazione sull'aspetto generale; era una specie di diario botanico privato che chiamava Herbarium vivum (la copia che ci è giunta risale al 1659). Ma negli anni '70, con una situazione economica ormai orientata al bello stabile, poté dedicare più tempo alla botanica e concepire due progetti paralleli e complementari: da una parte esplorare e fare conoscere la flora locale, dall'altra documentare le novità esotiche introdotte nei giardini europei dagli olandesi. Complementari perché, per i naturalisti del Seicento, la flora della Casciubia e della Prussia orientale era non meno esotica e inesplorata di quella sudamericana, sudafricana o indonesiana. Avvalendosi probabilmente anche di una rete di informatori e raccoglitori, nel 1673 Breyne creò un secondo, assai più ambizioso erbario, Plantes rariores borussicae et casubicae ("Piante più rare della Prussia e della Casciubia"), un corposo manoscritto in quattro volumi con i nomi e le annotazioni in latino. Con i duplicati, ne creò anche un certo numero di copie, dal contenuto variabile, che inviava come dono a protettori, amici e corrispondenti; il più importante era sicuramente l'influente uomo politico Hieronymus van Beverningh, che fu anche curatore dell'università di Leida, città nei cui dintorni possedeva uno dei più spettacolari "paradisi" della Repubblica. Nel 1697, l'anno stesso della morte di Breyne, una copia raggiunse anche James Petiver, con il quale il mercante corrispondeva da qualche anno e dal quale aveva ottenuto semi di varie piante nordamericane coltivate a Chelsea. Pur vivendo in un luogo apparentemente periferico, Breyne riuscì infatti ad inserirsi brillantemente nella grande rete dei naturalisti europei che scambiavano disegni, fogli di erbario, semi, tuberi e bulbi di piante esotiche, potendo anche approfittare dei legami commerciali della sua famiglia con l'EIC e la VOC. In cambio di esemplari dell'altrettanto esotica flora della Polonia settentrionale, riceveva materiali e preziose informazioni dai quattro angoli dell'impero olandese. Tra gli agenti della VOC con cui fu in contatto, vale la pena di citare almeno Willem ten Rhijne, medico delle VOC a Dejima tra il 1674 e il 1676, e Paul Hermann, che prima di diventare prefetto dell'orto botanico di Leida, aveva visitato Ceylon e il Capo di Buona Speranza. Dai suoi periodici viaggi in Olanda, durante i quali non mancava mai di informarsi sulle novità orticole e di visitare i più bei giardini, Breyne riportò anche l'attrezzatura per creare una propria tipografia, alla quale nel 1677-78 affidò la stampa di Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, un corposo e curatissimo in folio con splendide illustrazioni dovute ai migliori artisti locali, tra cui il pittore Andreas (o Andrzej) Stech e l'incisore Isaak Steel. Il libro, dedicato a Hieronymus van Beverningh, contiene la presentazione in latino di cento piante, una ventina delle quali raccolte da lui stesso nella Polonia settentrionale, le altre osservate nei giardini olandesi o segnalate dai suoi corrispondenti; tra le prime Geum rivale, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla patens, Saxifraga hirculus. Le seconde sono quasi un'epitome dei traffici olandesi nel secolo d'oro: ci sono parecchie americane, giunte dal Suriname ma anche da altre parti del centro e sud America, come la splendida Caesalpinia pulcherrima (che Breyne chiama Crista pavonis, cresta di pavone), Asclepias curassavica e Jatropha multifida; da Ceylon o da Giava arrivano Gomphrena globosa, Clitoria ternatera L., Hibiscus rosa-sinensis (Breyne lo chiama Alcea javanica arborescens flore pleno, a segnalare che gli olandesi l'hanno incontrato a Giava, in una forma coltivata e stradoppia) e una delle piante che da Breyne prenderanno il nome, Frutex indicus baccifer vitis ideae secundae clusii foliis, oggi Breynia vitis-idaea; grazie a Willem ten Rhijne, dal Giappone abbiamo la canfora (Cinnamomum camphora) e la prima rappresentazione a stampa del tè The Sinensum, sive Tsia japonensibus (Camellia sinensis). Ma a fare la parte del leone è il Sudafrica, grazie allo stesso ten Rhijne ma soprattutto alle raccolte di Paul Hermann: ecco la oggi assai nota Leonotis leonurus, i primi pelargoni, Pelargonium triste e P. lacerum, parecchie Aizoaceae tra cui Cylindrophyllum calamiforme, che campeggia in un elegante vaso al centro del frontespizio, la prima Proteacea Protea conifera, la prima Restionacea Restio dichotomus. E poi ancora le bulbose Wachendorfia paniculata, Drimia elata, Oxalis purpurea, e quello che Linneo chiamò in suo onore Tulipa breyniana, oggi Moraea collina. In appendice Breyne pubblicò un trattatello sul tè scritto dal caro amico (così lo definisce, summus amicus meus) Willem ten Rhijne. Breyne sperava di pubblicare una seconda centuria; nel 1680 ne diede un'anticipazione in Prodromus fasciculi rariorum plantarum, dedicato alle piante esotiche osservate - in occasione di un viaggio del 1670 - nell'orto botanico di Leida e nei giardini di Beverningh e altri appassionati, incluso Jan Commelin, futuro commissario dell'Orto botanico di Amsterdam; nel 1689 ne pubblicò una seconda edizione, Prodromus fasciculti rariorum plantarum secundus, che include le piante viste nel viaggio in Olanda dell'estate di quello stesso anno; qui Breyne aveva potuto tra l'altro incontrare il giardiniere Georg Meister, di ritorno da Batavia e dal Giappone, che gli consegnò un pacco di esemplari inviati da Andreas Cleyer. Ad assisterlo nella pubblicazione fu il figlio Johann Philipp che all'epoca aveva solo nove anni. Sono opere di minor impegno rispetto alla Centuria prima: in entrambi i casi, si tratta una lista di piante in ordine alfabetico, priva di illustrazioni, con una descrizione sintetica e l'indicazione di dove le vide e se poté averne semi o talee. Le sudafricane anche qui hanno il primato, con l'arrivo di Agapanthus e Mesembrynathemum; da segnalare anche la pubblicazione della prima Nepenthes, raccolta da Hermann a Ceylon: Breyne le conservò il nome locale Bandura zingelensium, Linneo la ribattezzò Nepenthes distillatoria. In effetti, dato che Paradisus batavus di Hermann (anch'esso un resoconto delle piante esotiche coltivate nei grandi giardini olandesi) poté essere pubblicato postumo solo nel 1695, in qualche modo Breyne gli soffiò la primogenitura: sono spesso i suoi libri, pubblicati nella periferica Danzica, ad aver fatto conoscere a botanici e appassionati europei le piante esotiche introdotte dagli olandesi. 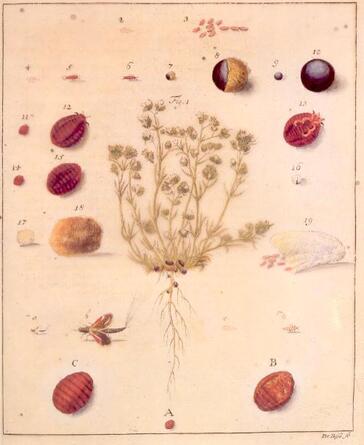 Talis pater, talis filius Breyne non riuscì mai a scrivere la progettata seconda centuria; inoltre, come confidò in una lettera all'amico Petiver e come sappiamo anche dalla testimonianza del figlio, avrebbe voluto scrivere una flora della Casciubia e della Prussia orientale, ma ne fu impedito da una penosa malattia e dalla morte, sopraggiunta nel gennaio del 1697, pochi giorni dopo il suo sessantesimo compleanno. Lasciava idealmente il compito in eredità al figlio minore Johann Philipp (1680-1764), che, come abbiamo visto, fin da bambino aveva coinvolto nei suoi progetti. Alla morte del padre Johann Philipp era un ragazzo di sedici anni. Qualche anno dopo, secondo le consuetudini familiari, anch'egli fu inviato a Leida; non però per avviarlo alla mercatura (di questo si occupava il fratello maggiore), ma per seguire i corsi di medicina del grande Hermann Boerhaave. Ottenuta la laurea di primo livello nel 1699 e quella magistrale nel 1702, munito delle lettere di presentazione dei suoi professori intraprese un grand tour scientifico attraverso l'Europa. La prima lunga tappa fu Londra, dove si trattenne per nove mesi, ospite del corrispondente del padre James Petiver, che gli fece conoscere Ray e Sloane, grazie al quale egli fu introdotto alla Royal Society, di cui divenne membro nel 1703. Fu poi la volta dell'Italia dove studiò la fauna marina nei dintorni di Ancona e visitò Padova, ospite di Vallisneri. Il viaggio proseguì attraverso Austria, Boemia e Germania, per concludersi nei Paesi Bassi, da dove rientrò a Danzica nel 1704. In una lettera del 1705 all'amico Petiver, dichiara di aver l'intenzione di riprendere e completare entrambi i progetti paterni. In realtà, per almeno venticinque anni, durante i quali esercitò con successo la professione medica, il proposito fu accantonato. Non però la passione per il giardino e le collezioni. Nel 1707 investì la dote della moglie Constantia Ludewig nell'acquisto di una casa e di un vasto giardino nel sobborgo di Brabank, dove poté sistemare le collezioni paterne che continuò ad arricchire per tutta la vita; oltre agli erbari, ai compendi di botanica, alle matrici delle opere del padre, c'erano monete, illustrazioni naturalistiche e a stampa (incluse le opere di Maria Sibylla Merian), minerali, fossili, pietre preziose o meno, ambre, preparati anatomici umani e animali conservati in formalina. Il giardino era così celebre che nel 1717 fu visitato dallo zar Pietro il Grande. Dalle testimonianze dell'epoca, sappiamo che c'erano una grotta, fontane, statue a grandezza naturale di Flora e Apollo, piante medicinali e molte esotiche: ananas, acacie, oleandri, fichi, ma anche banani, alberi di canfora, caffè e cannella. Ben noto negli ambienti scientifici europei anche grazie ai suoi viaggi, oltre che della Royal Society era membro della Leopoldina, e corrispondeva con oltre 170 scienziati, tra i quali, oltre al già citato Sloane, Leibnitz, Bernard de Jussieu, Peter Collinson e lo stesso Linneo. La corrispondenza con gli altri naturalisti europei era anche un modo per mantenere viva la fiamma della scienza in un ambiente che giudicava, se non ostile, poco interessato: "Per quanto mi riguarda, sono confinato in questo angolo d'Europa dove alla gente interessano solo i soldi", si sfogò con Hans Sloane. Alcune sue comunicazioni comparvero sporadicamente anche in precedenza sulle Transactions della Royal Society, ma l'attività scientifica occupò il centro della sua vita solo dopo il 1730, quando (anche in seguito alla morte del fratello che lo lasciò unico erede della fortuna familiare) si ritirò a vita privata. Tuttavia non scrisse mai né la seconda centuria né la progettata flora della Cascubia e della Prussia. Si accontentò di pubblicare una nuova edizione dei due fascicoli del Prodromus (1739), dandole però una splendida veste editoriale con eccellenti incisioni; in appendice vi pose una biografia del padre scritta da G. D. Seyler e un trattato sul ginseng, in origine la sua tesi di laurea. Le altre opere, per lo più brevi opuscoli usciti tra il 1730 e il 1740, dimostrano l'ecclettismo ma anche la mancanza di sistematicità dei suoi interessi: scrisse delle piante e degli insetti che aveva osservato sulla costa spagnola durante uno scalo del suo viaggio alla volta dell'Italia, del cosiddetto agnello vegetale o barometz, della cocciniglia polacca cui la sua famiglia doveva la propria ricchezza, di una foglia preistorica racchiusa nell'ambra, di alcuni tipi di molluschi fossili, delle ossa e dei denti di mammut scoperti in Siberia da un altro dei suoi amici, il conterraneo Daniel Gottlieb Messerschmidt. Come si vede, la paleontologia finì per occupare un posto importante nelle sue ricerche. Dalla moglie ebbe ben otto figli, ma tutti i maschi morirono bambini o in giovane età. In una commovente lettera a Linneo, confessa di essere vecchio e malato e provato dalla morte dell'unico maschio superstite, morto a ventiquattro anni nel 1740. Gli rimanevano invece quattro figlie, tre delle quali coltivarono gli interessi naturalistici di famiglia in uno dei pochi modi concessi all'epoca alle donne (escluse anche dalla lingua della scienza, il latino): la pittura. Saper danzare, strimpellare un clavicembalo e dipingere alla meno peggio un acquarello faceva parte dell'educazione delle fanciulle di buona famiglia, ma per Constantia Philippina (1708-?), Anna Renata (1713-1759), Johanna Henrietta (1714-1797) Breyne, cresciute praticamente in un museo naturalistico dove potevano ammirare le opere di grandi illustratori e in uno dei giardini botanici privati più belli d'Europa, dipingere piante e animali fu qualcosa di più di un passatempo. Nelle collezioni del castello di Gotha sono conservati molti loro disegni e acquerelli, caratterizzati da un livello di esecuzione notevole per delle dilettanti. Ciascuna di loro si specializzò in un capo preciso: i disegni di piante e uccelli si devono per lo più a Anna Renata (che era anche poetessa e musicista) e in parte a Constantia Philippina; Johanna Henrietta si dedicò alle immagini di animali marini. In almeno un caso, abbiamo la prova che i disegni di piante, presi dal vivo nello splendido giardino, erano destinati a illustrare le opere del padre. Furono utilizzati anche da almeno uno dei naturalisti che frequentavano casa Breyne, Jacob Theodor Klein. Impegnato anche nella creazione della prima società naturalistica polacca, Breyne fece della sua casa-museo un luogo di incontro dei naturalisti e ne incoraggiò l'attività, finanziando tra l'altro la pubblicazione della Flora quasimodogenita di Georg Andreas Helwing, di cui scrisse anche la prefazione. Johann Philipp Breyne morì nel 1764. Due anni dopo gran parte delle sue collezioni fu acquistata dagli agenti di Caterina II e finì nella Kunst Kamera imperiale di San Pietroburgo. Quasi tutti i manoscritti dei due Breyne, le lettere e i disegni rimasero però a Danzica fino alla morte dell'ultima delle sue figlie (1797); due anni dopo furono acquistati da Ernesto II di Sassonia-Gotha.  Un albero dalle foglie rosa Nonostante vivessero in una città tanto periferica, le opere e le attività di padre e figlio erano ben note ai naturalisti europei, con i quali, come abbiamo visto, i due si mantennero in assiduo contatto epistolare. Il primo a voler celebrare Breyne padre fu Plumier che ne ammirava grandemente la Centuria prima per la nitidezza dei caratteri tipografici, l'eccellenza delle incisioni e il contributo alla conoscenza di tante nuove piante. Ma nel dedicargli il genere Breynia il buon frate incorse anche in una fake news: chissà attraverso quali fonti, gli era giunta la notizia che quella Centuria fosse la sola superstite di parecchie, ma "delle quali, oh, dolore!, ne sopravvive una sola prima e ultima; tutte le altre furono distrutte dalle fiamme inique, come riferiscono, di un incendio fortuito che distrusse la casa e le opere. Ma l'opera di un tale uomo e la sua memoria tra gli uomini per bene e i botanici né le fiamme né le onde potranno farle perire". Linneo fece propria la denominazione e la ufficializzo in Species plantarum, nel 1753. Senza considerare che il nome non era più disponibile (all'epoca non c'erano ancora regole fisse) nel 1776 i Forster dedicarono ad entrambi i Breyne un secondo genere Breynia con una motivazione che ben testimonia la reputazione dei due naturalisti di Danzica: "In onore dei sommi botanici Jacob Breyne e suo figlio Johann Philipp Breyne, dottore in medicina, entrambi i quali coltivavano piante esotiche in un giardino di Danzica e molte le pubblicarono disegnate con grande arte e descritte con ingegno immortale". Benché il nome linneano preceda quello dei Forster, quest'ultimo è considerato nomen conservandum ("nome da conservare") perché comprende almeno una specie piuttosto coltivata e diverse specie alquanto diffuse nell'Asia meridionale e orientale. Breynia J.R.Forst. & G.Forst. (famiglia Phyllanthaceae) è comunque un genere dalla tassonomia travagliata, che minaccia prima o poi di confluire in Phyllanthus, Al momento attuale comprende, a seconda delle fonti, da 25-30 specie a oltre 90. Sono alberi o arbusti monoici diffusi nell'Asia tropicale, in Australia e nelle isole del Pacifico. Come abbiamo visto, una specie indiana e indocinese, Breynia vitis-idaea, fu descritta per la prima volta proprio da Jacob Breyne. La specie più nota è Breynia disticha, nativa della Nuova Caledonia e delle Vanuatu. Conosciuta con il nome comune "albero della neve", è coltivata nei giardini delle zone a clima mite per le foglie, rosa nella forma giovanile, poi crema o verde chiaro. Alcune specie di questo genere, tra cui proprio B. vitis-idaea, sono anche studiate dai biologi come esempio di mutualismo e coevoluzione con alcune falene del genere Epicephala, che impollinano i fiori, assicurando così la produzione di semi vitali, ma depongono anche le loro uova nell'ovario; i semi potrebbero essere distrutti dalle larve, se nonché in alcuni frutti esse abortiscono e non riescono a svilupparsi. Questo meccanismo è stato paragonato al mutualismo obbligato tra il fico e le sue vespe impollinatrici. Del medico veneziano Lionardo Sesler (o Leonardo, ma lui preferiva firmarsi nel primo modo) oggi ci rimangono un ritratto, un manoscritto copiato di sua mano, una lettera pubblicata nell'opera di un amico con la dedica di un nuovo genere - ormai ridotto a sinonimo - e poche notizie non sempre affidabili. Eppure intorno alla metà del Settecento il suo nome era noto anche al di fuori dei confini della Serenissima, e anche di più lo era l'orto botanico privato che aveva creato nell'isola di Sant'Elena, nel sestiere Castello. Fu il ricordo indelebile di quel giardino a spingere Scopoli a dedicargli il genere Sesleria, di casa nei prati aridi anche di casa nostra, divenuto così il suo ricordo più importante e concreto. 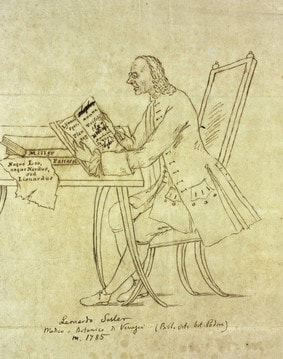 Un medico veneziano appassionato di piante Intorno al 1745 un giovanissimo Giovanni Antonio Scopoli giunse a Venezia, deciso ad approfondire lo studio della medicina e della botanica, alla quale aveva incominciato ad appassionarsi esplorando le sue montagne. Tra i luoghi che frequentava si può dire quotidianamente spicca il giardino che il medico veneziano Lionardo ( o Leonardo) Sesler aveva creato nell'isola di Sant'Elena, all'estremità orientale della città, così evocato dallo stesso Scopoli nella prima edizione di Flora carniolica (1760): "Nella nostra memoria rimane indelebile il giardino, di sovente visitato, bellissimo e ricchissimo di piante rare, creato a Sant'Elena dal dottor Leonardo Sesler, uomo sommamente curioso delle scienze naturali". In quegli anni a Venezia Sesler era senza dubbio una riconosciuta autorità per "l'osservazione e la coltivazione delle piante" (anche queste sono parole di Scopoli), ma le informazioni che ci rimangono su di lui sono poche e sfuggenti. Stando a Saccardo, la sua famiglia era di origini tedesche, ma nacque a Venezia, in quale anno non sappiamo. Mosé Giuseppe Levi nel 1835, dunque una sessantina di anni dopo la sua morte, riferisce che morì nel 1785 all'età di ben 102 anni; sarebbe nato dunque nel 1683, una data davvero improbabile. La data di morte è invece confermata tra l'altro da un suo ritratto a penna conservato nella biblioteca dell'orto botanico padovano, in cui lo vediamo intento a leggere un manoscritto con molte correzioni; sul tavolo di fronte a lui, due volumi, uno forse un testo medico di Falloppio, l'altro indubbiamente il dizionario di Miller, e un cartiglio che recita: "Neque Leo, neque Nardus, sed Lionardus" (Non sono né leone, né nardo [un animale e una pianta] ma Leonardo). Alto e segaligno, con gli occhiali, non è certo un ottuagenario; purtroppo però il ritratto non è datato e anche il Garden's Dictionary, con le sue 8 edizioni, non ci aiuta. Sempre secondo Levi fu medico molto stimato, specializzato in ostetricia (a questo potrebbe alludere il volume di Falloppio); presumibilmente si laureò a Padova e certamente fu legato a Giulio Pontedera, prefetto dell'orto padovano dal 1719 al 1757, visto che sempre nella biblioteca dell'istituzione patavina è conservato un manoscritto di mano di Sesler che consiste in una copia della prima parte del primo volume della storia dell'Orto Botanico di Padova dello stesso Pontedera. Se la data di nascita riferita da Levi fosse affidabile, i due sarebbero stati quasi coetanei (anzi il minore d'età risulterebbe Pontedera, nato nel 1688). C'è da dubitarne, se consideriamo che una seconda amicizia padovana ci porta a tutt'altra data: si tratta di Vitaliano Donati, con il quale Sesler potrebbe aver erborizzato in Veneto, Friuli e Istria negli anni '40. E proprio in appendice all'edizione olandese (1757) della Storia naturale dell'Adriatico di Donati compare l'unica opera edita di Sesler: la lettera nella quale egli istituisce in onore dell'amico il genere Vitaliana, sulla base di una pianticella da lui raccolta sul monte Pellegrino sopra Cividale (oggi Androsace vitaliana); la lettera testimonia anche la sua grande ammirazione sia per il giovane amico e la sua sensazionale scoperta della natura animale dei coralli, sia per Linneo, definito omnium naturalium rerum lumen fulgentissimum. Come si è visto, agli anni '40 ci riporta anche la testimonianza di Scopoli. Molte delle piante rare che egli notò nel giardino di Sant'Elena dovevano essere il frutto delle erborizzazioni di Sesler nei territori della Serenissima; la sua fama dovette però superarne i confini, tanto da essere citato anche da von Haller. Secondo Levi, quando Sesler fu nominato chirurgo dell'ospedale di San Pietro e Paolo, sempre nel sestiere Castello, vi trasferì il giardino, ma colui che gli successe nell'anno della sua morte "quasi cignale ne ha lo interamente guastato, poiché meglio gli piacque vedervi sorgere piante di frutta saporite". Difficile credere che Sesler mantenesse il "grave suo ufficio" (così lo definisce Levi) a 102 anni! Forse se gliene togliamo venti o trenta, i conti tornano di più... Sempre a Padova e agli anni '40 ci riporta infine una terza documentata frequentazione di Sesler: quella con l'abate Filippo Vicenzo Farsetti: il ricchissimo nobiluomo nel 1744 affidò all'architetto Paolo Posi il compito di trasformare la sua villa di Santa Maria della Sala presso Padova in una residenza degna di Versailles; il parco, progettato dal francese Charles-Louis Clérisseau, si arricchì di templi, laghetti, labirinti, parterres, boschetti. Ma Farsetti volle anche un orto botanico ricco di piante rare; Lionardo Sesler, stimatissimo "fiorista" (cioè esperto di piante anche ornamentali) fu il suo principale consulente; secondo alcune fonti ne fu addirittura il direttore o curatore, ma è difficile pensarlo, visto che continuava a risiedere a Venezia e ad esercitarvi molto attivamente la medicina.  Là dove fioriscono i prati di Sesleria Fu tuttavia il giardino di Sant'Elena tanto ammirato da Scopoli a fare entrare il medico veneziano nella lista dei dedicatari di generi botanici; il grato botanico trentino volle infatti dedicargli Sesleria, stabilito sulla base di una graminacea che cresceva copiosa nei luoghi sassosi nei pressi di Idrija (attuale Slovenia); Scopoli non le assegnò un nome specifico, ma potrebbe trattarsi di S. caerulea. Oggi al genere sono assegnate da 30 a 40 specie, una delle quali in Nord Africa, le altre diffuse dall'Europa all'Iran, con centro di diversità nei Balcani, dove ne vive circa l'80%. Ne è ben fornita anche la flora italiana, con una dozzina di specie, cinque delle quali endemiche: S. calabrica (Massiccio del Pollino e Catena dell'Orsomarso a cavallo tra Lucania e Calabria); S. italica (Appennini centrali e settentrionali, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria Marche e Lazio); S. nitida (Appennini centrali e meridionali, Sicilia); S. pichiana (Appennini settentrionali, con stazioni sparse dal Piemonte e dalla Liguria all'Emilia); S. x tuzsonii (endemismo del Monte Procinto nelle Alpi Apuane, possibilmente sinonimo di S. autumnalis). Specie pioniere dei prati aridi e rocciosi, soprattutto nelle aree montane, le Sesleriae sono le erbe dominanti dei seslerieti, talvolta insieme ai carici. Nelle Alpi, il seslerieto da Sesleria caerulea colonizza pendii aridi, scoscesi e assolati su substrati calcarei della fascia montana e prealpina ed è ricco di fioriture, con specie come Aster alpinus, la stella alpina Leontopodium alpinum, Potentilla aurea, Anemone alpina, Viola calcarata e l'orchidea Gymnadenia nigra (sin. Nigritella nigra). Insieme a Carex sempervirens costituisce il seslerieto-sempervireto. Negli Appennini, dove è presente dal piano montano a quello alpino in pendii fortemente aridi e lungo le creste esposte al vento, il seslerieto è dominato da S. juncifolia o da S. appenina, anch'esse con un ricco corteggio di compagne tra cui spiccano Pedicularis elegans subsp. elegans, Carex kitaibeliana, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Androsace villosa, Astrantia tenorei, Leontopodium nivale, Gentiana dinarica, Pulsatilla alpina subsp. millefoliata, Linum alpinum. Oltre a costituire la base dei tappeti di fiori multicolori che ammantano le montagne, le Sesleriae stanno entrando anche in giardino, per la robustezza, le scarse esigenze, e l'indubbio valore decorativo; quelle più facilmente disponibili nei vivai sono S. caerulea, apprezzata per i ciuffi sempreverdi di foglie glauche, e S. autumnalis, interessante anche per le spighette argentee prodotte a partire da settembre. Da Sesleria intorno alla metà del secolo scorso è stato separato il molto affine genere Sesleriella, con una o due specie di minuscole erbe rupicole delle Alpi orientali (Italia, Svizzera, Austria e Slovenia): si tratta di S. sphaerocephala, e forse da S, leucocephala, oggi per lo più considerata una variante cromatica della precedente. Altre notizie nelle rispettive schede di Sesleria e Sesleriella. Non c'è dubbio che, tra i botanici che hanno avuto l'onore di ricevere la dedica di un genere da Linneo in persona, a fare le parte del leone siano i medici e cattedratici tedeschi. Del resto, in quel mosaico di città libere e di principati laici ed ecclesiastici che la Germania fu fino all'età napoleonica, quasi nessun centro di una qualche importanza rinunciava a una propria Università; molte avevano una facoltà di medicina, dove si insegnava botanica farmaceutica e in genere c'era un orto botanico, per lo più adibito soprattutto alla coltivazione delle piante medicinali (i semplici). Tra secondo Cinquecento e inizio Settecento, due furono soprattutto gli ambiti che interessarono i botanici tedeschi (solitamente laureati in medicina e quasi sempre medici di professione): da una parte la flora locale, con una relativamente copiosa produzione di Flore di territori circoscritti; dall'altra la sistematica. In entrambi troviamo impegnati due fratelli di Halle: Christoph e Christian Knaut. Il primo scrive una flora dei dintorni della città, in cui classifica le piante seguendo il sistema di Ray con qualche modifica; il secondo, più giovane di quasi una generazione, crea un proprio sistema di classificazione, basato essenzialmente sui petali. Non senza una frecciatina polemica, in Hortus Cliffortianus Linneo gli dedica il genere Knautia, anche se più tardi, in Critica botanica, estende la dedica anche al fratello maggiore. Due fratelli, due generazioni a confronto A fine Seicento, nonostante si facessero ancora sentire il segni della Guerra dei Trent'anni che nella prima metà del secolo aveva devastato in profondità i territori dell'Impero, in Germania si contavano quasi trenta università; l'ultima ad arrivare, quasi allo spirare del secolo, fu quella di Halle, fondata nel 1691, per volontà del principe elettore di Brandeburgo. Anche questa relativamente importante città del Magdeburgo, all'epoca città libera, aveva gravemente sofferto per il conflitto, finché nel 1680 fu annessa al Brandeburgo. Nell'intento di risollevarla, il principe elettore Federico III (il futuro Federico I di Prussia) volle dotarla di un ateneo, presto celebre per gli studi giuridici, filosofici e teologici e come centro promotore del pietismo luterano e dell'Illuminismo tedesco. Dal 1694 vi furono aperti anche corsi di medicina. Quattro anni dopo l'elettore donava all'Università una parte dei suoi giardini per creare un hortus medicus destinato all'insegnamento della botanica farmaceutica (Materia medica), che tuttavia vivacchiò a lungo, tanto che ancora nel 1749 vi si coltivavano non più di 191 specie. Nessuno dei tre botanici prelinneani di una certa fama nati ad Halle però studiarono qui, vuoi per motivi anagrafici, vuoi per l'ancora scarso prestigio di quel nuovissimo ateneo. Si tratta dei fratelli Christoph (1638-1694) e Christian Knaut (1656-1716) e di Paul Hermann (1646-1695), che abbiamo già incontrato nei panni di direttore dell'orto botanico di Leida. Non conosciamo il percorso accademico del maggiore dei Knaut, morto lo stesso anno dell'inaugurazione dei corsi di medicina ad Halle; sembra però molto credibile l'ipotesi che abbia studiato a Lipsia (che dista da Halle appena una quarantina di km, ma faceva parte del ducato di Sassonia): infatti proprio a Lipsia egli fece stampare la sua opera più nota, un catalogo delle piante spontanee dei dintorni di Halle (Enumeratio Plantarum Circa Halam Saxonum Et In Eius Vicinia, Ad Trium Fere Milliarium Spatium, Sponte Provenientium, 1687); inoltre, per classificare le piante seguì i sistemi di Morison e Ray, il cui diffusore in Germania fu Paul Amman, professore di botanica a Lipsia dal 1674. Linneo esamina il libro del maggiore dei Knaut in Philosophia botanica e ne colloca l'autore tra i "fruttisti", ovvero coloro che hanno classificato i vegetali sulla base del pericarpo, dei semi o del ricettacolo, insieme a Cesalpino e appunto Morison e Ray, Hermann (un altro allievo di Lipsia) e la scuola di Leida. Lo svedese fa notare che il sistema di Knaut è vicino a quello di Ray, ma rovesciato: anche Knaut senior mantiene la tradizionale divisione tra erbe e alberi, e distingue le erbacee in base ai fiori perfetti (con i petali) e imperfetti (privi di petali), ma mentre Ray inizia con i fiori imperfetti, egli li mette alla fine. Le piante dotate di fiori perfetti sono poi classificate in base al frutto: carnoso, membranoso o nudo; ciascun gruppo è ulteriormente diviso in classi determinate dal numero e dalle caratteristiche dei petali (monopetale, tetrapetale regolari e irregolari, pentapetale, esapetale, polipetale) per un totale di 17 classi. Linneo recensisce l'opera, ma ne ha poca stima, e così i botanici successivi; unico merito di Christoph Knaut essere stato il primo ad usare il termine Compositae, modificando la denominazione di Ray Composito flore. Molto più stimato da Linneo è il fratello minore Christian. Era di sedici anni più giovane di Christoph, tanto che talvolta nei vecchi repertori viene detto suo figlio. Iniziò gli studi di medicina a Lipsia, dove seguì i corsi di Gottfried Welsch e Johannes Bohn per l'anatomia e di Paul Amman e Michael Ettmüller per la botanica. Completò poi gli studi a Jena, dove si laureò nel 1682 con una tesi intitolata De fermentatione in sanguine non existente. Quindi tornò nella città natale dove divenne medico personale del principe Emanuel-Lebrecht di Anhalt-Köthen che gli affidò anche la direzione della biblioteca della città di Halle. Come bibliotecario, scrisse alcuni trattatelli di argomento storico e genealogico, ma a noi interessa per la sua unica opera di botanica, Compendium Botanicum sive Methodus plantarum genuina, stampata postuma nel 1716: non una flora locale con le piante organizzate in modo sistematico come quella del fratello, ma un vero e proprio metodo per classificare le piante con forti aspirazioni teoriche. Dai tempi della Flora di Halle di Christoph sono passati quasi trent'anni e il panorama della botanica tedesca è del tutto cambiato; ora l'interesse per i "sistemi" si è fatto preminente e la nuova autorità è Rivinus (August Bachmann), che proprio a Lipsia - dove insegna ed è direttore dell'orto botanico - elabora il suo nuovo sistema basato non più sui frutti ma sulla corolla, nel quale per la prima volta erbe e alberi non sono più assegnati a classi separate. Sempre in Bibliotheca botanica, Linneo lo colloca tra i "corollisti", dove sta lui stesso, insieme a Pitton de Tournefort e vari altri, tra cui appunto il nostro Knaut junior, che, se non ne fu un seguace acritico, ne fu profondamente influenzato. Secondo Linneo, come il sistema di Christoph Knaut "rovescia" quello di Ray, il sistema di Christian Knaut "rovescia" quello di Rivinus: entrambi usano come criterio principale i petali, ma mentre in Rivinus la regolarità viene prima del numero, in Knaut junior succede il contrario. Mentre quello di Rivinus comprende 18 classi, Knaut ne prevede sostanzialmente otto, con diciassette sottoclassi: fiori con un petalo regolare e irregolare; fiori raggruppati regolari, irregolari e regolarmente irregolari; fiori con due petali regolari e irregolari; fiori con tre petali regolari e irregolari; fiori con quattro petali regolari e irregolari; fiori con cinque petali regolari e irregolari; fiori con sei petali regolari e irregolari; fiori con molti petali regolari e irregolari. Come si vede, mancano i fiori apetali, e tra poco scopriremo perché. Linneo ne apprezzò il rigore teorico (lo cita moltissime volte nelle sue opere giovanili), e in Philosophia botanica ne riprende il criterio per definire i generi; "Ogni pianta che produce le capsule dei semi nello stesso modo appartiene allo stesso genere, e così il contrario". Tuttavia non mancò di criticarlo per aver creato molti generi inutili sulla base della modalità di fioritura e, soprattutto, si fece beffe di due dei suoi assiomi più recisi. Secondo Knaut, il petalo costituisce l'essenza del fiore, dunque egli non ammette che il perianzio, gli stami e lo stilo ne facciano parte; perciò, nega l'esistenza di fiori apetali. Quanto al frutto, sostiene che ne esistono di due soli tipi: carnosi e membranacei; il primo è quello che troviamo nelle mele, nelle bacche, nelle ciliegie; il secondo comprende le capsule e quelli che i botanici del suo tempo chiamavano "semi nudi" di cui contestava recisamente l'esistenza. Aveva ragione ad osservare che tutti i frutti sono protetti da una membrana, ma sbagliava ad assimilarla a una capsula.  Knautia, una pianta "semplice" dalla tassonomia intricata Ciò che apprezzava e ciò che lasciava perplesso Linneo in Knaut junior si fondono nella dedica di Knautia, inizialmente al solo Christian, in Hortus cliffortianus (1737); erigendo a genere una specie che Boerhaave aveva separato da Scabiosa (oggi Knautia orientalis), Linneo osserva che in essa i singoli flosculi sono assai irregolari, ma insieme costituiscono un fiore regolarissimo; quanto ai semi, è assai dubbio se sono nudi o rivestiti. E aggiunge: "Dunque ci è soccorsa la memoria di Knaut che negava assolutamente i semi nudi e cercava assiduamente l'intera salvezza della botanica nell'uniformità e difformità della corolla, alla cui memoria dedichiamo questo genere". Dunque, una dedica con un pizzico di malignità (che Linneo considerava umorismo). E' chiaro che egli si riferisce a Christian, il solo Knaut che apprezzasse, ma sempre nel 1737 in Critica botanica è indicato anche il fratello maggiore, che così rientra dalla finestra tra i dedicatari di un genere botanico. Genere per altro interessantissimo. Esteso dall'Europa alla Siberia e all'Asia centrale, con la sua cinquantina di specie è uno dei più ricchi di diversità della flora europea, con tanti endemismi limitati a piccole zone, particolarmente numerosi nelle Alpi e nei Balcani. Con le sue infiorescenze a capolino che ricordano un puntaspilli (e gli inglesi la chiamano proprio così, pincushion) con numerosissimi fiorellini circondati da un involucro di squame, Knautia è un tipico rappresentate di quella che un tempo era la famiglia Dipsacaceae e ora la sottofamiglia Dipsacoideae delle Caprifoliaceae. E i semi, sono nudi o vestiti? Chi lo sa! I frutti in cui sono contenuti sono acheni o nucule che non si aprono, quindi in un certo senso fanno tutt'uno con il seme... Vestitissimi dunque, se non fosse che all'epoca di Knaut il termine semina nuda indicava proprio questo tipo di frutti. La disputa che non faceva dormire i botanici a cavallo tra Seicento e Settecento era solo una questione terminologica. Knautia è un genere dalla tassonomia intricata, in cui discriminare tra specie, sottospecie e varietà non è facile, né lo è distinguere una specie dall'altra. Vive in ambienti diversi: prati aridi ma anche umidi, pascoli alpini, boschi aperti e foreste, ma anche aree ruderali. Ad eccezione di poche specie, si tratta di perenni. Della flora italiana, oltre alla diffusissima e polimorfa K. arvensis, fanno parte una quindicina di specie, alcune delle quali endemiche: K. baldensis, presente in poche località attorno al massiccio del Baldo; K. gussonei, raro endemismo dell'Italia centrale; K. lucana, endemismo della Lucania a sud-est di Potenza; K. persicina, endemismo dei monti che circondano il lago di Garda. Altre informazioni nella scheda. Il missionario William Carey è una personalità molto nota della storia indiana. Prodigioso poliglotta, tradusse e pubblicò il Vangelo e la Bibbia in molte lingue del subcontinente, creò una tipografia, una rete di scuole, la prima università indiana. Forse è meno noto che era un appassionato botanico e un agronomo sperimentatore, e come tale fu tra i soci fondatori della Società agricola indiana, di cui dettò gli obiettivi. Il suo giardino botanico privato era il più ricco dell'India, secondo solo a quello della Compagnia delle Indie diretto dal suo amico William Roxburgh, a cui Carey donò per altro molte piante. Roxburgh ricambiò con la dedica di Careya, ma Carey lo contraccambio con un inestimabile servizio postumo: la pubblicazione di Flora indica. Una missione rivoluzionaria Nel 1755, la Compagnia danese delle Indie Orientali, in cambio di cinquemila rupie e vari doni, ottenne dal Nawab del Bengala il permesso di commerciare e di stabilire un emporio e un porto. Poté così installarsi a Serampore sulla riva dell'Hoogly, uno dei bracci del delta del Gange, un piccolo centro circondato da villaggi agricoli che già da secoli ospitava un mercato frequentato da portoghesi, olandesi e francesi. Con l'impegno di versare una tassa annuale e di far rispettare la legge e l'ordine, vi creò una minuscola stazione commerciale battezzata Frederiksnagore in onore del re di Danimarca Federico V (anche se è per lo più nota come Serampore). Rispetto a altre città dell'area controllate dalle compagnie francesi e inglesi, era insignificante ma i danesi furono abili a sviluppare attività artigianali e mercantili, attraendo mercanti europei e migliaia di indiani, impiegati soprattutto come tessitori. Nel 1777 l'amministrazione di Serampore passò alla corona danese. Grazie all'abile governatore Ole Bie (1776-1805) la cittadina conobbe un eccezionale sviluppo urbanistico, tanto da essere descritta dai contemporanei come la città più elegante e meglio amministrata dell'India europea. Gli affari andavano a gonfie vele, la presenza danese favoriva lo sviluppo dell'artigianato tessile e incise anche sull'agricoltura: i contadini vennero infatti incoraggiati ad affiancare alla traduzionale coltivazione del riso, quella l'indaco (Indigofera tinctoria), utilizzato nella tintura delle stoffe. Nel 1799 Ole Bie permise a un gruppo di missionari battisti britannici di stabilirsi a Serampore. I primi missionari battisti, John Thomas e William Carey, era arrivati a Calcutta nel 1793, ma avevano dovuto scontrarsi con l'ostilità della Compagnia inglese delle Indie che temeva che la loro attività di proselitismo causasse insanabili attriti con gli indiani; inoltre, come non conformisti con idee sociali avanzate, erano visti come pericolosi sovversivi. Il governatore Bie invece contava su di loro per creare una scuola aperta ai ragazzi tanto indiani quanto europei; per i missionari sarebbe stato un asilo dove iniziare finalmente la sospirata attività di proselitismo. A fondare la missione furono tre energici personaggi, noti come il "trio di Serampore": il maestro Joshua Marsham, il tipografo William Ward e il più famoso di tutti, il reverendo William Carey (1761-1834), una figura così eccezionale che il filantropo William Wilberforce lo definì "una delle principali glorie della nazione britannica", mentre Rabindranath Tagore lo salutò "padre del Bengala moderno". Figlio di un tessitore, nacque in un piccolo villaggio del Northamptonshire dove non esistevano scuole, finché, quando aveva sei anni, suo padre venne assunto dalla parrocchia come funzionario e maestro. Da lui ricevette una sommaria istruzione, rivelando un precoce talento per le lingue (imparò il latino da autodidatta) e un grande interesse per la natura, specialmente per gli insetti e le piante. A quattrodici anni fu collocato come apprendista presso un calzolaio e uno dei suoi compagni lo avvicinò all'ambiente dei dissidenti religiosi. Passò quindi a lavorare per un calzolaio battista; ne abbracciò la fede e ne sposò la cognata, una giovane donna analfabeta. Alla morte del padrone, ne rilevò la bottega; sempre più coinvolto nelle attività della congregazione battista, studiò i testi sacri e imparò da autodidatta altre lingue: il greco, l'ebraico, l'italiano, l'olandese e il francese, sempre con un libro sotto mano mentre fabbricava scarpe. Nel 1785, come mastro si trasferì in un villaggio più grande dove venne invitato a servire come pastore; lo diverrà a pieno tempo nel 1789. Intanto aveva incominciato a interessarsi sempre più alle attività missionarie. Nel 1792 grazie al finanziamento di un amico e correligionario pubblicò An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens, un vero e proprio manifesto in cui sostenne che ogni cristiano deve farsi apostolo del messaggio di Cristo. Lo stesso anno fu tra i fondatori della Società battista per la propagazione del Vangelo (poi nota come Baptist Missionary Society) e nel 1793, con la moglie e i figli, partì per l'India insieme al medico John Thomas. Pensava di mantenersi come agricoltore e portò con sé bulbi e semi di piante orticole e alimentari; anche in questo campo era un colto autodidatta: conosceva la classificazione linneana, e aveva una certa esperienza di raccolta sul campo. Giunto in India nel novembre 1793, venne a sapere che in seguito alla morte del colonnello Kyd il posto di intendente del giardino della Compagnia delle Indie era vacante. Si precipitò a Calcutta per presentare la sua candidatura, ma scoprì che era già stato designato William Roxburgh. La cosa non lo amareggiò, anzi andò a fargli visita: fu l'inizio di una grande amicizia. Carey scoprì ben presto che, a causa dell'ostilità della Compagnia delle Indie, gli era impossibile predicare; anche Thomas abbandonò l'impresa. Grazie a un amico, fu assunto come sovrintendente di una piantagione di indaco a Madnabati, dove visse per sei anni. Fu così testimone della miserevole condizione dei contadini indiani e si convinse che fosse compito degli inglesi risollevarla introducendo strumenti migliori e nuove coltivazioni. Vi creò un orto botanico e come l'amico Roxburgh, fece molti esperimenti agricoli. Scriveva agli amici in Inghilterra per ottenere pianticelle di piante da frutto e semi di ortaggi; da Roxburgh ebbe alberi di cannella, noce moscata, teak; a sua volta gli inviava esemplari che raccoglieva in natura. Tra di essi l'albero di sal, che nel 1798 Roxburgh pensò di dedicargli con il nome di Careya saulea. Carey respinse l'omaggio, sia per modestia sia nella convinzione che le piante debbano conservare i nomi indigeni; in effetti, le sue proteste furono accolte e la pianta fu rinominata Shorea robusta (dal nome sanscrito sarja). Furono anni durissimi che gli costarono la perdita di un figlio di cinque anni e l'alienazione mentale della prima moglie. Non aveva certo dimenticato lo scopo per cui era venuto in India; si preparò alla missione imparando il sanscrito e il bengali e tradusse in quest'ultima lingua il nuovo testamento. Dall'Inghilterra giunsero altri confratelli, in particolare Marsham e Ward che nel 1799 lo precedettero a Serampore; acquistarono una grande casa che doveva ospitare sia le loro famiglie sia i locali della scuola. Carey con la moglie e i figli superstiti li raggiunse all'inizio del 1800 portando con sé una macchina da stampa procuratagli dal proprietario della piantagione di Madnabati. Ad occuparsi della scuola furono soprattutto Joshua Marsham e sua moglie Hannah: era aperta a tutti, senza badare alla religione o alla casta: fu l'inizio di una vasta rete di scuole in lingua bengali che nel 1818 ne contava 92 frequentate da 10.000 alunni. Intanto anche la Compagnia delle Indie incominciava a convincersi che i missionari di Serampore non costituivano un pericolo, anzi potevano tornare utili per dare una patina di credibilità alla sua immagine offuscata. Nel 1801 il governatore Wellesley lo chiamò a insegnare bengali al Fort William College, una scuola dove i funzionari della Compagnia studiavano le lingue, le culture, le tradizioni e la storia dell'India. Continuò a dedicarsi con zelo allo studio del maggior numero possibile di lingue indiane e alle traduzioni e insieme a Ward creò una casa editrice, che iniziò la sua attività con la stampa del Nuovo testamento in bengali da lui tradotto; seguirono il Nuovo testamento in sanscrito, in marathi, in panjabi, e l'intera Bibbia in bengalese. Entro il 1835, l'anno successivo alla morte di Carey, la Bibbia era stata tradotta e stampata in non meno di 42 lingue e dialetti. Ma non si pubblicavano solo testi religiosi: nello stesso arco di tempo, la casa editrice giunse a stampare oltre 200.000 volumi: c'erano classici della tradizione indiana come il Mahabaratha e il Ramayana, grammatiche, lessici e dizionari per l'uso del Fort William College, ma anche - come vedremo meglio tra poco - testi scientifici. A partire dal 1818 venne anche pubblicato un quotidiano bilingue, in inglese e bengali. Anche se nel 1812 un devastante incendio distrusse manoscritti, carta, set di caratteri tipografici, le macchine da stampa si salvarono; la tipografia rimase ufficialmente attiva fino al 1837, ma anche dopo questa data uscì ancora occasionalmente qualche volume. Nel 1818 Carey, Marsham e Ward fondarono il Serampore College, destinato sia ai futuri pastori, sia a studenti di "ogni casta, colore o paese". Posto inizialmente sotto la giurisdizione danese, quindi passato sotto controllo britannico dal 1845, è considerato la prima università indiana, di cui ha costituito un duraturo modello. 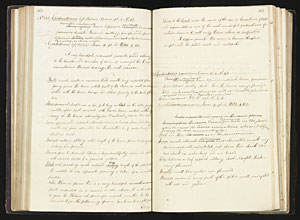 Carey e Roxburgh: una collaborazione fraterna Per Carey, la coltivazione di un giardino era una passione, un svago salutare per la mente e il corpo, ma lo studio delle scienze naturali aveva anche un risvolto religioso: la lettura del libro della natura avvicina a Dio quanto quella della Bibbia. Al suo arrivo a Serampore, portò con sé le piante che coltivava a Madnabati e creò un orto botanico privato; più tardi, quando in seguito a dissidi con la casa madre in Inghilterra lasciò la Baptist Missionary Society e si trasferì nel College, vi spostò anche il giardino. Misurava cinque acri, vantava una collezione di migliaia di piante (seconda solo a quella del giardino di Calcutta della Compagnia delle Indie), quattro vasche per le piante acquatiche, voliere per gli uccelli. Dopo la sua morte (1834), divenuto giardino del Serampore College, fu posto sotto la direzione di Joachim Otto Voigt, che ne scrisse il catalogo, insieme a quello dell'orto botanico di Calcutta (Hortus suburbanus Calcuttensis, 1845). Alcune piante erano state raccolte dallo stesso Carey, molte le aveva ottenute dai suoi corrispondenti, molto numerosi tanto in India quanto all'estero, grazie alla rete delle missioni e ai suoi contatti con studiosi, proprietari terrieri e filantropi indiani. Collezionava anche acquarelli di piante e insetti dipinti da artisti indiani, di alcuni dei quali fece dono alla Linnean Society di Londra di cui divenne membro nel 1823. Fin dai tempi di Madnabati, era molto interessato ai risvolti pratici della botanica e all'agricoltura; per sostenere la missione, progettò una piantagione di alberi da legname, cui dovette rinunciare perché la Compagnia delle Indie non concesse i terreni. Nel settembre 1820, su sollecitazione di lady Hastings, la moglie del governatore generale dell'India, insieme a Joshua Marsham e altri due europei fondò l'Agricultural and horticultural society of India, che entro un mese, posta sotto il patronato di lord e lady Hastings, che concessero anche un terreno sperimentale a Barrackpore, contava già cinquanta soci, metà europei e metà indiani. Gli obiettivi della società, fissati dallo stesso Carey, includevano il miglioramento dei terreni, tramite metodi di coltivazione più avanzati, incluse le più efficienti tecniche di rotazione delle culture; l'introduzione di nuove piante utili; il miglioramento delle attrezzature; il miglioramento degli animali agricoli; la bonifica e la coltivazione dei terreni abbandonati. Fin da quando si conobbero nel 1793, la collaborazione tra Carey e William Roxburgh fu strettissima. Il missionario considerava il suo stesso giardino quasi una succursale dell'orto botanico di Calcutta cui donò non meno di ottanta esemplari. Tra di essi, forse il più notevole è l'himalayana Rosa clinophylla (che Roxburgh chiamava R. involucrata) da lui spedita al giardino di Calcutta nel 1797; negli anni venti, ne inviò un esemplare anche a Hooker, all'epoca direttore dell'orto botanico di Glasgow. Nel 1813, quando Roxburgh, lasciò l'India nella speranza di recuperare la salute (sarebbe purtroppo morto poco più di un anno dopo) gli affidò due manoscritti: il catalogo dell'orto botanico di Calcutta Hortus Bengalensis e la sua monumentale Flora indica. Il primo fu pubblicato dalla tipografia di Serampore già nel 1814, con una prefazione dello stesso Carey. Durante il suo servizio in India (dal 1773 al 1813, interrotti solo da due brevi soggiorni in patria) Roxburgh descrisse circa 2600 specie, e di circa 2500 fece preparare i disegni. Nel 1795, quando da poco si era trasferito a Calcutta, una selezione di cento piante da lui raccolte in Cormandel fu pubblicata a spese della Compagnia delle Indie nel primo volume di Plants of the Coast of Coromandel, sotto la direzione di Joseph Banks e con la prefazione di Patrick Russell. Seguirono, a lunghi intervalli di tempo, altri due volumi, in tutto trecento piante; l'ultimo uscì nel 1819, dopo la morte di Roxburgh. Negli anni di Calcutta, quest'ultimo aveva continuato a lavorare alla sua Flora indica, un grosso manoscritto con 2542 descrizioni botaniche di cui preparò due copie. Per prudenza, tornando in patria una la portò con sé, con l'intenzione di completarla e prepararla per la stampa, l'altra la affidò a Carey. Durante il viaggio, aggiunse ancora alcune descrizioni, e inviò copia anche di queste a Carey. Le gravi condizioni di salute e la morte però gli impedirono di attuare il suo proposito. Non trovandosi in Inghilterra nessuno disposto a pubblicarlo (Plants of the Coast of Coromandel, tre volumi in folio con illustrazioni a piena pagina, si era rivelato costosissimo), Carey decise di stamparlo nella tipografia di Serampore. Con l'aiuto di Nathaniel Wallich (assistente di Roxburgh e suo successore alla testa dell'orto botanico di Calcutta dal 1817) che aggiunse le sue note, ne pubblicò una parte in due volumi, usciti rispettivamente nel 1820 e nel 1824. Nel 1832, su richiesta dei figli di Roxburgh, visto che ancora mancava un'edizione inglese, pubblicò l'intera opera in tre volumi, questa volta senza le note di Wallich. Tanto la prima edizione parziale, quanto la seconda edizione integrale per ragioni di costi furono stampate senza illustrazioni. Anche così, è un'opera fondamentale, fondativa della botanica indiana, di cui Roxburgh è considerato il padre.  Un albero dai molti usi Se Carey aveva rifiutato la dedica dell'albero di sal, dovette accettare un secondo omaggio di Roxburgh che nel 1811 nel secondo volume di Plants of the Coast of Coromandel gli intitolò il genere Careya sulla base di un esemplare di C. erbacea, raccolto dal missionario in Bengala e da lui inviato all'orto botanico di Calcutta; Roxburgh ricorda queste circostanze e aggiunge "nominata per il suo scopritore, un buono botanico, e un promotore della storia naturale in generale". Se avesse dovuto far propria la propensione di Carey per le denominazioni indigene, avrebbe dovuto chiamarla Kumbhaadu-lataa. Il genere Careya (famiglia Lecythidaceae) comprende tre specie, distribuite tra Afghanistan, isole Andamane, subcontinente indiano, Indocina e Malaysia. C. herbacea è un'erbacea perenne diffusa dalle pendici himalayane al Bengala; C. valida, un albero endemico delle isole Andamane. La specie più nota è però C. arborea, anch'essa descritta da Roxburgh. E' un bell'albero da medio a grande, deciduo, con le foglie che diventano rosse prime della caduta. Produce vistosi fiori a coppa crema o bianco verdastro con lunghissimi stami e filamenti sterili, porpora o soffusi di rosso alla base. All'epoca del Raj, la sua corteccia fibrosa veniva usata per gli stoppini dei fucili. Nella medicina tradizionale indiana, la corteccia e i fiori, ricchi di mucillaggini, trovano impiego per le loro proprietà astringenti. In Myanmar le grandi foglie vengono usate per fabbricare i tradizionali sigari detti cheroot, ma fermentate entrano in alcune specialità culinarie. In Tailandia invece le foglie giovani e i boccioli si consumano freschi in insalata. Il frutto è edule (tanto che l'albero è noto come guaiava selvatica) ma si ritiene che i semi siano lievemente tossici. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
March 2024
Categorie
All
|
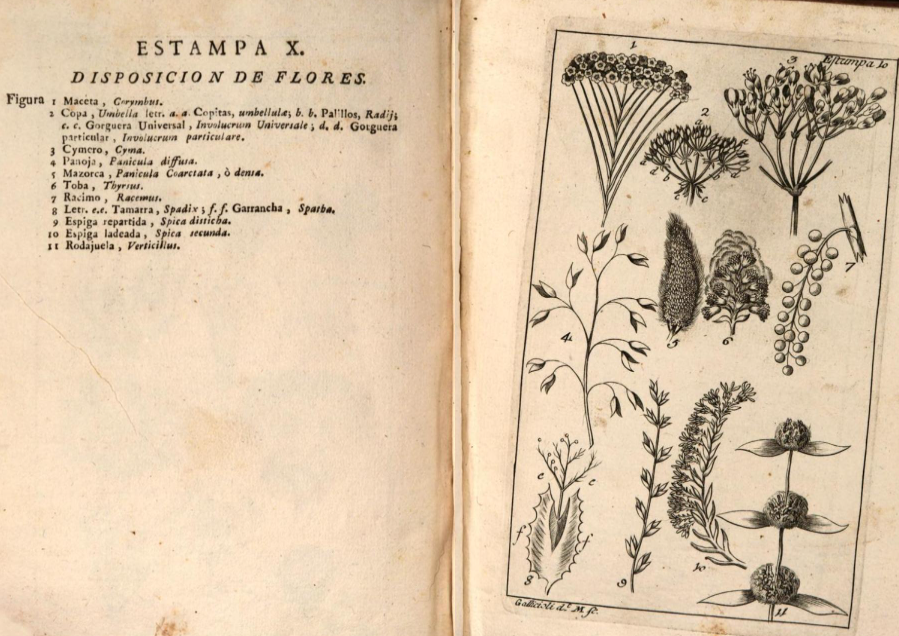
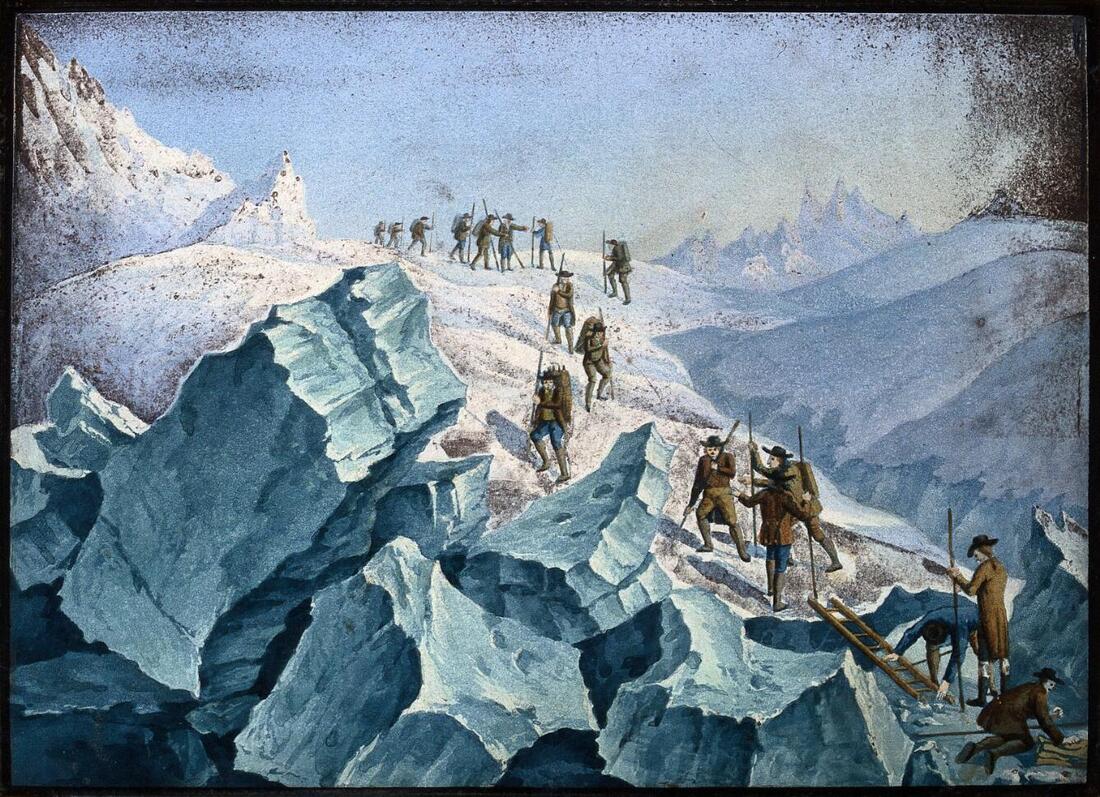


 RSS Feed
RSS Feed