|
La botanica francese esordisce con un traduttore e un erudito, Jean Ruel, autore di eccellenti traduzioni dal greco in latino e di due sillogi del sapere scientifico degli antichi, la prima dedicata alla medicina veterinaria, la seconda alle piante officinali. Si tratta di De natura stirpium, in cui le nozioni estratte da Teofrasto, Dioscoride e Plinio vengono attualizzate cercando di ritrovare - spesso con risultati poco credibili - le piante degli antichi negli orti, nei giardini e nei prati di casa. Al di là dei suoi limiti, l'opera (che è anche quasi l'unica a riprendere gli insegnamenti di Teofrasto) ha il merito di trasmetterci il più antico elenco di piante in lingua francese. Di questo antesignano della botanica d'oltralpe non poteva dimenticarsi Charles Plumier, che gli dedicò lo splendido (e vario) genere Ruellia. 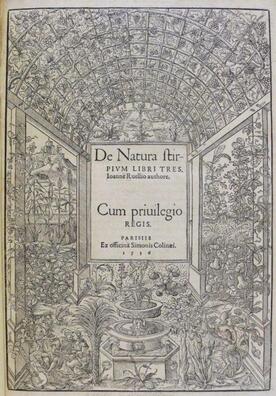 La botanica francese inizia con un grande traduttore Nel 1499, con l'aiuto di eruditi greci, Aldo Manuzio pubblica la prima edizione a stampa del testo greco di Dioscoride. Questa edizione, che include anche due trattati apocrifi sui veleni, fornirà la base per le traduzioni cinquecentesche in latino e nelle lingue moderne. Una delle prime, e delle più prestigiose, esce a Parigi nella primavera del 1516 ad opera del medico e filologo Jean Ruel (1479?-1537). Della vita di questo personaggio poco conosciamo, ad eccezione di qualche aneddoto. Il primo vuole che avesse appreso da autodidatta le lingue classiche, che tanto mirabilmente padroneggiava. Il secondo ci racconta che, rimasto vedovo, fu sollecitato dal vescovo di Parigi a abbracciare lo stato ecclesiastico, in modo da avere più tempo per lo studio; fu così che divenne canonico di Notre Dame. Sappiamo inoltre che tra il 1508 e il 1510 fu preside della facoltà di medicina di Parigi e per un certo periodo fu anche uno dei medici del re Francesco I, dedicatario di diverse sue opere. Una sintesi di queste poche notizia nella vita. Ma torniamo alla traduzione di Dioscoride. Pubblicata per i tipi di Henri Estienne il vecchio, si tratta di un lavoro eccellente in cui Ruel poté unire all'eleganza del linguaggio e alla competenza di filologo quella di medico e di botanico; la seconda edizione, riveduta e corretta (1530), ebbe successo europeo e divenne il punto di partenza per i tanti commenti di Dioscoride del Rinascimento, compreso quello di Mattioli. Nel corso del secolo ne uscirono venti edizioni. L'opera di traduzione di Ruel proseguì con Hippiatrika o Veterinariae medicinae (1530), a quanto pare commissionatagli da Francesco I, che consiste in una silloge di tutto ciò che era stato scritto in greco sui cavalli e la medicina veterinaria. Tradusse anche diverse opere di medicina, la più importante delle quali è De Methodo Medendi del medico bizantino Johannes Auctarius, uscita postuma (1539) con il titolo De Medicamentorum Compositione. Grazie a traduzioni, caratterizzate da una lingua elegante e da una perfetta intelligenza del testo di partenza, fu soprannominato, forse dall'amico Budé, l'"aquila degli interpreti". L'opera che lo fa entrare di diritto nella storia della botanica non è però una traduzione: De natura stirpium ("Sulla natura delle piante", 1536), analogamente al volume sulla medicina veterinaria, è una silloge in cui il medico-filologo riunì tutte le conoscenze dell'antichità sulle piante e sulla botanica applicata alla medicina; il grosso volume di oltre mille pagine, caratterizzato dall'alta qualità tipografica ma privo di immagini, si apre con un bel frontespizio: sotto una lussureggiante pergola d'uva vediamo un orto-giardino con piante locali ed esotiche (come la palma sulla sinistra) e una fontana che culmina in un amorino; sulla destra una curiosa figura alata con gambe caprine (un demone? un fauno? l'allegoria del tempo?), sulla sinistra una elegante coppia che, lasciata da parte la chitarra, si intrattiene a leggere in un grande libro (forse il libro della natura, o questo stesso che qui si apre). Il primo dei tre libri esordisce con una introduzione generale alla botanica tratta da Teofrasto; è questo un tratto originale del lavoro di Ruel, di fatto il solo autore del Rinascimento (ad eccezione del molto posteriore Cesalpino) a valorizzare l'insegnamento del poco studiato filosofo greco; di notevole interesse è anche il tentativo del nostro medico linguista di definire con precisione un vocabolario latino per le diverse parti delle piante. Segue poi la trattazione di circa seicento piante medicinali: prima gli alberi in ordine alfabetico (seconda parte del primo libro), poi le erbe coltivate (secondo libro), poi tutte le altre (terzo libro), parte in ordine alfabetico, parte raggruppate secondo criteri non sempre evidenti. Qui i nomi di riferimento sono Dioscoride e, anche di più Plinio. Tuttavia Ruel tentò di attualizzare l'insegnamento degli antichi, accostandovi le ricerche dei moderni e la sua stessa esperienza di medico e di conoscitore delle piante officinali. Fu così che ai nomi latini e greci unì quelli volgari, cercando di identificare nella flora francese (o meglio, dei dintorni di Parigi) le piante descritte da Dioscoride e Plinio. Queste identificazioni, che hanno anche un intento nazionalistico - l'opera è dedicata al re Francesco I e vuole dimostrare la grandezza del Regno di Francia anche in questo campo - sono per lo più arbitrarie, ma hanno il merito di fornirci il più antico elenco di piante in lingua francese. Inoltre, alle piante degli antichi Ruel volle aggiungere anche qualche specie esotica: proprio nelle sue pagine, ad esempio, troviamo la prima attestazione del dragoncello, pianta russa e asiatica che da pochissimo era stata introdotta in Europa. 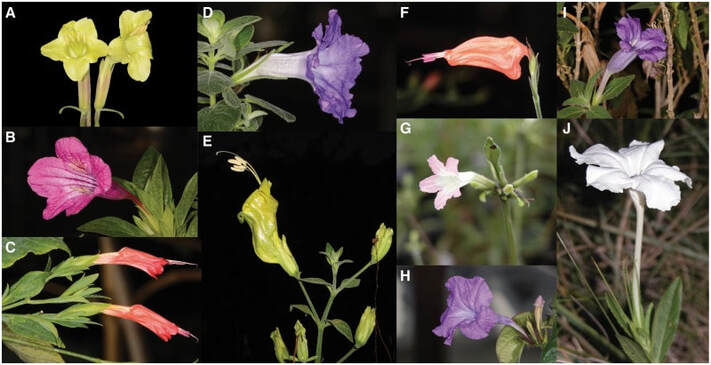 Ruellia, ovvero viva le differenze! A questo antesignano della botanica francese Charles Plumier volle dedicare uno dei suoi nuovi generi americani, Ruellia, poi validato da Linneo. Il secondo per grandezza della famiglia Acanthaceae, è un genere sempre più presente nei nostri giardini grazie alle bellissime fioriture. Estremamente ricco e vario, per secoli è anche stato un vero rompicapo per i tassonomisti, che ora lo hanno allargato, ora ristretto, finché a soccorrerli non è arrivato il contributo dell'analisi molecolare. Diffuso in un gran numero di specie (valutate in circa 350) nell'America temperata e nella fascia tropicale di Americhe, Africa, Asia, il genere non è solo vastissimo e diversificato (comprende erbacee, suffrutici, arbusti), ma anche caratterizzato da fiori sorprendentemente diversi per forme e colori, anche in specie affini: una diversità che potete facilmente notare nel collage di fotografie (tratto da un recente articolo di Zhuang & Tripp). Studi recenti hanno dimostrato che questa varietà è il risultato di una iper-specializzazione evolutiva, ovvero un adattamento ai diversi impollinatori. Le specie che sono impollinate da insetti, in particolare api e altri imenotteri, hanno fioritura diurna, tubo fiorale breve e aperto, grandi lobi viola, organi sessuali collocati all'interno del tubo. Le specie impollinate da colibrì hanno fiori rossi diurni con tubi lunghi e lobi retroflessi, organi sessuali all'esterno del tubo. Le specie impollinate da falene hanno fiori bianchi con tubo lunghissimo, lobi molto aperti e organi sessuali all'ingresso del fiore. Infine, quelle impollinate da pipistrelli sono notturne, da gialle a verdastre, con gola molto aperta e organi sessuali che sporgono al di fuori della corolla. Vistosi, colorati e decorativi, i fiori delle Ruelliae non piacciono solo a insetti, colibrì e pipistrelli, ma anche a noi umani e diverse specie hanno trovato posto nei nostri giardini. La più diffusa è probabilmente R. simplex (spesso commercializzata con il sinonimo R. brittoniana o anche R. angustifolia), anche nota con il nome del tutto arbitrario "petunia messicana" o "petunia selvatica" (le Petuniae, ricordo, sono Solanaceae, le Ruelliae Acanthaceae); molto apprezzata per i grandi fiori color lavanda, nei climi miti può formare con il tempo dense colonie, tanto da poter diventare invasiva. Sono disponibili anche cultivar con fiori rosa e bianchi. Ma altre specie sono sempre più facilmente disponibili nei migliori vivai; su alcune di loro quale informazione nella scheda.
0 Comments
Nel Cinquecento il mercato editoriale tedesco è uno dei più vivaci centri della produzione di testi di botanica e "materia medica". Da una parte ci sono le opere in latino, spesso innovative e scritte da studiosi con una preparazione filologica o medica come Brunfels e Fuchs, che si rivolgono soprattutto a medici e studenti di medicina; dall'altra c'è una vasta produzione di Krauterbucher, "libri di erbe", che a parte qualche eccezione (come il New Kreütter Büch di Bock), sono per lo più rifacimenti di erbari manoscritti medievali, dal contenuto ben poco originale; di carattere eminentemente pratico, ma anche ricchi di curiosità, soddisfano un pubblico molto più ampio e poco esigente, che comprende farmacisti, padri di famiglia, semplici curiosi. Requisito essenziale del loro successo sono le illustrazioni xilografiche che, proprio come i testi, passano disinvoltamente da un'edizione all'altra. Tra i protagonisti di questo mondo editoriale di riedizioni, rifacimenti, riscritture, maestro del copia-incolla, è il medico e botanico Adam Lonitzer; nella maturità, divenuto egli stesso editore dopo aver sposato la figlia di uno dei maggiori stampatori e editori tedeschi, seppe fare del suo Kräuterbuch un long seller che gli sopravvisse per due secoli: uscito per la prima volta nel 1557, raggiunse infatti 27 edizioni, l'ultima delle quali è del 1783. Come gli altri autori di questo tipo di prodotto, fu anch'egli poco più di un abile compilatore; il genere Lonicera, dedicatogli da Linneo raccogliendo un suggerimento di Plumier, non premia dunque né l'originalità né la profondità di pensiero, ma il successo di un libro che ancora nel Settecento non mancava nella biblioteca di ogni studioso di botanica. 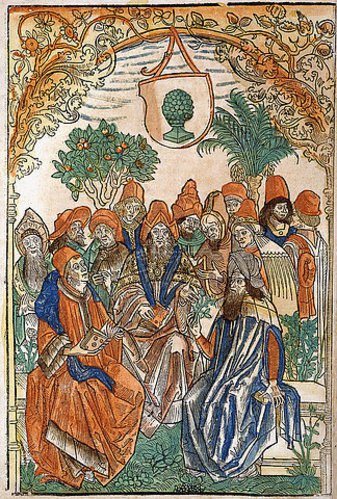 Successi commerciali e una causa per plagio Con l'invenzione della stampa, i libri si fanno più accessibili e incominciano a raggiungere un pubblico più ampio. Accanto alla Bibbia e ai classici, tra i primi testi a suscitare l'interesse di stampatori e lettori ci sono anche i manuali di medicina pratica e i libri di erbe. Particolarmente vivace è il mercato tedesco, dove il primo erbario (noto come Herbarius latinus o Herbarius moguntinus, "erbario di Magonza") venne stampato nel 1484 da Peter Schöffer, il principale collaboratore di Gutenberg; entro il 1499 giunse a toccare undici edizioni. L'anno successivo lo stesso Schöffer dava alle stampe il primo Krauterbuch ("libro d'erbe") in lingua tedesca, Gart der Gesundheit (corrispettivo del latino Hortus sanitatis), attribuito al medico della città di Francoforte Johann Wonnecke von Kaub, anche noto con il nome latinizzato Johannes de Cuba. Anche quest'opera nell'arco di pochi anni ebbe molteplici edizioni nonché adattamenti e traduzioni. Mentre l'erbario latino si rivolgeva al pubblico più tradizionale dei medici e dei farmacisti, quello in lingua locale rispondeva alle esigenze e alle curiosità di una sempre più vasta fascia di lettori che non conoscevano il latino. Né l'uno né l'altro erano opere dal contenuto originale, ma compilazioni basate sugli erbari manoscritti medievali, risalenti a loro volta ai rifacimenti medievali di Dioscoride, magari attraverso la mediazione araba. A costituire un valore aggiunto erano soprattutto le illustrazioni xilografiche, apprezzate anche dagli illetterati. A capirlo perfettamente fu il tipografo-editore Christian Egenolff (1502-1555), che operava sulla importante piazza di Francoforte sul Meno. Dotato di grande fiuto commerciale, era un editore eclettico che pubblicava di tutto, incluse partiture musicali. Nel 1533 entrò nel mercato degli erbari illustrati pubblicando Kreutterbuch von allem Erdtgewächs, un rifacimento del libro di Johannes de Cuba curato dal medico cittadino Eucharius Rösslin. Per illustrarlo, fece eseguire solo poche nuove xilografie, prendendo le altre (rimpicciolite e ruotate di 180 gradi) da Vivae icones herbarium di Brunfels, pubblicata l'anno prima a Strasburgo dell'editore Schott. Quest'ultimo, che aveva ottenuto un privilegio imperiale che gli concedeva l'esclusiva dell'opera per sei anni, lo citò in giudizio presso la Suprema corte di giustizia dell'Impero. In quella che può essere considerata la prima causa per plagio della storia dell'editoria, Egenolff si difese sostenendo in primo luogo che copiare da un libro vecchio di trenta o quarant'anni è lecito, anzi in questo caso benemerito, considerando i benefici che ne derivano per la salute pubblica; in secondo luogo, la sua non poteva considerarsi una copia del volume di Brunfels, visto che, oltre ad avere un testo completamente diverso, conteneva anche immagini originali; in terzo luogo, il privilegio editoriale riguardava la trattazione delle piante, non le loro forme: queste le impone la natura, e qualsiasi illustrazione delle piante non potrà che assomigliarsi. Un argomento specioso, ma che ben testimonia il nuovo modo rinascimentale di concepire la natura e la sua rappresentazione. Non sappiamo come finì la causa, ma è certo che Egenolff continuò imperterrito a illustrare i suoi numerosi libri di medicina e botanica con xilografie altrui. Erano pubblicazioni pensate per grandi tirature, né innovative né originali nei contenuti, ma perfette per il gusto del largo pubblico. Insomma, una specie di Reader's Digest del Rinascimento. Inoltre, per conquistare un'ulteriore fetta di mercato, Egenolff, seguendo l'esempio di Isengrin, l'editore di Fuchs, nel 1546 pubblicò un album costituito unicamente da immagini, prevalentemente di piante ma anche di animali, minerali e manufatti utilizzati in farmacia con il titolo Herbarum, arborum, fruticum, frumentorum ac leguminum... iconae. Non c'è bisogno di dire che anche in questo caso si trattava di xilografie pirata (copiate tra l'altro anche da opere di Fuchs). Sebbene non sia indicato il nome del curatore del testo, limitato all'indice e ai nomi latini e tedeschi dei semplici, gli studiosi lo identificano in Adam Lonitzer, all'epoca insegnante di matematica e promettente studente di medicina. 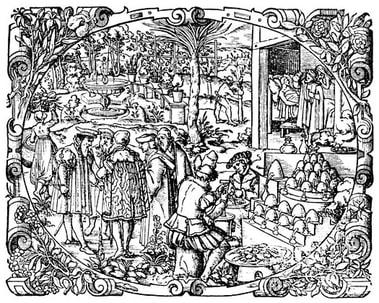 Un insuccesso editoriale e un long seller Figlio di un filologo e docente universitario di lingue classiche, Adam Lonitzer (Lonicerus nella forma latinizzata) aveva probabilmente familiarità con il mondo editoriale fin dall'infanzia. Dopo aver studiato filosofia e medicina nella sua città natale, Marburg, per completare gli studi nel 1545 si trasferì a Francoforte, dove probabilmente poco dopo entrò in contatto con Egenolff, con cui collaborò come correttore di bozze e curatore di volumi di medicina. Egenolff, che continuava a sfruttare il successo commerciale del vecchio testo di Johannes de Cuba (dopo il rifacimento di Rösslin, nel 1540 ne aveva pubblicato un'ulteriore edizione, con il titolo Botanicon, firmata da Theodor Dorstein), pensò di affidargli un'opera decisamente più ambiziosa. In effetti quel filone d'oro stava ormai esaurendosi, reso obsoleto dalle opere dei grandi botanici del Rinascimento come Mattioli, Gessner, Bock e Fuchs. Lonitzer, pur basandosi ancora una volta su quel vecchissimo testo, avrebbe dovuto attualizzarlo, dandogli una patina di novità grazie alle informazioni attinte dai più affermati moderni. Egenolff puntò su un'edizione di lusso: in lingua latina, con il titolo pliniano Naturalis historia, erano due grossi volumi in folio di 744 pagine con oltre 700 xilografie; inoltre, a quanto pare, fu messa in commercio solo la versione con le tavole acquarellate a mano (che mediamente costava il doppio di quella in bianco e nero). Per una volta, il fiuto commerciale di Egenolff sembrò venuto meno. Fu un clamoroso flop, se ancora quattordici anno dopo, nel 1565, i suoi eredi cercarono di liberarsi delle copie invendute cambiando il frontespizio per spacciarle per un'opera nuova intitolata Botanicon. In effetti, il vecchio Egenolff aveva sbagliato il target: un'opera così costosa, scritta in latino, avrebbe dovuto trovare il suo pubblico tra i dotti, agli occhi dei quali, per abile che fosse stato Lonitzer nel suo copia-incolla, si palesava immediatamente per quello che era: un centone, un patchwork con ben poca originalità. Nessuna originalità neppure nelle tavole, riciclate da opere precedenti della casa editrice e in buona parte piratate. Intanto Lonitzer faceva carriera. Nel 1553 ottenne una cattedra di matematica a Marburg e nel 1554 conseguì il dottorato in medicina; lo stesso anno fu nominato medico della città di Francoforte (incarico che avrebbe mantenuto fino alla morte, nel 1586) e sposò Magdalena, una delle figlie di Egenolff, legando per sempre le sue sorti alla casa editrice di cui, dopo la morte del suocero, nel 1555, divenne una specie di direttore editoriale. E in tale veste riuscì ad ottenere il più grande e più duraturo successo della ditta: il suo Kräuterbuch, prima edizione 1557, cui avrebbero fatte seguito altre tre durante la sua vita (1564, 1573, 1578); con rifacimenti e riadattamenti, questo long seller avrebbe totalizzato ventisette edizioni, l'ultima delle quali nel 1783. E che cos'era questo prodotto editoriale di successo? Nient'altro che la catastrofica Historia naturalis che, tradotta in tedesco, aveva finalmente trovato il suo pubblico: non più i facoltosi, dotti e smaliziati ma riluttanti acquirenti della versione latina, ma lettori di media cultura, più interessati a informazioni pratiche esposte in modo chiaro che a disquisizioni filologiche sull'identificazione delle piante di Dioscoride e Teofrasto. Del resto, sebbene sia fondamentalmente il frutto di un abile lavoro di copia-incolla, l'opera di Lonitzer ha il pregio della chiarezza e, soprattutto nella parte botanica, contiene anche qualche informazione tratta dall'esperienza diretta di medico e osservatore della natura. Ad esempio, egli fu il primo a segnalare e descrivere l'agente dell'ergotismo, il fungo parassita della segale Claviceps purpurea. Tra le parti più apprezzate del suo erbario, il primo ampio capitolo, dedicato alla distillazione. L'arte della distillazione, sconosciuta agli antichi, era un'invenzione araba che si era diffusa in Occidente nel corso del Medioevo; era dunque ancora relativamente recente e quanto mai necessaria a medici e farmacisti, perché permetteva di ricavare gli estratti alcoolici poi utilizzati per la preparazione dei farmaci. Intendiamoci, neppure qui non c'è nulla di nuovo o originale: Lonitzer riprese le sue informazioni da fonti precedenti, in particolare dal Liber de arte distillandi de simplicibus di Hyeronimus Braunswig. Tuttavia la sua esposizione e le immagini che accompagnano il testo sono tanto chiare e dettagliate che un'équipe internazionale di ricercatori le ha utilizzate per ricostruire sperimentalmente il processo di distillazione del XVI secolo. Sicuramente proprio questa parte contribuì non poco al successo del libro, tanto più che Lonitzer seppe valorizzarla fin dal frontespizio dove, sulla sinistra, in primo piano è rappresentato un farmacista che, assistito da un aiutante, sta distillando i semplici. Inoltre, c'erano anche informazioni sulla coltivazione dei giardini, anch'essa raffigurata nel frontespizio, in secondo piano sulla destra, dietro a un gruppo di dottori a consulto. Una sintesi della vita di Lonitzer come sempre nella sezione biografie.  Lonicera: bellezza e profumo Campione di vendite, il nome di Lonitzer era dunque ben noto ai cultori di botanica; grazie a questa fama Plumier gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani, battezzato Lonicera sulla base del cognome latinizzato Lonicerus. D'altra parte, è probabile che egli conoscesse solo i titoli dei suoi libri, visto che nella nota che accompagna la dedica cita come tre opere distinte Historia naturalis, Botanicon e un "herbarium vernacula lingua", ovvero il Krauterbuch. Il genere Lonicera di Plumier non è per altro quello a noi oggi familiare: appartenente alla famiglia Loranthaceae, corrisponde all'attuale genere Psittacanthus, che riunisce alcune piante parassite delle Antille e del Centro America affini al vischio. Se non fosse in contrasto con la candida personalità del buon padre Plumier, si potrebbe sospettare uno di quei ritratti vegetali al vetriolo che tanto deliziavano Linneo. Invece quest'ultimo, che aveva una copia del Krauterbuch nella sua biblioteca, volle dedicare al nostro protagonista un genere diverso e ben più importante, forse riconoscendo l'apporto di Lonitzer alla divulgazione del sapere botanico tra il vasto pubblico. Lo scrittore tedesco ci guadagnò immensamente nel cambio, aggiudicandosi Lonicera L., famiglia Caprifoliaceae, un vastissimo genere di oltre 180 specie, molte delle quali sono tra i rampicanti e gli arbusti più coltivati nei nostri giardini. Finalmente possiamo parlare di un genere anche europeo, anzi di uno di più ricchi di specie del nostro continente (ma presente anche in America settentrionale e in Asia; la sola Cina, centro di diversità del genere, ne vanta un centinaio). E quindi abbiamo a disposizione anche un nome comune, caprifoglio (dalla credenza che le capre si nutrissero delle sue foglie). In Italia ne abbiamo una dozzina di specie spontanee, legate ad ambienti diversi, le più note delle quali sono probabilmente la mediterranea L. caprifolium, la madreselva o caprifoglio comune (che dà anche il nome alla famiglia), diffusa in tutta la penisola, ma non nelle isole; l'atlantica L. periclymenum, presente solo nelle regioni settentrionali, il caprifoglio europeo più coltivato, con diverse pregevoli varietà da giardino; la montana L. xylostemum, il caprifoglio peloso, che non è un rampicante, ma un arbusto. Se infatti nell'immaginario collettivo tendiamo ad associare al nome caprifoglio a rampicanti dalle copiose e profumate fioriture, in realtà la maggior parte delle specie sono arbustive. I nostri caprifogli sono coltivati da secoli immemorabili e hanno lasciato la loro impronta anche in letteratura, ad esempio nel Lai du chievrefoil di Marie de France o nella poesia di Shakespeare. Hanno anche ispirato l'arte pittorica, dalle miniature medievali stile mille fleurs alle carte da parati di Morris. A partire dal Settecento, alle europee si è anche aggiunta la popolosa legione straniera delle asiatiche, come la profumatissima L. fragrantissima dalle fioriture precoci; la bella ma iperinfestante L. japonica; le arbustive L. nitida e L. pileata, la prima ottima pianta da siepe, la seconda eccellente tappezzante; L. tatarica, un grande arbusto dalla fioritura abbondante e prolungata. Già da un secolo era arrivata L. sempervirens, il caprifoglio della Virginia, con brillanti fiori tubolari che nel paese d'origine sono la delizia dei colibrì. Ma l'elenco potrebbe continuare, tanto più che alle già numerose specie si sono aggiunti molti ibridi orticoli. Su almeno qualcuno troverete qualche informazione nella scheda. Andrea Vesalio è noto come il padre dell'anatomia moderna: la sua spettacolare Fabrica segnò la rottura con la tradizione galenica e l'inizio dello studio del corpo umano basato sull'osservazione diretta e la dissezione. Gli interessi per la botanica furono marginali nella sua carriera scientifica, tutta rivolta all'anatomia, ma come medico di successo ebbe sicuramente a che fare con le piante medicinali, come dimostra nell'unica opera che dedicò all'argomento, da cui emerge come anche in questo campo si fece guidare dall'esperienza e da un cauto scetticismo. Per celebrare uno dei più grandi conterranei, a pochi anni dall'indipendenza nazionale, con un sussulto nazionalistico due botanici belgi gli dedicarono il genere Vesalea, cancellato appena due anni dopo la creazione, ma recentemente riportato in auge. 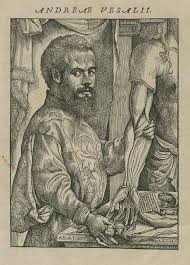 Anatomia, farmaci esotici e un tragico pellegrinaggio Il recente recupero del genere Vesalea per accogliere le specie americane di Abelia mi dà il destro di parlare di uno dei più grandi protagonisti della rivoluzione scientifica del Rinascimento, Andrea Vesalio. La sua Fabrica (De humani corporis fabrica libri septem) esce in quello stesso 1543 in cui Copernico termina, poco prima di morire, De Rivolutione orbium celestium e ha nel campo della medicina lo stesso significato di svolta e di rottura dell'opera copernicana in quelo dell'astronomia. Con questo libro, che unisce la descrizione del corpo umano basata sull'osservazione diretta a tavole spettacolari disegnate da allievi di Tiziano, nasce l'anatomia moderna. Rompendo con la tradizione galenica (di Galeno nell'edizione del 1555 elencherà 200 errori, dimostrando che le sue descrizioni anatomiche si basavano sulla dissezione di animali, non di esseri umani), Vesalio si procurerà fama, il prestigioso incarico di medico imperiale, ma anche irriducibili nemici. Il più accanito sarà il suo stesso maestro, Jacques Dubois detto Sylvius, che nel suo pamphlet "Confutazione delle calunnie rivolte contro l'anatomia di Ippocrate e Galeno da un pazzo furioso" (il pazzo furioso, in latino vesanus, è un gioco di parole per Vesalius) non esiterà a rivolgere questo appello a Carlo V: "Imploro sua Maestà l'imperatore di punire, con la severità che merita, questo mostro nato e allevato nella sua stessa casa, questo perniciosissimo esemplare di ignoranza, impudenza, arroganza e empietà, di sopprimerlo completamente, prima che possa ammorbare il resto d'Europa con il suo fiato pestilenziale". E per respingere le evidenze di Vesalio, arriverà a sostenere che Galeno aveva dato una descrizione del corpo umano perfetto, com'era ai suoi tempi, ma quest'ultimo nei secoli intercorsi si era corrotto e degenerato. Quali furono i rapporti tra il padre dell'anatomia e la botanica? Ovviamente, come tutti i medici del suo tempo Vesalio conosceva a fondo le erbe medicinali che fornivano la stragrande maggioranza dei medicamenti, tanto più che discendeva da una famiglia di illustri medici e farmacisti; inoltre divise buona parte della sua vita tra i due principali centri dell'innovazione botanica del Cinquecento: da una parte le natie Fiandre, dall'altra l'Italia (insegnò all'università di Padova, fece dimostrazioni anatomiche a Bologna e fu in contatto con l'ambiente mediceo). Quanto all'ambiente tedesco, documentati sono i rapporti personali con Fuchs, cui inviò un semplice all'epoca molto celebrato, il rhaponticum (forse Rhaponticum arthamoides); il botanico tedesco non solo utilizzò il libro di Vesalio come principale fonte del proprio manuale di anatomia (in alcune parti, un vero e proprio plagio), ma ebbe a definirlo frutto dell'illuminazione divina. La grande importanza delle immagini per la conoscenza e la diffusione del sapere ma anche come strumento argomentativo è comune ai due studiosi, come è stato sottolineato da S. Kusakawa nel suo importante saggio Picturing the nature. Image, text, and argument in sixteenth century human anatomy and medical botany, che mette a confronto l'uso delle immagini in De corporis humani fabrica di Vesalio e in De historia stirpium di Fuchs. Nei suoi difficili anni alla corte spagnola come medico di Filippo II, in cui Vesalio dovette affrontare un ambiente ostile e la rivalità dei colleghi, ebbe rapporti amichevoli con il medico e botanico Francisco Hernandez e poté approfondire la sua conoscenza dei semplici che affluivano dalle Indie. Verso questi ultimi il suo approccio fu allo stesso tempo aperto e cauto, come possiamo ricavare dall'unica sua opera dedicata alla botanica medica, Epistola, rationem modumque propinandi radicis Chynae decocti [...] pertractans (1546). A offrire il pretesto per quest'operina (che nella seconda parte si trasforma in una risposta alle accuse di Sylvius) fu un amico di Malines, Joachim Roelant, che gli chiese la sua opinione su un farmaco alla moda, la radice china (scritto in vari modi, anche radix Chyna, radix Chyna, radix Cynna); questa radice medicamentosa, a quanto pare tratta da una specie di Smilax (quella che Linneo denominerà appunto Smilax china, ma forse semplicemente una varietà cinese della nostra Smilax aspera, la salsapariglia) intorno al 1525 era stata portata a Goa da mercanti cinesi e da qui importata in Europa dai portoghesi; aveva conosciuto un immediato successo, affermandosi come specifico contro la sifilide (un suo estimatore per questo impiego fu ed esempio Mattioli) ma anche contro altre malattie, in particolare la gotta; la moda dilagò quando la adottò lo stesso imperatore Carlo V. La risposta di Vesalio è molto prudente e pacata (non può certo mettere in discussione il parere dell'imperatore, e suo datore di lavoro), ma ferma. Basandosi sulla propria esperienza medica, nega che la radix china abbia particolare efficacia contro la sifilide, preferendole di gran lungo il guaiaco (legno di Guaiacum sanctum e G. officinale); lo considera invece efficace per la cura della gotta e delle artriti, per le sue proprietà sudorifere. D'altra parte, mette in guardia contro l'idolatria per i rimedi esotici: oltre ad essere costosi, venduti sotto forma di polveri e parti essiccate, senza che se ne possa verificare la provenienza, sono spesso oggetto di contraffazioni e soperchierie. Meglio dunque rivolgersi a semplici nostrani, di altrettanta comprovata efficacia. Ricorda di aver curato un grave attacco di gotta del suo illustre paziente utilizzando un decotto a base di camedrio (Teucrium chamaedrys) e altre erbe; consiglia anche la tormentilla (Potentilla erecta). Un ultimo legame con la botanica ci riporta all'estremo, tragico viaggio di Vesalio. Nella primavera del 1564, egli lasciò la corte di Filippo II per un pellegrinaggio in Terra Santa. Su questo episodio sono fiorite le più incredibile leggende (tra la più gettonata quella secondo la quale, mentre dissezionava un nobiluomo o una nobildonna, fu evidente che il cuore batteva ancora; condannato a morte dall'inquisizione per aver praticato la vivisezione, fu graziato dal re, che commutò la pena nel pellegrinaggio); molto più probabilmente, secondo la testimonianza di Clusio, che giunse a Madrid proprio il giorno dopo la sua partenza, Vesalio, malato nel corpo e insofferente dell'atmosfera ostile della corte, aveva ottenuto il permesso di recarsi in pellegrinaggio per motivi di salute. Oltre alla devozione, tra le motivazioni del viaggio c'era anche il desiderio di esplorare le piante medicinali della pianura di Gerico. In effetti, alcuni contemporanei lo accusarono, una volta in Palestina (ma nel caso di Vesalio, mito e realtà, o se volete fatti e fake news, si mescolano continuamente), di aver dedicato più tempo alle piante che alla visita dei luoghi santi. Ma di queste eventuali ricerche non è rimasta traccia; Vesalio infatti durante il viaggio di ritorno morì a Zante, in circostanze, tanto per non smentirsi, ancora una volta misteriose. Una sintesi della sua vita di cortigiano, ma anche di "uomo contro" nella sezione biografie. A chi desidera approfondire il contributo del grande padre dell'anatomia, consiglio il bellissimo sito vesaliusfabrica.com, pubblicato in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita e ricchissimo di contributi (incluso l'accesso alla prima edizione digitalizzata di De corporis humani fabrica).  Vesalea, Abelia, Vesalea? o magari Linnaea? Nel 1842, il raccoglitore belga A. B. Ghiesbreght, che esplora la flora del Messico insieme a H.G. Galeotti e J.J. Linden, nelle montagne degli stati di Veracruz e Oaxaca raccoglie due nuove specie di arbusti; importate in Belgio (dove Galeotti ha fondato un proprio vivaio per la diffusione delle piante messicane), vengano subito immesse nel mercato con il nome un po' fantasioso di fuchsia messicana. Due anni dopo lo stesso Galeotti, insieme a M. Martens, riconoscerà la loro appartenenza alla famiglia delle Lonicerae (oggi Caprifoliaceae) e l'affinità con Abelia; sulla base di alcune particolarità dell'ovario i due creano il nuovo genere Vesalea, in onore del grande conterraneo, l'anatomista belga Andrea Vesalio. Il nuovo genere ha però vita brevissima: due anni dopo, il francese J. Decaisne, rilevando un errore nella descrizione dei due colleghi, lo fa confluire in Abelia. Questa è la situazione per circa 160 anni, finché le ricerche filogenetiche (come abbiamo visto in questo post) mettono in crisi lo stesso genere Abelia; due le possibili soluzioni: la confluenza di Abelia in Linnaea (la linea seguita da Plants of the World); la sua divisione in generi più piccoli monofiletici (la linea seguita da Plants List). Così, i sostenitori di questa posizione resuscitano Vesalea, che va ad accogliere le specie messicane prima appartenenti ad Abelia. Poche le differenze, a dire la verità, tra i due generi; le due principali sono le caratteristiche delle infiorescenze, brevi racemi con pochi fiori, da uno a tre; il numero dei sepali, sempre cinque; la disposizione delle ghiandole del nettario. Per noi profani, la differenza pratica più evidente è la diversa rusticità: al contrario delle sorelline asiatiche, le Vesaleae sono poco rustiche. Le specie attribuite al genere sono presumibilmente cinque (ma le differenze tra una specie e l'altra sono sottili); una è piuttosto nota anche nei nostri giardini. Siamo abituati a chiamarla Abelia floribunda; dobbiamo abituarci a ribattezzarla Vesalea floribunda (a meno che si imponga Linnaea floribunda). Comunque la si chiami, è un arbusto di grande bellezza, con eleganti rami arcuati e fiori penduli dalla lunga corolla tubolare rosa acceso (che ci fanno capire perché furono inizialmente commercializzate come fuchsie). Di non difficile coltivazione, devono essere protette dove le temperature vanno sotto zero. Qualche particolare in più nella scheda. Da qualche tempo si è affermata tra i cosiddetti dolcificanti naturali la Stevia (più esattamente Stevia rebaudiana), nota per il potere dolcificante 300 volte superiore rispetto allo zucchero, senza calorie. Ma forse non a tutti è noto che il suo nome celebra un interessante personaggio del Rinascimento spagnolo, il medico e umanista Pedro Jaime Esteve. 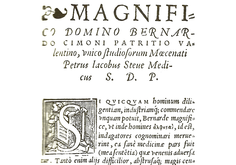 La battaglia contro i barbari e una flora pionieristica Nel Medioevo, la Spagna aveva contribuito alla conoscenza dei grandi testi medici (e botanici) dell'antichità grazie alla mediazione degli studiosi arabi: fu infatti attraverso le loro traduzioni che si conobbero, tra gli altri, Dioscoride, Galeno e Ippocrate. Se per secoli questo aveva posto la penisola iberica all'avanguardia negli studi medici, con l'Umanesimo anche qui si sentiva il bisogna di tornare alle fonti, leggendo i testi degli antichi direttamente sui manoscritti originali. Ma, vista l'autorevolezza della tradizione araba, il ritorno all'antico avvenne non senza polemiche. Gli innovatori, che spesso avevano studiato all'estero o erano in contatto con la rete di umanisti europei, si contrapponevano ai tradizionalisti, da loro soprannominati "barbari", che ancora controllavano i posti chiave della professione medica e dell'insegnamento universitario. Tra i più notevoli e tenaci sostenitori della nuova scuola, troviamo anche Pedro Jaime Esteve, che alla latina si firmava Petrus Jacobus Stevus. Secondo la tradizione avrebbe studiato a Parigi e a Montpellier, dove avrebbe appreso la materia medica (cioè la botanica farmaceutica) da Guillaume Rondelet; maggiore di età del francese, quando questi cominciò a insegnare, Esteve era già vicino ai quarant'anni; ma non sarebbe l'unico caso, in epoca umanistica, di personaggi di età matura che, attratti dalla fama di un grande maestro, lasciavano la patria e magari una carriera per seguirne l'insegnamento. In ogni caso, negli anni '40 del Cinquecento lo troviamo a Valencia, sia come medico sia come versatile professore universitario (insegnò greco, anatomia, chirurgia, materia medica, matematica). Insieme all'amico e concittadino Miguel Jeronimo Ledesma, fu uno degli esponenti più attivi dell'umanesimo iberico, tanto da essere espulso per un anno (1548) dall'Università per aver pronunciato "parole irrispettose" nei confronti di Juan de Celaya, rettore dell'Università di Valencia e uomo di punta dei "barbari". Come medico-umanista, i suoi maggiori contributi sono la traduzione latina e i commenti del secondo libro del trattato sulle Epidemie di Ippocrate (1551) e la traduzione della Teriaca (1552) di Nicandro (la riscoperta dei veri ingredienti della teriaca, considerato un potentissimo antiveleno, fu uno degli argomenti che più appassionarono - e divisero - i medici rinascimentali). Ancora a metà strada tra tradizione medievale e nuova scienza, fu un seguace della teoria galenica degli umori (il che lo portò a interessarsi anche di astrologia) e nel suo insegnamento dell'anatomia mantenne una posizione ambigua, di solo parziale accettazione, nei confronti di Vesalio. In ogni caso, non era un acritico difensore degli antichi; commentando la descrizione dell'anatomia delle vene e dei nervi periferici nel suo commento a Ippocrate, osserva che è tanto rozza e tanto lontana da ciò che chiunque può osservare nelle dissezioni anatomiche, da fargli pensare che si tratti di un'interpolazione (venerava troppo il nome di Ippocrate per metterlo in discussione direttamente). Tra i suoi molteplici interessi, c'era anche, come abbiamo visto, la botanica; dal suo maestro Rondelet aveva appreso i metodi e la passione della ricerca sul campo; già nei suoi commenti al testo di Nicandro (dedicato essenzialmente ai veleni animali) inserì informazioni su alcune piante, fornendo i nomi volgari e informazioni sulla loro localizzazione nell'area valenciana. Ma la sua opera più importante in questo campo fu un manoscritto, intitolato Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan en el Reino de Valencia, "Dizionario delle erbe e delle piante medicinali che si trovano nel Regno di Valencia". L'opera, scritta presumibilmente tra il 1545 e il 1556, fu una delle prime flore regionali d'Europa; tuttavia, non fu mai stampata e andò perduta. Ne conosciamo parzialmente il contenuto grazie a un riassunto incluso nelle Décadas de la Historia de Valencia (1610) di Gaspar Escolano. Escolano fornisce una lista di 120 specie, di cui dà il nome in valenciano e spagnolo, e, solo per alcune, brevi indicazioni sulla localizzazione, sull'uso medico o alimentare, sulle proprietà. Una sintesi della vita di Esteve nella sezione biografie.  La dolce erba dei Guaranì Nonostante ciò che si favoleggia in diversi siti internet, non c'è alcuna relazione diretta tra Esteve e la Stevia. Non la conobbe, né tanto meno fu il primo a studiarla o addirittura a raccoglierla. L'omaggio si deve a Cavanilles che, egli stesso valenciano, volle riconoscere i meriti di un conterraneo di cui erano ancora ben note e apprezzate le traduzioni, autore soprattutto della prima flora della sua regione, che, benché perduta, ne faceva comunque un precursore. Partendo dalla forma latinizzata del nome dell'illustre predecessore, nel 1797 egli creò il genere Stevia (famiglia Asteraceae) sulla base di quattro specie messicane, giunte all'Orto botanico di Madrid grazie alla Real Expedición Botánica a Nueva España. Stevia è un genere piuttosto diffuso, distribuito dal Sud degli Stati Uniti, fino al Sud America meridionale, presumibilmente con massimo centro di diversità in Messico; erbacee annuali e perenni, suffrutici e arbusti, molte specie sono estremamente variabili, causando notevoli problemi di classificazione; lo stesso numero delle specie è dunque incerto (da 350 a 220, di cui almeno una settantina in Messico) e abbondano i sinonimi. Hanno foglie semplici, opposte, raramente alternate, e capolini raccolti in corimbi, con flosculi ligulati assenti e cinque flosculi del raggio tubolari, solitamente bianchi. Si tratta sopratutto di piante di montagna (tra 1000 e 3000 metri), che vivono nel sottobosco di aree fresche e umide. Tra tutte, l'unica a destare sensazione è S. rebaudiana, un arbusto che cresce in un alcune aree del Paraguay. Le proprietà dolcificanti delle sue foglie erano sfruttate dagli indios Guaranì per attenuare il sapore amaro del mate; nel 1887, Moses Bertoni, un eclettico personaggio di origine svizzera che aveva fondato una comunità anarco-socialista e fu un pioniere degli studi etnografici sui Guaranì, identificò per primo la pianta (assegnandola inizialmente al genere Eupatorium), mentre il primo a studiarne le proprietà chimiche fu il chimico paraguayano Olidio Rebaudi, in onore quale nel 1899 Bertoni la battezzò Eupatorium rebaudianum. A riconoscerne l'appartenenza al genere Stevia fu qualche anno più tardi il botanico di Kew W. B. Hemsley. Il suo successo come dolcificante al di fuori del Paraguay (dove vengono usate le foglie fresche) e del Sud America, dove è stato usato dall'industria alimentare almeno dagli anni '40, inizia solo intorno al 1970, grazie ai Giapponesi. E iniziano anche le polemiche. Ma se volete saperne di più, leggete i particolari nella scheda. Bartolomeo Maranta, terzo esponente del Rinascimento botanico napoletano, ebbe una vita travagliata e segnata, suo malgrado, dalle polemiche, tanto da essere preso di mira dall'Inquisizione. Più fortunata la sua vita postuma. Ammirati dalla sua opera, notevole e originale nel pur ricco panorama della botanica italiana del tardo Cinquecento, Plumier prima e Linneo poi gli dedicarono un genere destinato a diventare una delle più popolari piante d'appartamento: Maranta, genere tipo della famiglia Marantaceae.  Un metodo per riconoscere i semplici Maestro di Gian Vincenzo Pinelli, amico e collaboratore di Ferrante Imperato, il botanico Bartolomeo Maranta del vivace circolo botanico napoletano del tardo Rinascimento fu in un certo senso il teorico. Nato a Venosa, si formò come medico all'università di Napoli, raggiungendo un'altissima reputazione professionale (si dice che fosse in grado di diagnosticare una malattia solo dall'aspetto del paziente, prima ancora di sentirgli il polso) tanto che sarebbe stato nominato medico di corte di Carlo V (forse tra il 1535 e il 1539). Per approfondire le conoscenze botaniche, presumibilmente tra il 1550 e il 1554 si spostò a Pisa per studiare con Luca Ghini. Dal veneratissimo maestro, Maranta apprese le basi della scienza botanica e un approccio innovativo, basato, più che sulla lettura filologica di Teofrasto, Plinio e Dioscoride, sull'osservazione diretta delle piante e delle loro proprietà mediche. Il soggiorno pisano gli fruttò la stima del maestro, che lo considerò il più brillante dei suoi allievi, tanto da lasciargli in eredità le sue carte e il suo erbario. Frutto del soggiorno pisano furono anche l'amicizia con Gabriele Falloppio (altro professore dello studio di Pisa) e con Ulisse Aldrovandi, suo compagno di studi, con il quale intrattenne un'importante corrispondenza epistolare per tutta la vita. Tornato a Napoli nel 1554, divenne il maestro di Gian Vincenzo Pinelli, che gli mise a disposizione l'orto botanico della Montagnola; fu qui, sul campo, che Maranta poté mettere alla prova quanto appreso da Ghini. Il risultato fu Methodi cognoscendorum simplicium libri tres, "Tre libri del metodo per riconoscere i semplici". Il suo non è né l'ennesimo commento a Dioscoride - gli immensi Discorsi di Mattioli avevano ormai esaurito questo filone di ricerca - né un erbario o un prontuario con i semplici ben disposti in ordine alfabetico. Lo potremmo piuttosto considerare il primo trattato di botanica generale. Destinato ai medici, cerca di definire un metodo per riconoscere i semplici citati dagli autori classici (primo fra tutti Dioscoride) o comunque usati nella pratica medica. Grazie a una profonda conoscenza del mondo vegetale, Maranta prende in esame tre criteri, a ciascuno dei quali è dedicato uno dei tre libri. Il primo analizza i nomi e i modi in cui possono aiutare (o talvolta ostacolare) l'identificazione delle piante: troviamo così denominazioni tratte da personaggi reali o mitologici, dal luogo di provenienza, dalle caratteristiche morfologiche o dalle proprietà officinali; i nomi tramandati dai classici o di nuova coniazione; si analizzano gli equivoci che nascono dallo stesso nome attribuito a piante diverse o al contrario dai molti nomi con cui è designata la stessa specie. Il secondo libro è dedicato alla descrizione delle piante, sempre intesa come chiave di riconoscimento; Maranta è ben consapevole che le descrizioni degli autori classici sono spesso parziali e inutilizzabili. Ma soprattutto è attento - sono per noi le pagine più affascinanti - alle infinite variazioni di una stessa specie: la stessa pianta si mostra sotto un aspetto diverso nel corso dell'anno e nelle diverse fasi dello sviluppo; una pianta giovane e vigorosa è diversa da una pianta senescente e in declino, una coltivata è diversa da una spontanea; l'aspetto è influenzato dal terreno, dall'esposizione, dalle contingenze stagionali. Più specificamente medico il terzo libro, dedicato alle proprietà officinali delle piante, anche in questo caso nella consapevolezza che le nozioni tratte dagli antichi vanno verificate alla luce dell'esperienza. Secondo le sue stesse dichiarazioni, Maranta avrebbe scritto i Methodi libri tres su sollecitazione di Ghini (con il quale mantenne un'assidua corrispondenza dopo essere tornato a Napoli); prima di pubblicarlo, avrebbe voluto sottoporlo al giudizio del maestro ma questi nel 1556 morì improvvisamente. Maranta ripiegò su un altro amico, Gabriele Falloppio, che nel frattempo si era trasferito a Padova, dove aveva la cattedra di medicina, anatomia e botanica. Solo dopo l'approvazione di quest'ultimo, pubblicò la sua opera, che uscì nel 1559 a Venezia, preceduta dalla dedica a Pinelli e dal carteggio con Falloppio. Nonostante Maranta nel suo testo si pronunci sempre con grande prudenza, evitando toni polemici, nella piena consapevolezza dell'enorme difficoltà della materia, che ha tratto in errore anche gli studiosi più grandi, l'iracondo Mattioli insorse. Già ingelosito dal fatto che le carte di Ghini fossero andate a Maranta anziché a lui, attaccò con violenza il medico venosino, reo di aver identificato in modo diverso da lui un tipo di felce, la lonchite. Ma il calmo e avveduto Maranta non era il tipo da farsi trascinare in polemiche sterili; così non esitò a scrivere un'Epistula excusatoria (insomma, una lettera di scuse); pace fu fatta e i due divennero amici. Un'avventura peggiore toccò a Maranta nel 1562, quando fu arrestato e trattenuto nelle carceri dell'Inquisizione sospettato di simpatie luterane. Liberato dopo qualche mese, da quel momento si dedicò soprattutto alla critica letteraria. Tuttavia nel 1568, come scrive in una lettera all'amico Aldrovandi, lo ritroviamo a Roma dove era impegnato a impiantare un orto botanico (forse per il Cardinale Branda Castiglioni). L'anno dopo però tornò a Napoli, dove su richiesta del protofisico, sulla base delle ricerche condotte con l'amico Ferrante Imperato, scrisse Della Theriaca e del Mitridato, che gli creò la fama di specialista di antiveleni. Pubblicato postumo nel 1571, anche questo libro era destinato a suscitare roventi polemiche con i medici di Padova. Ma Maranta era già morto da qualche mese. Oltre che illustre botanico, fu anche un fine letterato e un esperto d'arte. Qualche notizia in più nella biografia.  Maranta: tuberi alimentari e foglie spettacolari I Methodi libri tres di Maranta non erano certo fatti per diventare un bestseller. Privi di immagini, con quasi 400 pagine fitte di informazioni e osservazioni in un latino brillante ma complesso, arrivarono comunque a una seconda edizione (uscita l'anno stesso della morte dell'autore, con il titolo Novum herbarium sive methodus cognoscendorum omnium simplicium). Grazie a questo testo sapiente e singolare, il nome di Maranta rimase noto ai botanici delle generazioni successive. Nel Settecento, lo svizzero Albrecht von Haller ebbe persino a proclamarlo "l'oracolo dei botanici". Plumier nel 1704 gli dedicò uno dei suoi nuovi generi americani, dedica confermata da Linneo in Genera Plantarum (1753). Il genere Maranta, che ha anche dato il nome alla famiglia delle Marantaceae, è nativo dell'America tropicale (centro e sud America, Antille). Comprende 40-50 specie di erbacee perenni rizomatose con grandi foglie sempreverdi intere e piccoli fiori tubolari con tre petali. Due sono le specie più note, per motivi molto diversi. La prima è M. arundinacea, nota con il nome di arrowroot, dai cui tuberi si ricava una fecola alimentare, conosciuta con lo stesso nome; nativa del Messico, dell'America centrale e meridionale, delle Antille, dove è coltivata fin dalla preistoria, è stata introdotta e si è naturalizzata in moltissimi paesi tropicali, dall'Africa all'Asia orientale. Utilizzata in questi paesi nell'alimentazione ordinaria, per la sua eccellente digeribilità da noi è soprattutto impiegata per preparare alimenti leggeri per bambini o ammalati. La seconda è M. leuconeura, una delle più popolari piante da appartamento. Non è coltivata per i fiori, bianchi o violacei e insignificanti, ma per la bellezza delle grandi foglie, caratterizzate da nervature vivacemente colorate che spiccano, talvolta simili a piume, sullo sfondo di colore contrastante o isolano grandi macchie di colore. Curioso è il portamento di queste foglie: nelle ore diurne sono abbassate e distese, in quelle notturne si raddrizzano e si ammassano l'un l'altra. Poiché in quest posizione evocherebbero mani giunte in preghiera, nei paesi anglosassoni sono note come Prayer Plant. Il movimento delle foglie , ovviamente accelerato, è ben apprezzabile in questo video. Sul mercato sono disponibili molte cultivar che si distinguono per i colori e le diverse forme delle variegature. Qualche informazione in più nella scheda. Nel Cinquecento la creazione dei primi orti botanici imprime una svolta allo studio delle piante. Accanto a quelli pubblici, nati in ambito universitario, come quelli di Pisa e Padova, anche giardini privati ebbero talvolta un ruolo nella (ri)nascita dell'interesse per la botanica. Ne è un esempio il giardino della Montagnola, creato a Napoli da Gian Vincenzo Pinelli intorno alla metà del XVI secolo, grazie al quale si formò un vivace circolo di studiosi e appassionati.  Un giardino e una corrispondenza internazionale Il nome di Gian Vincenzo Pinelli è noto agli studiosi di Galileo e ai bibliofili. Trasferitosi a Padova dal 1558, attratto da quella celebre università, vi creò una immensa biblioteca che, almeno in parte, venne acquistata dal cardinal Borromeo andando a costituire uno dei fondi più importanti della Biblioteca ambrosiana; raccolse attorno a sé un importante circolo di intellettuali, fu il primo ospite di Galileo che poté avvalersi della sua notevole collezione di volumi di ottica; fu in corrispondenza con il fior fiore degli intellettuali europei. Ma prima di tutto questo, nella sua giovinezza napoletana, Pinelli fu veramente un "giovane meraviglioso". Di salute cagionevole, aggravata da un grave incidente a un occhio, fin da bambino si dedicò attivamente allo studio, acquisendo una cultura vastissima e poliedrica. Le cospicue risorse economiche della famiglia (il padre era un mercante genovese trasferitosi a Napoli per meglio curare i propri interessi commerciali) gli permisero di avere i migliori maestri: il filosofo e letterato napoletano Gian Paolo Vernaglione per la cultura classica e le lingue latina e greca; il celebre compositore fiammingo Filippo de Monte per la musica. I suoi interessi includevano anche le scienze: i problemi di vista lo spinsero a studiare ottica; le piante medicinali esotiche che affluivano al porto di Napoli, uno dei principali del Mediterraneo, lo avvicinarono alla medicina e botanica. Fu così che intorno alla metà del secolo il giovanissimo Pinelli fece impiantare in una proprietà della famiglia fuori delle mura della città, sulla collina dei Miracoli in località Montagnola, un giardino botanico privato, sul modello di quello che pochi anni prima Ghini aveva creato a Pisa. Secondo le testimonianze dell'epoca, comprendeva specie sia medicinali sia ornamentali, ed era ricco di essenze rare ed esotiche. Forse grazie a Ghini, Gian Vincenzo entrò in contatto con il suo allievo prediletto, Bartolomeo Maranta, che rientrato a Napoli da Pisa intorno al 1555, divenne il suo maestro di medicina e botanica, nonché il curatore del giardino. In realtà, fu un arricchimento reciproco: se Pinelli si giovò della grande competenza di Maranta, quest'ultimo fu stimolato dalle intelligenti conversazioni con il dotatissimo allievo. La frequentazione quotidiana del giardino della Montagnola permise al botanico di mettere alla prova le conoscenze apprese alla scuola di Ghini e di creare un vero e proprio metodo per il riconoscimento dei semplici, esposto in Methodi cognoscendorum simplicum libri tres (1559), che volle dedicare a Pinelli (al tempo ventitreenne). Maranta non era il solo frequentatore di quel favoloso giardino; un altro abituè fu il farmacista Ferrante Imperato che ne ottenne esemplari per la sua collezione e rese omaggio a Pinelli nella prefazione della sua Historia naturale, dove lo celebra come fondatore della scuola naturalistica napoletana. Tuttavia nel 1558 Gian Vincenzo riuscì finalmente a convincere il padre a lasciarlo partire per Padova. Non sappiamo quale sorte avesse il giardino dopo la sua partenza; pare che per qualche tempo fosse affidato alla cura di Maranta che tuttavia a sua volta lasciò Napoli a più riprese (e per un certo periodo, nel 1562, subì anche il carcere dell'Inquisizione). Probabilmente, lontani il proprietario e il curatore, il giardino languì e fu abbandonato. Non di meno, anche a Padova Pinelli continuò a interessarsi di scienze naturali; oltre alla ricchissima biblioteca, considerata la maggiore del tempo, creò anche una collezione di antichità e di storia naturale; anche la casa padovana aveva un giardino ricco di piante rare. Soprattutto, fu l'animatore di una rete di studiosi europei, che consentì di collegare gli esponenti dell'umanesimo e della ricerca scientifica italiana con gli studiosi d'oltralpe. La sua stessa casa - meta irrinunciabile degli intellettuali stranieri in visita in Italia - divenne in un vero centro di smistamento da cui transitavano lettere, libri, pacchi di reperti. Ad esempio, Imperato si rivolse a lui per far pervenire un pacco (che conteneva tra altri esemplari una collezione di semplici essiccati) al botanico tedesco Camerarius; e a Pinelli fece spesso ricorso per procurasi reperti rari per il suo museo. Fu sempre Pinelli a mettere in contatto Clusius con Imperato e Aldrovandi. Anche Gessner e i fratelli Bahuin furono tra i suoi contatti. Dopo aver fondato in giovinezza un giardino, nella maturità Pinelli fu dunque uno dei principali tramiti tra la botanica italiana e quella europea. Questi i suoi meriti botanici; qualche informazione in più sulla vita del poliedrico erudito, che fu cultore di molte materie ma non scrisse neppure un libro, nella sezione biografie.  Pinellia, un drago verde dalla Cina Al fervore di studi della Napoli rinascimentale, seguì una lunga pausa. Bisognò attendere il Settecento perché rifiorissero gli studi di botanica e addirittura il 1807 perché Napoli avesse il suo orto botanico. Per una singolare coincidenza, sorse proprio in località Montagnola, dove 250 anni prima Pinelli faceva coltivare il suo orto dei semplici. Se ne ricordò Michele Tenore, primo prefetto dell'orto napoletano, nell'agosto del 1839, quando creò un nuovo genere, staccandolo da Arum. Nella comunicazione all'Accademia reale delle scienze si dichiara deciso a imitare l'esempio dei botanici di tutte le nazioni che quasi ogni giorno creano nomi in onore dei "più distinti cultori della scienza delle piante". Quindi aggiunge: "Di simili omaggi noi scrittori della Penisola mostrar ci dobbiamo più teneri, come quelli che meno frequenti occasioni avendo di tributarli, una schiera non meno numerosa d'illustri nomi negli annali della scienza registrati troviamo, che ne attendono tuttora il meritato favore". La sua scelta cadde dunque su Pinelli, di cui Tenore ricorda i meriti come fondatore del giardino della Montagnola, prima istituzione di questo tipo in Napoli. Nacque così il genere Pinellia della famiglia Araceae. Pinellia è un piccolo genere endemico dell'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone) che comprende nove specie, con centro di biodiversità in Cina. Alcune di esse sono relativamente conosciute anche da noi come piante ornamentali, prima fra tutte la famigerata P. ternata. Famigerata perché questa erbacea, per quanto bella e gradevole, si dimostra fin troppo espansiva e volonterosa, tanto da essere ormai considerata una pericolosa infestante. Così, l'anno scorso l'orto botanico di Torino ha chiamato a raccolta amici, studenti, volontari per eradicarla dalle sue aiuole. Eppure in Cina è una specie di notevole importanza etnobotanica, utilizzata nella medicina tradizionale nel trattamento di svariate malattie. Più controllabili e (a mio parere) più attraenti altre specie: in particolare la giapponese P. tripartita, con foglie trifogliate con venature molto evidenti e uno spadice lunghissimo, verde acido, che le ha guadagnato il nome di Green Dragon. Notevole anche il fogliame di P. pedatisecta, che forma una grande ventaglio di lunghe foglioline lanceolate, di aspetto molto esotico. Un po' meno diffusa è la piccola P. cordata, che in alcune varietà ha foglie a freccia o cuoriformi piacevolmente marmorizzate. Qualche approfondimento nella scheda. La prima immagine a stampa (1599) di una Wunderkammer, una camera delle meraviglie, immortala il Museo di Ferrante Imperato, farmacista napoletano, collezionista, studioso di scienze naturali con particolari interessi per la geologia, creatore di un immenso, misterioso e sfortunato erbario. A fine Settecento, l'ancor più sventurato botanico napoletano Domenico Cirillo gli dedicherà il genere Imperata. 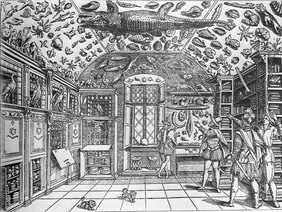 Un grande museo napoletano Nel Cinquecento, con la rinascita degli studi naturalistici, inizia anche il collezionismo dei naturalia, oggetti più o meno rari e curiosi tratti dai tre mondi della natura (minerali, animali, piante). Le prime collezioni private, note come "Teatri della natura", furono create da scienziati, medici e farmacisti. Nate a scopo di studio, furono comunque segnate dal gusto del meraviglioso, dell'esotico e dello stravagante. Quale aspetto potessero avere lo vediamo dall'illustrazione che apre l'Historia naturale di Ferrante Imperato, creatore di un celebrato museo presso la sua abitazione napoletana (che si trovava in piazza santa Chiara, nei pressi di palazzo Gravina, e non nello stesso palazzo, come si dice in molti siti). L'immagine ci mostra tre pareti della sua "camera delle meraviglie"; su quella di sinistra, e in parte su quella di fondo, illuminata da una grande finestra, una elegante scaffalatura in legno custodisce scatole, sacchetti e boccette; sulla parete di fronte, una libreria con imponenti volumi in folio; nella parte alta delle scaffalature, uccelli impagliati; la parete di fondo e il soffitto sono letteralmente tappezzati di animali, soprattutto marini, tra tutti spicca un coccodrillo. In primo piano, sulla destra un giovane (probabilmente Francesco, figlio di Ferrante Imperato) mostra la collezione a due visitatori, elegantemente vestiti alla spagnola. Sul fondo, un po' in disparte, un quarto personaggio, che potrebbe essere un terzo visitatore o lo stesso Ferrante Imperato (è vestito con la stessa pomposa eleganza dei "turisti", ma non porta la spada, privilegio dei nobili). Insieme a quelli allestiti da Ulisse Aldrovandi a Bologna e da Francesco Calzolari a Verona, il museo napoletano di Imperato era noto in tutta Europa ed era meta di numerosi visitatori. Secondo le testimonianze dell'epoca, comprendeva dodicimila reperti tratti dai tre regni della natura (minerali, fossili, pietre preziose e gemme, terre, coloranti, conchiglie, animali imbalsamati, pesci e animali marini essiccati, oli, inchiostri, profumi, balsami e resine, erbe secche e semi) e alcuni artificialia, oggetti curiosi creati dall'uomo, che Imperato parte aveva raccolto personalmente nei suoi viaggi nel sud d'Italia, parte aveva acquistato alla fiera di Francoforte - che a quanto pare frequentò assiduamente -, parte aveva ottenuto come dono o in scambio da altri membri della grande rete che raccoglieva i naturalisti europei. Fondato probabilmente intorno al 1566 - come si deduce dal contratto con gli stipettai che realizzarono i mobili - nacque dapprima dalla stessa professione di farmacista. Lo speziale-farmacista, un professionista che non aveva formazione universitaria ma un vasto sapere pratico, acquisito dopo un lungo apprendistato regolato dagli statuti della propria corporazione, preparava le medicine prescritte dai medici, partendo dai semplici: non solo erbe, spezie e altri prodotti di origine vegetale come resine e balsami, ma anche minerali e persino alcuni animali (la carne di serpente era un ingrediente indispensabile della celebre teriaca). La sua bottega includeva perciò un vero e proprio laboratorio, con mortai, alambicchi e altre attrezzature per pestare, impastare, distillare i preparati "galenici". Non si vendevano solo droghe medicamentose, erbe medicinali e preparati farmaceutici, ma anche quei prodotti che in futuro spetteranno al droghiere: spezie alimentari; candele, cera, miele, zuccheri e conserve; carta, inchiostro e colori per la pittura; insetticidi e veleni per i topi; profumi, acque distillate e belletti... Non stupisce dunque che due farmacisti di successo come Imperato e Calzolari abbiano trasformato le loro botteghe in veri e propri musei. Le due istituzioni erano piuttosto simili: entrambe si trovavano al primo piano, sopra il negozio, comprendevano una galleria di ritratti di scienziati illustri e la vera e propria camera delle meraviglie; quello di Imperato comprendeva anche un terrazzo con un piccolo giardino botanico pensile. Sia Calzolari sia Imperato erano inseriti nel circuito dei naturalisti europei e italiani, da cui ricevettero molti materiali per le loro collezioni, e godevano di un notevole prestigio personale. Ma mentre il veronese si accontentò di essere un farmacista, Imperato nutriva maggiori ambizioni; la sua bottega era un vero e proprio laboratorio, in cui lui stesso e altri studiosi potevano condurre ricerche e esperimenti. Celebre la sua collaborazione con Bartolomeo Maranta, il cui frutto fu Della theriaca et del mithridato libri due, firmato dal solo Maranta ma nato dal sodalizio scientifico tra i due. Come naturalista, l'interesse principale di Imperato andava ai minerali e alla geologia: osservatore attento del territorio campano, studiò gli affioramenti geologici, descrisse con esattezza le serie stratigrafiche osservate nelle cave di pozzolana, comprese e spiegò correttamente la natura dei fossili, il ruolo delle acque nel modellamento nel terreno, l'origine della salinità marina. Espose le sue ricerche in un vasto trattato, Dell'Historia naturale, pubblicato nel 1599 a cura del figlio Francesco, in cui studiò terre, acque, aria, minerali, metalli, erbe e animali soprattutto dal punto di vista della loro utilità per l'uomo. Alle citazioni degli autori del passato vi affianca i risultati delle sue osservazioni, spesso in dissenso con le idee ricevute e ricche di intuizioni corrette. 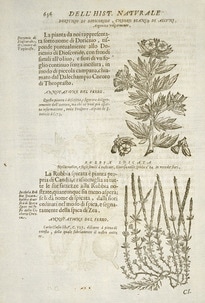 Un erbario leggendario e sfortunato A fare la parte del leone nel trattato sono le terre, i minerali, i metalli. A animali e piante, forse per non entrare in competizione con ammirati studiosi come Mattioli, Imperato dedicò solo gli ultimi due libri; vi compiono una manciata di piante per lo più officinali, nuove, di identificazione discussa o poco note. Ad esempio, vi troviamo una delle prime segnalazioni della melanzana rossa (Solanum aethiopicum). Eppure la botanica rientrava tra gli interessi principali del poliedrico studioso e il suo erbario costituiva uno dei punti di forza del Museo. Ci sono giunte informazioni contrastanti sulla sua consistenza: le piante, sistemate su fogli di carta di formato in folio con un particolare trattamento che conservava i colori naturali, erano raccolti in grandi volumi, dieci secondo alcune testimonianze, 80 secondo altre. Dopo la morte di Imperato (avvenuta dopo il 1615), il figlio Francesco ne custodì l'eredità, incrementando addirittura le raccolte. Le generazioni successive tralasciarono invece il museo: le collezioni furono abbandonate e disperse, probabilmente anche in seguito all'epidemia di peste che devastò Napoli nel 1656. Nel Settecento i 9 volumi superstiti del grande erbario pervennero a Sante Cirillo, medico, botanico, membro della Royal Society, che li trasmise al nipote, il grande botanico Domenico Cirillo. Costui partecipò attivamente alle vicende della Repubblica partenopea; dopo il crollo della repubblica e il rientro dei Borbone, fu arrestato, processato e condannato a morte. Il giorno stesso della sua esecuzione, il governo borbonico permise a una folla di fanatici sanfedisti di saccheggiarne la casa, distruggendo molti scritti e materiali scientifici di inestimabile valore, incluso l'erbario di Imperato. Fortunosamente, si salvò un solo volume, che pervenne a uno storico locale, Camillo Minieri Riccio, e nella prima metà dell'Ottocento fu venduto alla Biblioteca nazionale di Napoli, dove è oggi custodito. Il volume superstite, di 536 pagine, comprende 442 esemplari. Supponendo vera l'informazione secondo la quale l'erbario originariamente fosse composto da 80 volumi, e ipotizzando che ciascun volume fosse di dimensioni analoghe, si arriverebbe alla favolosa cifra di 35.000 esemplari secchi. Per capirne l'enormità basti pensare che il coevo erbario di Cesalpino (del 1563) contiene 768 esemplari e quello di Caspar Bauhin (il più grande dell'epoca) ne raccoglieva circa 4000. Anche se la cifra fosse fantasiosa, e fosse da accettare l'ipotesi più prudente di 10 volumi, l'erbario rimarrebbe comunque il più imponente del suo tempo. Testimonianze dell'epoca ci dicono che era ricco di piante esotiche, ottenute da altri studiosi o acquistate a grande prezzo; Imperato avrebbe addirittura finanziato un viaggio in India per procurarsene alcune. Per maggiori informazioni sulla vita di Imperato, si rimanda alla biografia.  Imperata, una bella invasiva Parti dell'erbario di Cirillo sfuggirono alla devastazione sanfedista e passarono al botanico Vincenzo Petagna (1730–1810). Mescolati ad essi, si trovano circa 170 esemplari di provenienza sconosciuta, che in base a recenti analisi potrebbero aver fatto parte dell'erbario di Imperato. Alcuni di essi sono storicamente importanti, perché costituiscono i tipi su cui si basò Cirillo per stabilire denominazioni binomiali, alcune delle quali ancora accettate. Fu proprio su uno di questi esemplari (da lui denominato Imperata arundinacea, oggi I. cylindrica) che Cirillo stabilì il genere Imperata, dedicato all'illustre predecessore, pubblicato nel secondo volume di Plantarum rariorum regni neapolitani (1788-1792). Imperata è un piccolo, ma diffuso genere di erbe tropicali e subtropicali (famiglia Poaceae). Sono erbe perenni rizomatose, con steli solidi, eretti e infiorescenze setose, cui si deve il nome comune inglese satintail "coda di raso". Oggi le si attribuiscono undici specie, diffuse nelle Americhe, in Asia,in Africa, in Micronesia e in Papuasia, dopo il distacco di altre specie, assegnate a generi affini (Miscanthus, Saccharum, Lagurus, Cinna). La specie più nota, I. cylindrica, è ubiquitaria: originaria dell'Asia, del Sud Africa e delle isole del Pacifico, è stato introdotta nell'Europa meridionale e in America, dove spesso si è naturalizzata, diventando a volte invasiva. Nei paesi originari è invece una specie di estrema utilità: è estesamente utilizzata per consolidare aree litoranee sabbiose e altri terreni franosi; gli steli secchi sono utilizzati per ricoprire i tetti, intrecciare tappeti e borse, fare la carta. Alcune cultivar sono coltivate per il valore ornamentale; la più diffusa nei giardini è la giapponese I. cylindrica 'Red Baron', con foglie rosse. Qualche informazione in più nella scheda. Imperato è anche ricordato da una specie di zafferano, Crocus imperati, endemismo presente esclusivamente nell'Italia centrale e meridionale. Se pensate che le calceolarie si chiamino così perché i loro singolari fiori assomigliano a una pantofola, in latino calceolus, non sbagliate. Ma molto probabilmente, il vecchio Linneo (e prima di lui il padre Feuillée) volle fare un gioco di parole e prendere due picconi con una fava: chiamò quel genere di piante sudamericane Calceolaria non solo per la forma dei loro fiori, ma per rendere omaggio a un altro protagonista della botanica rinascimentale, il farmacista veronese Francesco Calzolari.  Esplorando il Giardino d'Italia Parlare di Francesco Calzolari vuol dire parlare del Monte Baldo. Il Baldo è un massiccio montuoso che separa il lago di Garda e la provincia di Verona dal Trentino, il bacino del Mincio da quello dell'Adige, celebre per la grande varietà floristica, che gli ha guadagnato il soprannome di Hortus Italiae, il giardino d'Italia. E' una sorta di orto botanico naturale in cui si susseguono almeno quattro fasce floristiche e climatiche: la fascia mediterranea, estesa lungo le rive del Garda, con la coltivazione dell'olivo e degli agrumi e essenze tipicamente mediterranee, come il leccio, l'alloro, il rosmarino, lo scotano; la fascia montana caratterizzate da boschi di faggio, tiglio, carpino nero, abete bianco, larice e peccio, e più in alto, oltre i 1000 metri, praterie ricche di erbe; la fascia boreale, dominata dal pino mugo e caratterizzata da fioriture vistose e dalla presenza di molti endemismi, come l'anemone del Baldo, Anemone baldensis; la fascia alpina, la più elevata, con la vegetazione rupestre delle cime più alte, tra i 2000 e 2200. La varietà di altitudine, esposizione e suolo crea un'infinità di microclimi e nicchie ecologiche più o meno vaste, ciascuna con una flora caratteristica; ma facciamolo raccontare da Francesco Calzolari stesso: "Cotanta è poi nello stesso monte la varietà dei luoghi e delle cose, che troppo lungo sarebbe tutte con ordine ricordarle. Imperciocchè vi sono valli non picciole in esso di vivo masso, erte, e inchinate, e scheggiose, e forte sparute; così viceversa praterie di pascoli assai pingui ed ampie, smaltate di varia spezie d'erbe e di fiori, e alcune di loro piane ed ombrose, ed altre inchinate ed apriche. [...] E per non dilungarmi lascio da parte le frondose e folte selve di faggi, di querce e d'elci, e alcune di soli castagni, et altre in cui vengono i silvestri pini, i larici e gli altissimi abeti. Del resto che dirò del variare dell'aria e del cielo! Cose mirabili certamente! conciossiachè quelli che tutta cotesta montagna van discorrendo, provan dell'aere, anche a brevi intervalli, grande variazione; per modo che sembra a parecchi di aver cambiato clima, non che paese, e ciò perché questa parte è volta al levar del sole, quella al cadere; alcuna dal sole è abbruciata, ed altra a perpetua ombra soggiace. Qua il sito è freddo in tutta la state per neve e per gielo; là poi per calore divampa. A certe altre parti quasi per tutto l'anno v'ha una temperatura da primavera; per la quale la diversità di luoghi e di siti la cotanto diversa copia di piante in questo terreno germoglia, che non più in nessun altro d'Italia." Di questo orto botanico naturale, Francesco Calzolari si autonominò esploratore e prefetto. Erede di una ben avviata farmacia che sorgeva proprio sulla piazza delle Erbe di Verona, allievo e amico di Luca Ghini, sulle pendici del Baldo andò a cercare le erbe medicinali che altri coltivavano negli orti botanici, con le quali mise a punto una teriaca, elogiata da Mattioli. In contatto con molti dei bei nomi della botanica rinascimentale italiana, organizzò molte spedizioni di esplorazione scientifica della montagna, la più celebre delle quali avvenne nel 1554 e vide la partecipazione, insieme a Calzolari, di Ulisse Aldrovandi, Luigi Anguillara e Andrea Alpago. Una dozzina di anni dopo (1566) l'esperienza si tradurrà nel più noto scritto di Calzolari, Il viaggio di Monte Baldo, una specie di guida floristica del massiccio montuoso, con un puntiglioso elenco delle sue specie e della loro localizzazione. E' un'operina di appena 16 pagine, famosa per essere la prima flora locale in cui si indica l'habitat di ogni specie; qui e nelle sue lettere, il farmacista veronese nomina ben 450 specie diverse che crescevano tra Verona e la cima del Baldo. Una ricchezza che permane: nel bel sito del Parco naturale del Monte Baldo ne sono fotografate e descritte 104. All'esplorazione del monte Baldo (un'area ricca anche di fossili e particolari formazioni geologiche) risale anche la passione di Calzolari per la raccolta di oggetti naturalistici. Nel corso degli anni egli mise insieme un'imponente collezione che sistemò al primo piano della sua abitazione, sopra il negozio di speziale, un vero e proprio museo suddiviso in tre locali: il primo conteneva i ritratti dei più importanti scienziati e medici del suo tempo; il secondo vasi e alambicchi per la distillazione; il terzo, il museo vero e proprio, con spezie, piante, minerali, fossili e curiosità naturali di vario tipo sistemati in teche bene ordinate o appesi scenograficamente al soffitto. Visitato e ammirato dagli scienziati in visita a Verona, il Museum Calceolarium fu uno dei più importanti gabinetti di curiosità del Rinascimento italiano, accanto al Teatro della Natura di Aldrovandi, al Museo allestito a Napoli da Ferrante Imperato, alle collezioni naturalistiche del Granduca di Toscana. Al Baldo è legata anche la pagina più tragica della vita del farmacista veronese: mentre su "alte et asprissime pendici" del monte era alla ricerca di erbe rare per la farmacia paterna, il figlio maggiore, Angelo, a soli 28 anni morì in seguito a uno dei primi incidenti alpinistici ricordati dalla letteratura, dopo venti giorni di penosa agonia. Altre informazioni sulla vita di Calzolari nella sezione biografie.  Calceolariae, scarpette dai colori del sole Il genere Calceolaria fu creato da un sacerdote francese, Louis Feuillée, che tra il 1708 e il 1711 esplorò l'America meridionale. Nell'Histoire des plantes medicinales qui sont les plus en usages de l'Amérique meridionale, descrisse due specie cilene: Calceolaria salviae (probabilmente da identificare con C. integrifolia) e C. foliis scabiosae (presumibilmente C. tomentosa). Feullée aveva in mente la forma del fiore, simile a una babbuccia, ma intendeva anche rendere omaggio a Calzolari (la forma latina del cui cognome è Calceolarius). Nel 1770, in Sistema naturae, Linneo riprese e ufficializzò il nome, e il gioco di parole: a forma di pantofola / dedicata a Calzolari. Il genere Calceolaria, un tempo assegnato alla famiglia Scrophulariaceae, oggi appartiene a una famiglia propria (Calceolariaceae); molto vasto, comprende circa 250 specie americane, distribuite tra il Messico meridionale e la Terra del fuoco, e nettamente distinte in due gruppi: il primo, distribuito dal Messico al Perù, comprende specie tropicali, per lo più andine; il secondo, presente in Cile e Argentina, comprende specie rustiche delle regioni temperate e fredde; alcune specie di particolare fascino vivono nella fredda Patagonia e si spingono addirittura nelle isole Falkland; quelle più note sono erbacee, annuali e perenni, ma alcune sono arbusti alti anche 4 metri. Nei nostri giardini sono presenti soprattutto due gruppi di ibridi: le bizzarre e coloratissime Calceolariae erbacee, note come C. x herbeobryda, con vistosi fiori a palloncino nei colori più caldi e solari (giallo, arancio, rosso, mattone, talvolta bicolori, picchettati e screziati) coltivate soprattutto in vaso o in appartamento; i più alti e robusti ibridi arbustivi C. x fruticohybrida con fiori più piccoli, gialli, utilizzati per lo più come piante da aiuola. Purtroppo sono meno diffuse le perenni rustiche di origine cilena e argentina, alcune delle quali sono esigenti piante da collezionisti da riservare alle serre alpine, ma altre, almeno nel nord Italia, si adatterebbero molto bene alla coltivazione in giardino roccioso, purché protette dalle piogge invernali. Curiose e inconfondibili per la singolare forma dei fiori, le Calceolariae sono anche interessanti per alcune particolarità biologiche; il labbro inferiore della corolla di molte specie (circa l'80 % del genere) è dotato di tricomi ghiandolosi, detti eleofori, che secernono oli non volatili, ricercati come ricompensa dagli impollinatori, gli imenotteri del genere Chalepogenus. Le Calceolariae sono tra le poche angiosperme a utilizzare questa strategia di impollinazione e a produrre questo tipo di oli. Altre informazioni nella scheda. Nel tardo Rinascimento, con tre botanici di risonanza internazionale, le piccole Fiandre sono all'avanguardia negli studi botanici. A inaugurare il gruppo, prima di Clusius e l'Obel, fu Dodoens. Tanto fervore di studi - e di pubblicazioni - non fu casuale: prima che arrivassero le guerre e la violenza religiosa, quella era l'area più ricca e aperta d'Europa. Aperta anche alle piante e alle idee nuove.  Un nuovo pubblico per i libri di botanica Nella prima metà del Cinquecento il cuore pulsante dell'economia europea era Anversa. Ancor più che a Lisbona o a Siviglia, era qui che approdavano le merci coloniali che giungevano dall'Asia, dall'Africa e dal Nuovo Mondo, pronte ad essere scambiate con i prodotti che per via di terra giungevano dal Mediterraneo e per mare dalle sponde del Baltico; secondo le parole di l'Obel: "Tutto ciò che c'è di straordinario e desiderabile ovunque nel mondo, viene portato qui in abbondanza per mare e per terra, e tutti i tesori d'Europa, Asia e Africa si raccolgono qui". In pochi anni, la città crebbe tumultuosamente: nel 1496 aveva 40.000 abitanti, nel 1566, all'apice della sua prosperità, ne contava 100.000. Molti di quegli immigrati, oltre a un lavoro e alla ricchezza, cercavano un luogo libero dove poter professare senza impedimenti la loro fede religiosa. Le Fiandre sembravano il posto giusto: appartenevano agli Asburgo, ma erano abituate da secoli ad autogovernarsi e l'imperatore Carlo V (nato a Gand, di lingua madre fiamminga egli stesso) ne era ben consapevole e lasciò ampi margini di autonomia a quella ricchissima provincia che fruttava sei volte tanto le colonie americane. Così Anversa divenne anche uno dei maggiori centri della stampa, dove si pubblicavano le opere dei predicatori riformati vietate in Francia o nell'Impero. Tra i tesori ricordati da l'Obel, affluivano in abbondanza nuove piante. Tra i ricchi fiamminghi, vecchi e nuovi, divenne di moda creare giardini e collezioni di piante esotiche. A dare l'esempio fu la stessa governatrice dei Paesi Bassi, Margherita d'Austria, che fece edificare uno splendido giardino nella residenza di Mechelen (o Malines). Il più bello di tutti, però, era quello del farmacista Peeter van Coudenberghe che proprio ad Anversa creò un orto botanico privato che giunse a comprendere più di 600 specie, dotato di una struttura per il ricovero invernale delle piante esotiche, che possiamo considerare il primo esempio di orangerie. Grazie alla diffusione della stampa, cresceva anche il livello culturale e l'alfabetizzazione era sempre più diffusa; c'era dunque un pubblico potenziale interessato a libri sulle piante e sulla flora esotica, soprattutto se scritti in fiammingo (tra i borghesi appassionati di piante pochi conoscevano il latino) e corredati di belle figure. Almeno, fu questo il ragionamento di uno stampatore-editore, Jan van der Loe, che intorno al 1550 acquistò dall'editore tedesco le matrici dell'erbario di Fuchs e chiese a un amico, il medico Rembert Dodoens, di tradurlo in fiammingo. Dodoens (che, alla latina, si firmava Dodonaeus) era un medico di successo che fino a quel momento non si era particolarmente interessato di botanica, se non per quelle nozioni che facevano parte delle competenze di base di ogni medico in un'epoca in cui quasi tutti i medicamenti erano ricavati dalle erbe. Uomo metodico e coscienzioso, si mise al lavoro con entusiasmo. La sua non fu dunque una traduzione o una riscrittura del testo di Fuchs, ma un'opera del tutto nuova. Certo, Dodoens, riprende da Fuchs la struttura delle trattazione di ogni pianta, ma le sue descrizioni, quasi sempre basate sull'osservazione dal vivo, risultano più precise e dettagliate di quelle del tedesco. L'attenzione alla piante locali (di cui si indicano le epoche di fioritura e fruttificazione) fanno del suo erbario una flora regionale delle Fiandre. Più simile al modello la parte erudita, con le citazioni di prammatica delle proprietà attribuite dagli scrittori antichi e le solite infinite discussioni sulle corrette identificazioni delle specie (tuttavia, ben più contenute rispetto a Fuchs, per non parlare dell'enciclopedico e logorroico Mattioli). La maggiore novità sta nella disposizione delle specie: nella lettera dedicatoria, Dodoens confessa di essere stato a lungo combattuto: non gli sembravano funzionali né l'ordine di Teofrasto (l'analisi delle piante in base ai loro organi costringeva infatti a trattare la stessa specie più volte) né l'ordine alfabetico (adottato da Fuchs), che teneva lontane piante affini e accostava piante senza alcun punto in comune. Decise così di tornare a Dioscoride, raggruppando le piante prevalentemente in base agli usi e alle proprietà, e, meno spesso, alle forme e alle affinità. E' una classificazione ancora eclettica, che lasciò insoddisfatto per primo le stesso Dodoens, come si vede dall'elenco delle sue sei classi: - piante notevoli per i loro fiori o i loro semi; - piante usate in medicina o venefiche; - cereali, legumi, foraggi; - erbe, radici e frutti di uso alimentare; - alberi e arbusti; - piante che non rientrano in nessun dei gruppi precedenti. Dodoens terminò la redazione nel 1552 e sottopose il testo a un'attenta revisione, prima della pubblicazione, che avvenne nel 1554, con il titolo Cruydeboeck. Fu un successo commerciale, che in dieci anni esaurì la tiratura e rese necessaria una ristampa, nel 1563. L'editore, che aveva ottenuto dall'imperatore un privilegio di dieci anni per l'uso delle matrici dell'erbario di Fuchs, sfruttò pienamente l'investimento; prima ancora dell'uscita del volume, pubblicò le tavole da sole (con i nomi in molte lingue e note sintetiche a margine, sempre a cura di Dodoens). Nel 1557, uscì una traduzione in francese, curata da Carolus Clusius (che di Dodoens diverrà intimo amico), con il titolo Histoire des plantes. Possiamo considerarla una vera e propria nuova edizione, aumentata sia nel testo sia nelle tavole, che a sua volta sarà la base, per una seconda edizione delle tavole (1559) e per le traduzioni in inglese (A new herbal, a cura di Henry Lyte, 1578) e in latino (1583), che fanno dell'erbario di Dodoens il testo più tradotto dei suoi tempi dopo la Bibbia.  L'opus magnum di Dodoens Nel 1563, anno in cui scadeva il privilegio decennale, ritenendo probabilmente il mercato ormai saturo, van der Loe vendette le matrici. Poteva essere la fine dell'opera botanica di Dodoens, se non fosse stato per il fortunato incontro con un altro stampatore, il grande Christophe Plantin. Convinto che ci fosse ancora spazio per raffinate opere scientifiche corredate da belle immagini, Plantin mise a disposizione di Dodoens - oltre alla sua tipografia celebre per la nitidezza dei caratteri, l'accuratezza della revisione dei testi, la sobria eleganza - una squadra di pittori e incisori che, secondo le indicazioni del botanico, avrebbero ritratto nuovamente dal vivo le piante necessarie per l'edizione latina delle sue opere. Ma, ancora una volta, Dodoens non si accontentò di ripubblicare in nuova veste il suo vecchio lavoro, ma lo riscrisse completamente, arricchendolo di nuove piante e accentuando il taglio propriamente "botanico". Se quando scrisse il Cruydeboeck, Dodoens era essenzialmente un medico erudito prestato alla botanica, ora, dopo dieci anni di ricerche, era un botanico a tutti gli effetti. E se la prima opera gli aveva richiesto circa tre anni, tra la stesura e la revisione, la seconda richiese un ventennio, per molte ragioni: la necessità di conciliare la ricerca scientifica e l'attività editoriale con un'intensa pratica medica; la situazione politica sempre più tesa che trasformò le Fiandre in un campo di battaglia (Mechelen, la città dove abitava Dodoens, fu presa e saccheggiata due volte: nel 1572 dalle truppe del duca d'Alba e nel 1580 da quelle dell'Unione di Utrecht); i riflessi di tale situazione sulla sua vita personale (dopo aver trascorso tutta la vita tra Malines e Anversa, l'ultimo decennio della sua esistenza lo vide medico imperiale a Vienna quindi, dopo un breve soggiorno a Colonia, professore universitario a Leida). L'opera maggiore di Dodoens, prima di essere pubblicata in edizione definitiva nel 1583, con il titolo Stirpium historiae pemptades sex, uscì, si potrebbe dire, a puntate. Il primo frutto della collaborazione tra Dodoens e Plantin fu nel 1565 Historia frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum ("Storia dei cereali, dei legumi e delle erbe palustri e acquatiche"); il libro confluirà nella quarta sezione delle Pemptades. Nel 1567 seguì Florum et coronarium, odoratumque herbarum historia ("Storia delle piante da fiore, adatte a far corone e odorifere"), notevole perché è uno dei primi trattati specificamente dedicati alle specie ornamentali; confluirà nella seconda parte delle Pemptades. Più tradizionale l'argomento della terza "puntata" (1574), Purgantium aliarumque eo facentium, tum et radicum, convolvulorum ac deleteriarum herbarum historiae libri III ("Tre libri sulla storia dei purganti e di altre piante con effetti simili, compresi radici e convolvoli e piante nocive"), che entrerà, con molte aggiunte, nella terza sezione delle Pemptades; unico opuscolo non edito da Plantin, uscì nel 1580 a Cologna, dove Dodoens si trattenne al suo rientro da Vienna, in attesa che la situazione delle Fiandre si facesse meno confusa.Seguì una breve pubblicazione sulla vite, in cui Dodoens inserì anche piante di varia natura non trattate in precedenza, Fu ancora Plantin, invece, a pubblicare nel 1583 l'opus magnum in cui confluiscono il Cruydeboek, i quattro opuscoli e ulteriori contributi: Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX, un grande volume di oltre 900 pagine. Le piante sono distribuite in sei grandi categorie, articolate a loro volta in 26 gruppi (detti pemptades, perché, tranne la prima sezione, tutte le altre sono divise in cinque sottosezioni), alcuni dei quali possono corrispondere almeno in parte alle nostre "famiglie": - Prima sezione: tutte le piante non inserite in altre classi, presentate in ordine alfabetico, raggruppando insieme tuttavia quelle che presentano somiglianze e affinità: troviamo un vasto gruppo di piante vulnerarie, e alcuni raggruppamenti affini a famiglie (ad esempio quelle che oggi chiameremmo Crassulaceae e Saxifragaceae); - Seconda sezione: fiori notevoli come ornamentali e medicinali; erbe profumate (tra cui numerose Umbelliferae, riconosciute come un gruppo naturale anche per la struttura delle infiorescenze); - Terza sezione: piante di uso medicinale non trattate precedentemente (radici con proprietà officinali, piante purgative, radici purgative della famiglia Convolvulaceae, piante velenose; crittogame, sistemate qui perché molte hanno proprietà nocive); - Quarta sezione: piante usate come cibo di uomini e animali (qui si riconoscono due gruppi abbastanza evidenti, i cereali e le leguminose, anche se queste sono divise tra legumi e foraggere); - Quinta sezione: piante orticole e culinarie (l'ultima pemptas raggruppa, in base a affinità formali, diversi "cardoni" che ora assegneremmo a famiglie diverse); - Sesta sezione: arbusti e alberi (divisi rispettivamente in arbusti spinosi e senza spine; alberi coltivati nei giardini e nei frutteti, forestali e sempreverdi). Appena due anni dopo la pubblicazione del grande lavoro, Dodoens morì a Leida dove da pochi anni insegnava medicina. Celebratissimo come medico di eccezionale competenza e grande botanico, ai suoi tempi fu il più noto della triade fiamminga formata con Clusius e l'Obel, tanto da guadagnarsi l'appellativo di "Teofrasto fiammingo". Una sintesi della sua vita nella sezione biografie.  Dodonaea, australiana vagabonda Tra le piante ornamentali, Dodoens ne aveva descritte alcune notevoli per i loro semi. Se l'avesse conosciuto, qui avrebbe collocato il genere Dodonaea, che ha fiori insignificanti ma splendide capsule alate. La prima ad essere descritta fu la sola specie diffusa in ampie aree tropicali, D. viscosa, che nel 1753 Linneo descrisse in Species plantarum come Ptelea viscosa, e l'anno successivo fu rinominata D. viscosa da Philip Miller in onore del nostro Dodoens, la cui opera era ben nota e apprezzata dai botanici britannici. Nelle edizioni successive, Linneo farà propria la denominazione milleriana. Il genere Dodonea, appartenente alla famiglia Sapindaceae, comprende una specie di specie di alberelli e arbusti sempreverdi, il cui centro di diffusione è l'Australia (tranne tre, tutte le specie sono endemismi australiani), nettamente distinte in due gruppi in base alla struttura delle foglie: nella maggior parte delle specie, esse sono semplici e lineari; in un gruppo minoritario, sono invece composte. Piante adattabili che, crescono in una varietà di condizioni, soprattutto nelle formazioni di macchia arida, non si mettono in mostra né per il portamento né per i fiori, maschili e femminili (si tratta di piante per lo più dioiche) privi di petali. A dare spettacolo sono piuttosto le capsule alate dei frutti che spesso assumono colori inconsueti: rosso, rosa carico, rosa antico. L'unica specie reperibile da noi è D. viscosa, polimorfica e adattabile, che - secondo la ricostruzione dei paleobotanici - nell'arco di due milioni di anni dalla nativa Australia ha colonizzato le aree tropicali, subtropicali e calde di Oceania, America meridionale, Africa e Asia. Questa pianta vagabonda sta diventando di moda ed è proposta anche da noi da alcuni garden center; del resto, ben si adatta al clima mediterraneo. La forma più coltivata è D. viscosa 'Purpurea', una forma di origine neozelandese, con foglie sfumate di porpora e capsule rosate. Qualche informazione in più nella scheda. A proporre una delle prime classificazioni delle piante è alla fine del Cinquecento Mathias de l'Obel, ovvero Lobelius, con l'amico Pierre Pena. Basata sulle foglie, è un po' bizzarra a nostri occhi, senza dubbio un vicolo cieco, ma non priva di meriti. Tanto è vero che il bestseller di l'Obel, Icones stirpium, fu assai consultato da Linneo. Entrambi gli amici sono ricordati da un genere, in fondo azzeccato: il dimenticato Pena dal poco noto Penaea, il celebrato Lobelius dal diffusissimo Lobelia. 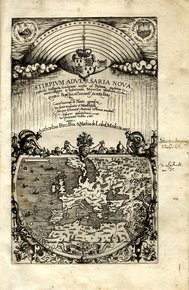 Un'amicizia e un sodalizio intellettuale Nella tarda primavera del 1565, giungono a Montpellier, a un mese di distanza l'uno dall'altro, due studenti non più giovanissimi. Il primo, ad aprile, è Pierre Pena, un "figlio del paese", un provenzale che ha abbracciato la riforma. Il secondo, a maggio, è Mathias de l'Obel (o de Lobel, o alla latina, Lobelius), un fiammingo di Lilla. Dato che purtroppo conosciamo male la giovinezza di entrambi, non sappiamo se si conoscessero già, e avessero addirittura erborizzato insieme in Germania, in Svizzera e in Italia, o se si incontrassero qui per la prima volta. Certo è che da quel momento diverranno inseparabili. Li ritroviamo in un team di sei studenti, sotto la guida di Assatius, collaboratore e genero di Rondelet, a erborizzare nei dintorni di Montpellier; o insieme a un vasto gruppo di studenti, partecipare a una gita a Marsiglia che è allo stesso tempo una spedizione scientifica e un'allegra scampagnata tra amici. Nonostante la sua rozzezza di modi e le lacune della sua formazione accademica (il suo latino è privo di eleganza e non sempre ineccepibile), Rondelet è così colpito dell'acume di de l'Obel che quando morirà, poco più di un anno dopo, gli lascerà in eredità i suoi scritti botanici. Di nuovo, non sappiamo esattamente cosa successe dopo la morte di Rondelet: forse gli amici si fermarono ancora nel Midi ad esplorare Linguadoca e Provenza, forse conseguirono la laurea (mancano i registri di questi anni), forse partirono dopo pochi mesi. Di nuovo, abbiamo una data certa: nel 1570 erano sicuramente in Inghilterra, e vi si trovavano da qualche anno (almeno dal 1568). Non sappiamo quali motivi li avessero spinti a raggiungere il regno di Elisabetta: forse la situazione politica (l'Obel parlerà esplicitamente dei Paesi Bassi come di una terra "bagnata dal sangue umano": sono gli anni in cui il duca d'Alba cerca di schiacciare nei sangue la rivolta dei Paesi Bassi), forse il desiderio di esplorare una flora ancora largamente sconosciuta ai botanici del continente. La data ci è fornita dalla loro opera comune: alla fine del 1570 o all'inizio del 1571, esce a Londra per i tipi dello stampatore Thomas Purfoet (o Pufoot) Stirpium adversaria nova, il libro che gli amici hanno scritto a quattro mani. Il curioso titolo si rifà agli adversaria, i libri dei conti in cui i negozianti annotavano giorno per giorno entrate e uscite. Vuole essere dunque un registro delle piante (circa 1200) viste e raccolte per esperienza diretta soprattutto in Provenza e in Linguadoca, ma anche nel corso di altri viaggi (tra il 1562 e il 1563 l'Obel da solo o insieme a Pena visitò l'Italia settentrionale e conobbe tutti quelli che contavano nella botanica italiana). 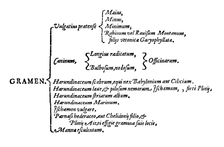 Una classificazione basata sulle foglie La novità di Stirpium adversaria nova non sta nel metodo (abbondano ancora i riferimenti eruditi ai botanici dell'antichità, con le solite polemiche feroci sull'identificazione delle specie di Dioscoride e soci), né nell'accuratezza delle descrizioni (Tournefort noterà che è quasi impossibile identificare le piante non accompagnate da disegni). A parte un'insolita attenzione all'habitat (di ogni specie è indicato, in genere, il luogo di raccolta e l'ambiente), è nuovo il modo di organizzare le piante. Gli autori si sono infatti proposti di raggrupparle in modo "naturale", in base a evidenti somiglianze morfologiche, così che il molteplice venga ricomposto nell'uno: "Quest'ordine si sviluppa uno e identico a se stesso, conduce dai semplici più vicini ai sensi e più familiari a quelli più sconosciuti e compositi, seguendo un percorso di somiglianze e familiarità, grazie al quale, per quanto possibile, le piante vengono a corrispondersi sul piano universale e particolare attraverso la varietà e l'immensità". E' lo stesso intento di Cesalpino (l'Obel lo conobbe in Italia, e forse ne fu influenzato), ma attuato in modo assai diverso, quasi opposto. Come Cesalpino, l'Obel si rifà ad Aristotele (citato poco più avanti nello stesso passo), ma mentre l'italiano muoveva dal generale al particolare (partendo da considerazioni generali sulla natura, ovvero l'essenza, dei vegetali, per poi giungere a categorie specifiche, con approccio deduttivo), il fiammingo parte dall'osservazione del molteplice per giungere all'uno (con approccio induttivo, dal particolare al generale). E se i ragionamenti filosofici avevano indotto Cesalpino a scegliere come criterio di classificazione gli organi riproduttivi (in particolare i frutti e i semi), l'osservazione diretta delle piante induce l'Obel a scegliere l'organo più immediatamente percepibile: le foglie. Oggi noi sappiamo che, per convergenza evolutiva, piante diversissime che vivono negli stessi ambienti possono avere aspetto simile; le foglie, da questo punto di vista, sono particolarmente ingannevoli. Ciò non toglie che quello di l'Obel (e Pena) sia stato il primo tentativo di raggruppare le piante per affinità naturali, giungendo a individuare delle sorta di "famiglie". Almeno un risultato è stato raggiunto: anche se solo sulla base della diversa struttura delle foglie, vengono chiaramente distinte le monocotiledoni (con foglie, in genere allungate, caratterizzate da nervature parallele) e le dicotiledoni (con foglie distinte in picciolo e lamina, caratterizzate da nervature reticolate). Non mancano le confusioni, i vicoli ciechi e le incongruenze: ad esempio, le monocotiledoni con lamina fogliare ampia, come Arum, finiscono con le dicotiledoni. Trifogli, Oxalis e Hepatica, che hanno foglie a tre o quattro lobi, sono raggruppate insieme; piante prive di foglie verdi, come Orobanche, finiscono insieme ai funghi. D'altra parte, anche i criteri di classificazione sono incongruenti: così, ninfee, loti, Caltha e Hydrocharis stanno insieme (sono tutte piante che fluttuano sull'acqua). Tuttavia, a sfogliare il testo di l'Obel, abbiamo l'impressione che un ordine inizi a delinearsi. Non più piante in ordine alfabetico (tra l'altro, in base al nome greco come in Fuchs o in Mattioli), raggruppate in base alle virtù terapeutiche o agli usi pratici, oppure disposte dall'alto in basso (dagli alberi, le essenze più nobili, fino alle erbe, le più effimere e insignificanti, come in Teofrasto). L'Obel e Pena procedono esattamente al contrario: si parte dalle forme più semplici, più comuni, cioè dalle graminacee, per giungere via via a forme più articolate e complesse. I gruppi non hanno nome (se non quello di una specie più nota e familiare, molto lontanamente paragonabile al "genere tipo" della tassonomia odierna) e manca anche un'esposizione teorica dei criteri seguiti; tuttavia, ciascun gruppo è corredato di tabelle o schemi ad albero che evidenziano visivamente i rapporti tra le diverse "stirpi". Accanto alle piante medicinali o utili all'uomo, acquistano diritto di cittadinanza anche le "erbacce". Attività editoriali e mediazione culturale E' oggetto di discussione quale sia stata il ruolo rispettivo dei due autori nella raccolta dei materiali e nella redazione di Stirpium adversaria nova: c'è chi giudica il contributo di Pena insignificante, chi al contrario vorrebbe attribuirgliene quasi l'intera paternità. Sta di fatto che poco dopo la pubblicazione, le strade dei due si divisero: Pena tornò in Francia, abbandonò del tutto la botanica e la scrittura (non risulta aver pubblicato nient'altro) per dedicarsi a una lucrosa attività di medico specializzato nella cura della sifilide. Il poco che sono riuscita a appurare sulla sua vita, assai mal nota, è esposto nella sezione biografie. All'opposto, Mathias de l'Obel, anch'egli rientrato in patria, divenne un botanico militante e un attivo pubblicista. Per qualche anno visse ad Anversa ed entrò a far parte della scuderia di Christophe Plantin. Scrisse un supplemento degli Adversaria, Stirpium Observationes, che nel 1576 fu pubblicato da Plantin, insieme a una riedizione dell'opera prima, in un'edizione assai curata accompagnata da quasi 1500 xilografie, sotto il titolo Plantarum seu stirpium historia (nel frontespizio compare solo il nome di l'Obel, mentre quello di Pena è conservato nel frontespizio della seconda parte, per la quale Plantin si accontentò di riutilizzare le copie rimaste invendute dell'edizione Purfoot, cambiando appunto solo il frontespizio). Nel 1581 seguì la versione in fiammingo, con il titolo Krydtboeck. Queste vicende mi sembrano confermare il ruolo secondario di Pena nella redazione di Stirpium adversaria nova: se davvero fosse stato un botanico così geniale e innovativo, come mai non si è più occupato di botanica? se avesse scritto gran parte di quell'opera, non avrebbe in qualche modo reagito al tentativo di l'Obel di appropriarsene? Che almeno il sistema tassonomico basato sull'osservazione delle foglie si debba a l'Obel, è confermato a mio parere da un'altra impresa editoriale plantiniana. Poiché le opere di botanica illustrate avevano un grande successo di mercato, sempre nel 1581 l'editore pensò di pubblicare in un solo volume più di 2000 xilografie ricavate dalle opere di Dodoens, Clusius e l'Obel; la redazione venne affidata a quest'ultimo che riorganizzò le illustrazioni disponendo le piante secondo la sua classificazione e corredò ciascuna tavola con un nome descrizione e un rimando alla pagina relativa di Plantarum seu stirpium historia; in una riedizione, fu aggiunto un indice in sette lingue che rese l'opera fruibile agli studenti di botanica dei principali paesi europei. Il volume, pubblicato con il titolo Icones stirpium, fu senza dubbio un grande successo editoriale, oltre che l'opera più nota di l'Obel, e non mancò di influenzare Linneo, che lo cita ripetutamente. Dopo essere stato per qualche anno medico di Guglielmo il taciturno a Delft, de l'Obel (forse alla fine degli anni '80) ritornò in Inghilterra dove entrò al servizio di lord Zouche come curatore del giardino di Hackney, nei pressi di Londra, allora il più importante del paese, che univa alle funzioni di orto botanico quello di giardino di piacere. Nominato più tardi giardiniere del re Giacomo I (un incarico del tutto onorifico), egli esercitò un essenziale ruolo di intermediazione tra la botanica continentale, più avanzata sul piano teorico, e la più empirica botanica inglese. Inizialmente amico del più noto botanico inglese di fine Cinquecento, John Gerard, nel 1596, scrisse la prefazione della sua prima opera, Catalogue of Plants. L'amicizia si ruppe quando, nel 1597, riscontrando il Great Herball dell'inglese, de l'Obel individuò non solo più di mille errori, ma ampi plagi delle sue stesse opere. Altre notizie sulla vita, purtroppo non ben conosciuta, di questo influente botanico nella sezione biografie.  La sconosciuta Penaea e l'ubiquitaria Lobelia Se Pena, al contrario di l'Obel, è stato quasi dimenticato, almeno sul versante della nomenclatura botanica i due amici hanno avuto diritto a pari onori: non solo ad entrambi è stato dedicato un genere, ma l'uno e l'altro hanno avuto la ventura di tenere a battesimo un'intera famiglia. Non stupisce che l'omaggio sia partito in primo luogo da Plumier, egli stesso provenzale (è anche una delle nostre poche fonti sulla vita di Pena), che nel suo Nova plantarum americanarum genera ne battezzò due generiPenaea e Lobelia; nessuno dei due corrisponde però ai generi attuali (la Penaea di Plumier è una Polygala e la sua Lobelia venne rinominata Scaevola da Linneo). Infatti lo scienziato svedese in Species plantarum, 1753 riutilizzò le due denominazioni, attribuendole ad altre piante. Penaea dà il nome alla piccolissima famiglia delle Peneaceae, che comprende solo sette generi e una ventina di specie, limitate alle aree meridionali e sudorientali della provincia del Capo in Sud Africa. Sono arbustini caratteristici della tipica formazione vegetale del fynbos, affine alla nostra macchia mediterranea, con piante adattate a condizioni semiaride con piogge invernali. Il genere Penaea comprende quattro specie: P. mucronata, P. cneroum, P. acutifolia, P. dahlgreenii; sono piccoli arbusti con fusti quadrangolari e foglie coriacee, alternate o opposte, e infiorescenze terminali di piccoli fiori poco vistosi, con tubo fuso e quattro lobi più o meno appuntiti, gialli, rossastri o bianchi. Non avendo particolare pregio estetico, non sono stati finora introdotti in coltivazione. Tutto il contrario della notissima e diffusissima Lobelia erinus, la più coltivata delle Lobeliae, fin troppo sfruttata in giardini e fioriere. Il genere Lobelia, assegnato ora alla famiglia Campanulaceae, ora a una famiglia propria (Lobeliaceae) è presente in tutti i continenti, tranne l'Antartide; comprende più di 400 specie, che stupiscono per la grande varietà di forme e dimensioni (si va dalle erbacee annuali, alle perenni, incluse alcune palustri, agli arbusti). Al di là delle enormi differenze di aspetto generale, di portamento, di rusticità, tutte sono accomunate dalle foglie lanceolate e dai fiori tubolari bilabiati, spesso con fioriture spettacolari e prolungate dai colori vibranti, che le hanno rese popolari nei giardini. Le più note sono senza dubbio l'erbacea L. erinus, una perenne di origine sudafricana che noi coltiviamo come annuale nelle aiuole e sui balconi, oggi disponibile in tutte le gamme dell'azzurro e del viola, cui di recente si è aggiunto il rosso; le grandi perenni rustiche nordamericane, la rossa L. cardinalis e l'azzurra L. siphilitica, entrambe in passato utilizzate nella cura della sifilide. Ma accanto ad esse ci sono le sorprendenti Lobeliae arbustive del Sud America e dell'Asia orientale, come L. tupa; e le ancor più stupefacenti Lobeliae giganti dell'Africa e dell'arcipelago delle Hawaii. Qui, dove sono arrivate circa 13 milioni di anni fa forse dall'Asia, forse dall'America meridionale, grazie al clima favorevole e al fertile suolo, si sono rese protagoniste di un'eccezionale differenziazione genetica, grazie alla quale le Lobelioideae sono divenute il gruppo di angiosperme dominanti nelle isole, con sei generi (Lobelia e cinque generi endemici) e 125 specie endemiche. Uno di essi, Trematolobelia, rende a sua volta indirettamente omaggio al nostro Lobelius. E' un piccolo genere di otto specie dalle fioriture spettacolari, con grandi racemi di fiori tubolari dai lobi ricurvi, arricciati, posti come i bracci di un candelabro. Qualche informazione in più su Penaea, Lobelia e Trematolobelia nelle rispettive schede. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|
 RSS Feed
RSS Feed