|
E' piuttosto inconsueto che un botanico affermato, professore universitario e membro dell'Accademia delle scienze del proprio paese, a cinquant'anni suonati parta per una pericolosa spedizione scientifica ai tropici. Eppure il professor de Vriese, quando il parlamento olandese gli chiede di andare in missione in Indonesia, non esita a partire, forse affascinato dalla prospettiva di vedere nel loro ambiente naturale le piante che studia da sempre in erbari e serre. Non sa ancora che il prezzo da pagare sarà la sua stessa vita. Rivolgetegli un pensiero quando ammirate la fioritura delle piante che lo celebrano, le bellissime Vriesea.  L'uomo giusto al momento giusto Impressionato dalle rivoluzioni che scuotono l'Europa, nel marzo 1848 il re d'Olanda Guglielmo II decide di trasformare il paese in una monarchia costituzionale. A capo della commissione che dovrà elaborare il testo della nuova costituzione, non esista a nominare Johan Rudolph Thorbecke, il leader dei liberali; proclamata il 3 novembre dello stesso anno, la costituzione prevede tra l'altro elezioni dirette con voto segreto, limitazioni del potere del sovrano, maggiore autonomia delle province, libertà di religione. Per la prima volta, il parlamento ottiene la giurisdizione sulle colonie, fino ad allora sotto l'esclusiva autorità del re. In Indonesia, i liberali al potere, fautori del liberismo economico, vorrebbero spezzare il sistema delle coltivazioni forzate, introdurre un'economia basata sul lavoro libero e aprire le Indie olandesi al capitale privato. Al di là delle petizioni di principio, devono muoversi con cautela perché dal batig slot, ovvero dai proventi versati al tesoro da quelle colonie, dipende larga parte del bilancio statale. Una soluzione per alleggerire le terribili condizioni dei contadini giavanesi, senza mandare in crisi il bilancio olandese, potrebbe essere l'introduzione di coltivazioni coloniali più redditizie, come sta facendo in quegli anni l'Impero britannico in India. E' in questo contesto che il governo olandese nel 1852 invia in Perù il botanico J.C. Hasskarl per cercare di procurarsi pianticelle di Cinchona, la pianta da cui si ricava il chinino, da introdurre a Giava; nel 1854 egli è di ritorno in Indonesia con un carico di virgulti che trapianta nell'orto botanico di Bogor/Buitenzorg. Non è un'iniziativa isolata. Nel 1857 il parlamento olandese decide di inviare in Indonesia un esperto di agronomia tropicale per studiare l'economia agricola delle isole e valutare le strategie migliori per affrancarla dal regime delle coltivazioni forzate. La scelta cade su Willem Hendrik de Vriese, professore di botanica dell'università e direttore dell'orto botanico di Leida. Come leggiamo nell'atto di nomina, approvato dal re, egli dovrà individuare le produzioni esotiche più adatte ai diversi climi delle isole e ricercare le piante native più utili per "le arti e il commercio". De Vriese era la persona perfetta per questo compito, per la sua profonda conoscenza della flora indonesiana e per i numerosi studi dedicati alle piante esotiche utilitarie. Medico, aveva insegnato botanica dapprima ad Amsterdam, poi a Leida, dove era succeduto a Reiwardt. Già esperto di piante esotiche, aveva particolare dimestichezza con la flora indonesiana per aver catalogato le piante raccolte dal suo predecessore e aver curato la pubblicazione del suo diario di viaggio in Plantae Indiae Batavae Orientalis : quas, in itinere per insulas archipelagi indici Javam, Amboinam, Celebem, Ternatam, aliasque, annis 1815-1821 exploravit Casp. Georg. Carol. Reinwardt (1856). Tra il 1855 e il 1856 pubblicò anche un'opera illustrata in tre volumi di orticultura e floricoltura (Tuinbouw-flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen) in cui le piante esotiche hanno larga parte. Gli si devono anche due importanti monografie su Rafflesia e sulle Marattiaceae (con Pieter Harting); era anche un esperto di felci e orchidee. Negli anni cinquanta, egli dedicò poi una serie di saggi a importanti piante tropicali di cui propugnava l'introduzione nelle colonie olandesi: nel 1855 Cinchona, nel 1856 Vanilla e Cinnamomum camphora. 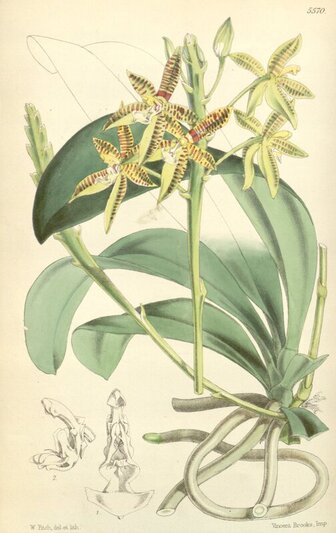 Un faticoso periplo tra le isole Il 28 ottobre 1857 de Vriese si imbarcò a Marsiglia alla volta dell'oriente; lo accompagnava il chimico de Vry, incaricato di studiare i principi attivi della Cinchona coltivata a Bogor. La prima tappa fu Ceylon, dove il botanico olandese studiò le piantagioni di caffè, all'epoca tra le più importanti del mondo; solo qualche anno più tardi, devastate da Hemileia vastatrix, sarebbero state sostituite dal tè. All'inizio dell'anno, via Singapore, si spostò a Giava, che visitò quasi per intero nel corso del 1858 e della prima metà del 1859; a questo punto si unì a Johannes Elias Teijsmann, il capo giardiniere di Buitenzorg/Bogor, con il quale visitò la parte orientale dell'isola e la desolata Madura. Teijsmann sarà ancora il suo compagno di viaggio in una impegnativa spedizione nelle Molucche, sulla quale siamo più informati grazie alla relazione che ce ne ha lasciato. Imbarcatisi a Surabaya il 15 dicembre, all'inizio del 1860 i due viaggiatori fecero scalo per qualche giorno a Makassar nell'isola di Celebes (oggi Sulawesi); si spostarono subito a Timor, dove si trattennero appena un giorno a Kupang, per poi passare a Dili e alle isole Banda: una visita doverosa, anche se ormai avevano perso l'importanza strategica che avevano rivestito per gli olandesi nell'arco di due secoli. Dal 1621 al 1810, come unico luogo al mondo dove si coltivava Myristica fragrans, avevano garantito all'Olanda il lucroso monopolio della produzione di noce moscata e macis. Un monopolio infranto dall'occupazione britannica del 1810: restituendo le isole dopo il Congresso di Vienna, gli inglesi si erano premurati da fare incetta delle preziose pianticelle, trapiantate con successo a Ceylon e in altre colonie. Ormai più importante la tappa successiva, Ambon, antico centro del commercio delle spezie, promettente per il suolo fertile e la varietà di ambienti naturali. Nei primi mesi del 1860, i due botanici vi stabilirono il loro quartier generale per l'esplorazione delle Molucche settentrionali. La prima spedizione fu dedicata alla piccola isola di Saparua ma soprattutto a Ceram (oggi anche Seram), dove de Vriese e Tejismann poterono dismettere i panni di agronomi e ispettori per tornare ad essere botanici. Ancora in gran parte ricoperta dalla foresta pluviale, questa isola dove gli animali e le piante dell'Asia si incontrano con quelli dell'Australia, con un clima caldo umido e un'intricata topografia montagnosa, dovette essere per de Vriese quasi il luogo dei sogni, dove studiare nel loro ambiente naturale le piante che amava di più: in primo luogo le felci, una delle sue specialità (oggi nell'isola si calcola ne vivano oltre 700 specie), ma anche le orchidee e le piante officinali, la cui ricognizione era uno degli obiettivi della sua missione. Nei mesi successivi fu la volta di Buru, quindi Ternate (in entrambe queste isole scalarono anche alcune cime), Tidore, Halmahera e numerosi isolotti. Ad aprile erano a Bacan, quindi, ormai sulla via del ritorno si spostarono a Celebes, dove si trattennero fino a giugno, visitando molte località delle regioni settentrionali. Alla fine del mese, erano di ritorno a Surabaya. Dato che da questo momento si separò da Tejismann, conosciamo meno dettagliatamente i viaggi successivi di de Vriese. Nella seconda parte del 1860 fu in Borneo e poi di nuovo a Giava, dove visitò le regioni centrali trascurate l'anno precedente; poi si spostò a Sumatra, dove si trovava all'inizio del 1861. Fu da Sumatra che probabilmente si imbarcò per l'Olanda, con la salute ormai compromessa da un'avventura tanto faticosa per un uomo che aveva superato la cinquantina. Al suo rientro in patria, nel marzo 1861, ebbe il dolore di perdere la moglie; ormai gravemente malato, non poté né riprendere la carriera universitaria né pubblicare i risultati della sua missione, morendo dieci mesi dopo il ritorno. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. Intanto, il progetto di valorizzare le Indie orientali olandesi con l'introduzione di nuove specie andava avanti. Pur tra polemiche e mille difficoltà, la sperimentazione della coltivazione di Cinchona proseguì con successo e entro fine secolo l'Olanda si era assicurata il monopolio della produzione mondiale di chinino; intorno al 1860, a Sumatra arrivò il cacao e all'inizio del Novecento l'albero della gomma, Hevea brasiliensis. A guadagnarci, però, non furono certo i contadini indonesiani.  Vriesea, bellezza tropicale Molto prima della faticosa missione che gli sarebbe costata la salute e la vita, il professor de Vriese si era già fatto un nome negli ambienti della botanica europea. Infatti, nel 1843, quando egli insegnava ancora a Amsterdam, John Lindley, separando da Tillandsia una specie brasiliana, T. psittacina, creò il genere Vriesea in suo onore con la seguente dedica: "Ho così colto l'opportunità di onorare i meriti del dottor W. de Vriese, professore ad Amsterdam, un eccellente botanico e fisiologo". Vriesea è oggi uno dei generi più importanti e il secondo per numero di specie della famiglia Bromeliaceae (circa 250). Per lo più epifite, vivono in foreste umide anche d'altura dal Messico al Brasile. Dato che si adattano bene alla limitata luminosità delle nostre case, sono anche una tra le più popolari piante d'appartamento, grazie alla bellezza della foglie, spesso elegantemente variegate, e delle infiorescenze a forma di spiga, che si fanno notare per le brattee dai colori squillanti da cui sporgono i fiori tubolari, spesso in colore contrastante; un'accoppiata frequente è data dal rosso e dal giallo. Anche se alcune specie (come V. carinata o V. hieroglyphica) sono abbastanza coltivate, a dominare il mercato sono soprattutto gli ibridi; da questo punto di vista, del resto, tra le Bromeliaceae Vriesea vanta un duplice primato: è stato il primo genere ad essere ibridato con successo, ed attualmente è quello con un maggior numero di ibridi. Per la cronaca, il primo fu prodotto in Belgio nel 1879 da Eduard Morren, curatore dell'Orto botanico di Liegi incrociando V. psittacina e V. carinata. Altre notizie nella scheda.
0 Comments
Talvolta, la giustizia poetica è concessa anche ai nomi botanici. Che a ricordare il grande Michel Adanson, autore di un'opera impossibile per il suo stesso gigantismo, per perseguire la quale egli rinunciò a fama, riconoscimenti materiali e alle stesse elementari necessità della vita per chiudersi nel suo lavoro solitario, sia proprio il baobab, albero gigante che si erge sulla arida savana, vive per migliaia di anni e supera le peggiori siccità accumulando acqua nel fusto e rinunciando alle foglie, ne è la dimostrazione. A guidare la mano dell'inconsapevole Linneo e a ispirargli la creazione del genere Adansonia, molto prima che il destino di Adanson si palesasse, è uno scherzo della sorte o, appunto, un atto di giustizia poetica. 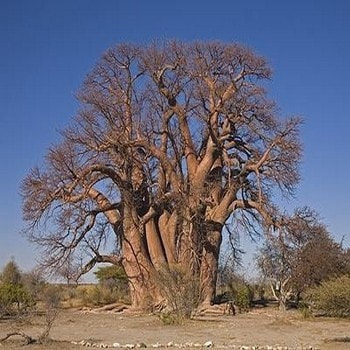 Primo atto: un viaggio in Senegal L'incontro tra i due protagonisti della nostra storia avviene nell'agosto del 1749, nel villaggio senegalese di Sor. Michel Adanson è arrivato in Senegal da circa sei mesi ed è ancora pieno di entusiasmo e di stupore per la ricchezza della natura tropicale. Ha già imparato abbastanza la lingua wolof (tra i suoi tanti talenti c'è anche quello linguistico) da muoversi da solo; chiede indicazioni su un buon terreno da caccia e viene indirizzato sulle tracce di un branco di gazzelle. Ma una visione stupefacente spegne ogni interesse venatorio: è un albero immenso, il più grande che abbia mai visto. Non per l'altezza (forse una ventina di metri), ma per la circonferenza straordinaria; incredulo, Adanson gli gira intorno tredici volte. Cerca di misurarla allargando le braccia, poi con una corda. Calcola una circonferenza di 20 metri, e un diametro di quasi 7. Ciascuno dei rami che forma la chioma, alcuni dei quali toccano terra, è più lungo e spesso del tronco di uno dei maggiori alberi monumentali d'Europa. L'albero in sé non è raro, aggiunge Adanson, appartiene anzi a una delle specie più comuni nel paese, che i francesi chiamano calebassier, o anche pain-de-singe ("pane delle scimmie") e i locali goui. Noi lo conosciamo con il nome di origine araba baobab, ma anche - grazie a Bernard de Jussieu e a Linneo - come Adansonia digitata. Nel momento in cui incontrò l'albero destinato a preservare il suo nome, Adanson aveva 22 anni, ma era già un naturalista ambizioso e singolare. La famiglia lo aveva destinato alla chiesa e durante gli anni di collegio si era distinto come allievo solerte e brillante; quattordicenne, aveva attirato l'attenzione del biologo inglese John Needham che gli donò un microscopio con queste parole: "Dato che avete imparato così bene a conoscere le opere degli uomini, è ora che studiate quelle della natura". Fu una folgorazione. Il ragazzo incominciò a frequentare il Jardin du Roy e le lezioni di Réaumur e Bernard de Jussieu. A diciotto anni conosceva migliaia di specie vegetali e sapeva classificare tutte le piante del giardino. Gli era anche chiaro che il suo destino non era nella Chiesa, ma nello studio della natura. Rinunciò al beneficio ecclesiastico che aveva coperto i costi degli studi e insisté con il padre - scudiero del vescovo di Parigi - perché trovasse il modo di farlo partire per un paese tropicale, se possibile inesplorato. Grazie a Pierre-Barthélemy David, direttore della Compagnia delle Indie, ottenne infine un modesto posto di commesso a Saint-Louis, l'emporio della compagnia sulla costa del Senegal. Malfamato per il suo clima insalubre, era praticamente sconosciuto ai naturalisti. Senza alcun incarico ufficiale, senza alcun titolo di studio formale, fu dunque come "impiegato incaricato di tenere i registri" che Adanson il 3 marzo 1749 si imbarcò a Lorient sul Chevalier marin. Si era preparato con scrupolo al viaggio, raccogliendo tutte le informazioni possibili sul clima, gli animali, le piante, le lingue, i costumi locali. Aveva imparato i metodi più all'avanguardia per conservare piante e animali. Nel suo bagaglio, telescopi, barometri, termometri e altri strumenti scientifici. Il soggiorno di Adanson in Senegal si prolungò per cinque anni (fino al febbraio 1754), fu ricchissimo di risultati scientifici, ma difficile da ogni punto di vista. Si ammalò ripetutamente e la Compagnia si dimostrò ostile; anche se lui cercava di convincere i suoi capi dell'utilità anche economica delle sue ricerche, per loro questo impiegato che si dava troppo da fare e faceva di tutto tranne quello per cui era pagato, era davvero meno che inutile. Solo grazie alle insistenze dei suoi protettori parigini (in particolare Jussieu e Réaumur) riuscì ad ottenere il permesso di coltivare un piccolo giardino, dove sperimentava incroci e coltivava piante rare da introdurre in Francia. Eppure, era attivissimo: oltre a St. Louis e ai suoi dintorni, visitò l'isola di Gorée, Podor, e il bacino del Gambia; annotò dati meteorologici e astronomici, disegnò mappe, imparò lingue e compilò dizionari, raccolse ogni sorta di dati etnografici, geografici, economici. E, ovviamente, campioni di minerali, animali, piante. Spedì centinaia di esemplari ai corrispondenti parigini, e molte migliaia lo avrebbero accompagnato nelle casse che portò con sé nel viaggio di ritorno, insieme a 300 piante vive da acclimatare al Jardin du Roy. 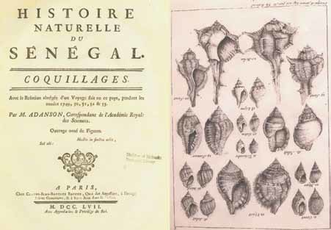 Secondo atto: un'opera pionieristica Provato dal clima tropicale, privo di mezzi e di relazioni, l'uomo che sbarca infine in Francia nel 1754 è molto diverso dal ventunenne di quasi sei anni prima. Da quell'esperienza, oltre all'enorme mole di materiali, ha portato indietro una convinzione profonda: per comprendere la natura, la scienza deve cambiare paradigma. Tutti i sistemi che si è finora data per classificarla, di fronte alla sterminata esuberanza dei tropici, dimostrano la loro inconsistenza: "Appena lasciamo i nostri paesi temperati per entrare nella zona torrida, la botanica sembra mutare totalmente volto: sono sempre piante, ma sono così particolari nelle loro loro forme, hanno caratteristiche così nuove che eludono la maggior parte dei nostri sistemi, i cui limiti non vanno al di là delle piante dei nostri climi". Ma il primo compito è studiare e pubblicare le raccolte senegalesi. Ospitato generosamente dai Jussieu, Adanson elabora il primo dei suoi grandiosi progetti: una storia naturale del Senegal in otto volumi. In realtà, ne scriverà solo il primo: Histoire naturelle du Sénegal (1757) comprende il vivace racconto del suo viaggio e le descrizione delle conchiglie senegalesi, che egli classifica in modo del tutto originale, non più basandosi sulle conchiglie stesse, come si faceva all'epoca, ma sui molluschi che vivono all'interno e le loro strutture. E' il primo saggio di quel metodo globale che tra poco vedremo in azione con le piante. Benché parziale, l'opera gli assicura fama immediata. Adanson è ammesso all'Accademia delle Scienze parigina, seguita qualche anno dopo dalla Royal Society. Ottiene una pensione con il titolo (praticamente una sinecura) di censore reale. Ma ormai sta perseguendo un nuovo progetto. Dal 1759, collabora con il maestro Bernard de Jussieu alla creazione del giardino botanico del Trianon, con le piante disposte in famiglie naturali e incomincia a lavorare a un proprio metodo di classificazione, che esporrà nella sua opera maggiore, Familles naturelles des Plantes (1763). Quando essa uscì, Adanson viveva ancora a casa dei Jussieu ed è impossibile che la frequentazione quotidiana e il lavoro comune non abbiano influito sul suo pensiero; eppure, Adanson cercò di minimizzare il debito con il suo maestro. A suo dire, aveva concepito il progetto di una classificazione naturale fin da ragazzo al Jardin du Roy e la spinta decisiva era venuta dal viaggio in Senegal, con la sua natura tanto diversa da quella europea; quanto a Bernard, lo descriveva come un linneano ortodosso, incapace di allontanarsi dal fallace sistema di Linneo. Di parere opposto sarà Antoine-Laurent de Jussieu, secondo il quale il metodo di Adanson era un plagio delle elaborazioni di suo zio, il solo vero inventore della classificazione naturale. Come avviene quasi sempre, anche in questo caso la verità starà nel mezzo: Bernard aveva cominciato a lavorare a una classificazione naturale e a insegnarla ai suoi allievi quando il giovanissimo Michel seguiva le sue lezioni al Jardin du Roy e sicuramente alla fine degli anni cinquanta era giunto a definire un proprio sistema (non sappiamo quanto coincidente con quello esposto da Antoine-Laurent in Genera Plantarum); d'altra parte, la ricerca di Adanson, se fu stimolata da quella di Bernard de Jussieu, dovette poi seguire un proprio percorso e un proprio metodo.  Terzo atto: manie classificatorie Il primo volume di Familles naturelles des Plantes si apre con un'ampissima disamina di tutti i sistemi di classificazione proposti in precedenza, tutti quanti considerati incapaci di rendere conto del vero ordine della natura. Per giungere a individuarlo, lo studioso non deve concentrasi su uno o pochi elementi, scelti in modo più o meno arbitrario, ma deve analizzare tutte le caratteristiche possibili, senza stabilire una gerarchia: "Non c'è dubbio che in botanica c'è un solo metodo naturale, ed è quello che considera tutte le parti, qualità, proprietà e facoltà delle piante". Adanson individua quindi 595 categorie di caratteri che raggruppa in 66 sistemi "artificiali", fondati ciascuno su un gruppo di caratteri omogenei (ad esempio, caratteristiche delle foglie, delle radici, delle corolle, ecc.); inserendo tutte le piante note in ciascun sistema, è possibile individuare la loro maggiore o minore affinità. Le piante che, in tutti i sistemi, ricadono nella stessa classe, hanno un alto grado di affinità; quelle che si ritrovano insieme solo in alcune classi sono meno prossime; quelle poi che in tutti i sistemi stanno in classi diverse non hanno alcuna affinità. Come si vede, è un metodo altamente complesso che implica un enorme numero di comparazioni, che difficilmente Adanson avrà utilizzato davvero per classificare nel secondo volume ben 1615 generi, assegnati a 58 famiglie naturali (52 delle quali sono piante da fiore), in un'epoca in cui i computer e il calcolo combinatorio erano al di là da venire. Anche lui, non diversamente da Bernard de Jussieu, avrà condotto le sue comparazioni "par tatonnement", per usare le parole di Augustin de Candolle. In ogni caso, il risultato è imponente; il concetto di "famiglia" entra ormai nella storia della botanica e molte delle sue famiglie sono riconosciute ancora oggi, spesso proprio con i nomi che lui stesso diede loro. Fu infatti Adanson a introdurre la convenzione di nominare le famiglie sulla base di un genere tipico, anche se non usava ancora il suffisso che oggi le contraddistingue: ad esempio, Papavera (oggi Papaveraceae), Ranunculi (oggi Ranunculaceae), Cisti (oggi Cistaceae), Solana (oggi Solanaceae). Nel Congresso internazionale di botanica del 1987, Familles naturelle des plantes fu addirittura scelto come punto di partenza per i nomi delle famiglie (attualmente, tuttavia, non lo è più: dal 2003 è sostituito da Genera plantarum di Jusseu). Di Linneo, Adanson rifiutò anche la nomenclatura binomiale, vista a sua volta come un'imposizione. A suo parere i nomi delle piante dovrebbero cambiare il meno possibile e non dovrebbero essere motivati: bisognerebbe evitare sia i nomi figurati sia i termini che rimandano a una qualche etimologia. I nomi migliori sono quelli che esistono già, quindi in primo luogo quelli indigeni. Coerentemente, gli spiacque persino che Linneo avesse dato il suo nome al baobab. Insieme alla personalissima grafia fonetica che Adanson volle adottare per la sua opera (ad esempio scrive Botanik anziché Botanique), anche questa scelta contribuì all'insuccesso dell'opera che la comunità scientifica apprezzò per l'erudizione, ma non per il metodo; fu ovviamente avversata dai linneani; quanto a Linneo, il suo commento fu che non aveva mai visto un simile ammasso di sciocchezze. Da parte sua, Adanson stava già pensando a un nuovo progetto, ancora più ambizioso. Il metodo induttivo e combinatorio da lui scoperto non era forse universale, applicabile all'intero mondo naturale, anzi ad ogni sapere umano? Ci lavorò almeno una dozzina di anni, e nel 1774 (l'anno prima aveva finalmente ottenuto il sospirato titolo accademico, come botanico aggiunto dell'Accademia delle scienze) presentò all'Accademia stessa lo schema del suo L'Ordre universel de la Nature. La commissione incaricata di analizzare la proposta, sgomenta, si trovò di fronte 27 volumi manoscritti dedicati alle relazioni tra tutte le entità; 150 volumi manoscritti con la descrizione di 40.000 specie in ordine alfabetico; un vocabolario di 200.000 parole; 40.000 illustrazione; 24.168 esemplari; in più, note e osservazioni. I commissari gli consigliarono di espungere tutta la parte compilatoria, limitandosi ai suoi contributi originali, da presentare in una serie di memorie separate. Adanson rifiutò, ostinandosi fino alla fine della vita nel suo folle progetto. Il rifiuto lo amareggiò, e lo spinse a chiudersi in se stesso, a sacrificare tutto alla sua "enciclopedia". Non aveva più né amici né allievi, e neppure una famiglia. Nel 1784 lasciò addirittura la moglie, da cui aveva avuto una bambina (Aglaé Adanson, a sua volta botanica), perché la sua presenza lo distraeva dal lavoro. Divenne un eremita; si ritirò in periferia, in una casa sempre più ingombra di collezioni e manoscritti, dove lavorava accanitamente sedici, diciotto ore al giorno; unica pausa dallo studio e dalla scrittura, il piccolo giardino dove sperimentava incroci e coltivava alberi di gelso. Già in condizioni economiche precarie, fu totalmente rovinato dalla Rivoluzione, che soppresse le pensioni reali di cui godeva. Perse anche l'amatissimo giardino e fu ridotto a vivere in condizioni di miseria estrema. Nel 1798, invitato a prendere parte alle sedute dell'Institut national (la nuova denominazione "rivoluzionaria" dell'Accademia delle scienze), rifiutò, dicendo che gli era impossibile andarci perché non aveva neppure un paio di scarpe. Se non altro, il ministro dell'interno provò vergogna e gli assegnò una pensione, poi raddoppiata da Napoleone. Nel testamento, espresse un solo desiderio: che la sua bara fosse ornata da una ghirlanda formata dai fiori delle sue 58 famiglie. Una sintesi di questa vita tutta occupata dallo studio e da progetti sempre più giganteschi e più impossibili nella sezione biografia. 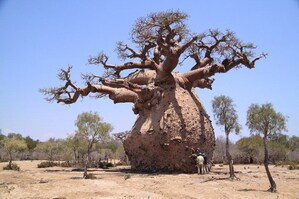 Boabab, giganti minacciati Tra le scoperte di Adanson in Senegal, sicuramente quella che destò maggiore interesse fu proprio l'albero gigante che tanto aveva ammirato. Poco dopo il suo ritorno, nel 1757, egli lesse all'Accademia delle scienze una memoria in cui lo descriveva e ne ricostruiva la storia. Prima di allora, nessun europeo l'aveva mai visto, anche se se ne conoscevano i frutti, che venivano venduti nei mercati egiziani, dove li vide Alpini. Jussieu ritenne che sarebbe stato un doveroso omaggio dedicare allo scopritore il nuovo genere e si affrettò a scrivere in proposito a Linneo. Il tempo dell'inimicizia e delle polemiche era ancora lontano, e lo svedese lo accontentò volentieri, ufficializzando la denominazione nella decima edizione di Systema naturae (1759). Così, con dispetto del dedicatario, il baobab (parola di origine araba che significa "padre di molti semi"), divenne Adansonia digitata. E' la più nota delle otto-nove specie del genere Adansonia, della famiglia Malvaceae (precedentemente Bombacaceae). Uno dei suoi esemplari, il baobab di Glencoe, un albero monumentale della provincia di Limpopo in Sud Africa, era considerato l'essere vivente più grande del mondo, con una circonferenza di 47 metri e un diametro di 15,9. Purtroppo nel novembre del 2009 si è spaccato in due parti e il primato è passato al baobab di Sunland, sempre in Sud Africa, con una circonferenza di 34 metri. Nativi di aree stagionalmente aride, i baobab africani sono in grado di immagazzinare nel tronco enormi quantità di acqua (fino a 120.000 litri); inoltre nella stagione secca, riducono la dispersione lasciando cadere le foglie. Tuttavia, oggi in varie zone dell'Africa sono in grande pericolo: a partire dall'inizio del secolo, proprio gli esemplari maggiori, che vantano un'età tra 1000 e 2500 anni, hanno incominciato a collassare e a morire uno dopo l'altro. Secondo gli studiosi, è una conseguenza del cambiamento climatico, in particolare della combinazione tra siccità e innalzamento della temperatura: gli alberi si disidratano e non riescono più alimentare i loro enormi tronchi. E non possiamo neanche sperare in un Napoleone che sollevi questi giganti dalla loro miseria. Ma non c'è solo A. digitata. Il Madagascar ospita ben sei specie endemiche, tra cui A. grosdidieri, considerata la più bella per il tronco slanciato. Vive invece in Australia A. gregorii, non meno affascinate delle cugine africane. Qualche approfondimento nella scheda. Di origini italiane, ma nato in Francia e naturalizzato belga, Henri Guillaume Galeotti tra il 1835 e il 1840 fu protagonista di una importante spedizione in Messico, in cui unì le sue due competenze: quella di geologo e quella di botanico. Visitando regioni all'epoca in larga parte inesplorate, spesso di difficile accesso, come gli altopiani e le montagne del Messico centrale, fece imponenti raccolte, facendo conoscere alla scienza numerose nuove specie, in particolare orchidee e cactacee, le sue piante preferite. Al suo ritorno in Belgio, aprì un vivaio dedicato proprio a loro, ma non fu molto fortunato. Lo fu invece nella sua gestione dell'Orto botanico di Bruxelles, nota come "era Galeotti". Lo ricordano due generi di orchidee, ovviamente di casa in Messico: Galeottia e Galeottiella. 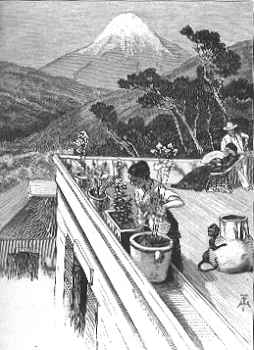 Un grande e instancabile raccoglitore Nato a Parigi da genitori italiani, ma arrivato in Belgio nella prima infanzia, Henri Guillaume Galeotti era un vero figlio d'Europa. Subito dopo l'indipendenza del Belgio, nel 1830, fu uno dei primi allievi dell'Etablissement Géographique, la straordinaria istituzione privata creata dal cartografo Philippe Vandermaelen. Si trattava molto di più di uno stabilimento industriale dove si stampavano carte, atlanti e dizionari geografici; Vandermelen sognava di farne un centro scientifico e didattico dove sarebbero confluite le conoscenze geografiche di tutto il mondo. Lo dotò di una ricchissima biblioteca, di collezioni naturalistiche e etnografiche, di un medagliere e di vari laboratori, compreso un laboratorio di anatomia comparata. In modo più o meno formalizzato, vi si tenevano lezioni gratuite, destinate a ragazzi tra 14 e 18 anni; in tal modo, vi si formò un'intera leva di giovani tecnici e scienziati di modeste origini familiari, che altrimenti non avrebbero avuto accesso agli studi. Grazie alla passione per le piante del fratello Jean-François Vandermaelen, lo stabilimento divenne anche un importante centro di studi botanici, con un erbario, un giardino con piante esotiche, due serre, una scuola di botanica dove due volte alla settimana Michel Scheidweiler insegnava botanica e fisiologia vegetale. Galeotti approfittò fino in fondo di questo ambiente così ricco di stimoli: si appassionò di scienze naturali, divenne un abile disegnatore e si specializzò in geologia; nel 1835, poco più che ventenne, si laureò con una tesi sulla struttura geologica e paleontologica del Brabante, che fu premiata e pubblicata dall'Accademia reale del Belgio. Ma quando venne a sapere del premio, era già in viaggio per il Messico. I fratelli Vandermaelen infatti, per accrescere le collezioni geologiche, naturalistiche e botaniche dell'Etablissement, organizzarono e finanziarono diverse spedizioni di ricerca. Nel 1832, inviarono in Brasile due giovani formatosi alle scuola dello stabilimento: Gédéon Crabbe che. oltre a seguire le lezioni di scienze naturali e disegno, vi prestava servizio come aiuto giardiniere, e Achilles Deyrolle, figlio del tassidermista del Museo di Bruxelles, allievo delle classi di zoologia. I due tra il 1832 e il 1834 esplorarono per sedici mesi la provincia di Rio e ritornarono in patria con notevoli collezioni; c'erano anche piante vive, tra cui un'orchidea che in onore dei loro protettori battezzarono Maelenia paradoxa (oggi sinonimo di Cattleya forbesii). Nel 1837 fu la volta dei fratelli Jean-Baptiste e Honoré Lacourt, inviati in Australia. Ma la più importante spedizione naturalistica sponsorizzata dai fratelli Vandermaelen fu proprio quella di Galeotti in Messico. Imbarcatosi ad Amburgo, egli sbarcò a Veracruz alla fine del 1835, iniziando immediatamente le ricerche geologiche e botaniche. I primi mesi furono dedicati all'esplorazione dello stato di Veracruz, in particolare attorno a Xalapa e alla colonia tedesca di El Mirador. Nei tre anni successivi egli esplorò estesamente gli altopiani interni; nell'estate del 1836 fece raccolte a Real del Monte insieme al tedesco Carl August Ehrenberg. Non gli facevano paura neppure i grandi vulcani: fu il primo botanico a scalare il Cofre del Perote; nel 1837, esplorò le pendici del Popocatepl, raccogliendo esemplari fino al limite delle nevi; nell'agosto 1838 scalò il Pico de Orizaba insieme a Funck, Ghiesbreght e Linden. Dal loro campo base, situato in una caverna a circa 3300 metri d'altezza, raccolse tra 400 e 500 piante di alta quota. L'ultimo anno, si spostò a sud, da Puebla a Oroxaca, dove raccolse le collezioni botaniche più importanti. Lasciò il Messico nel giugno 1840 e ritornò in Belgio via Cuba, dove raccolse ancora qualche pianta. 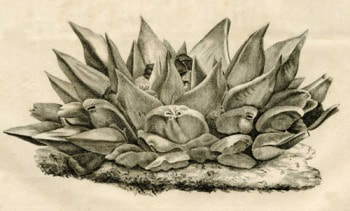 Un vivaio senza fortuna e un orto botanico ben gestito Senza trascurare il lavoro geologico, anch'esso di primaria importanza, Galeotti si rivelò un grande raccoglitore di piante, con all'attivo circa 8000 esemplari di 931 specie diverse. Importanti furono soprattutto le sue collezioni di orchidee e di cactacee. Tra le piante vive che spedì a Bruxelles, la maggioranza appartenevano a quest'ultima famiglia; tra di esse alcune rarità come Ariocactus retusus, raccolto in altura nel deserto di Chihuahua; Astrophytum myriostigma, con l'insolita forma a stella che lo fa assomigliare alla berretta di un vescovo; il variabile e difficile Echinocactus horizontalonius. Anche il suo contributo alla conoscenza delle orchidee messicane è assai rilevante; tra le specie da lui raccolte per la prima volta Barkeria melanocaulon, Bletia adenocarpa, Cyclopogon luteo-albus, C. saccatus, Epidendrum galeottianum, E. longipetalum, E. propinquum, Masdevallia galeottiana, Pleurothallis violacea, Prosthechea chondylobulbon, Schiedeella violacea. Al suo ritorno in Belgio, gli fu offerta una cattedra all'Università di Bruxelles, ma egli rifiutò, preferendo aprire un proprio vivaio presso Lovanio, dove intendeva importare e coltivare piante rare, in particolare le amate cactacee. Contemporaneamente, scrisse diverse memorie di argomento geologico e botanico per l'Accademia delle Scienze; pubblicò alcune specie insieme al suo maestro Scheidweiler, ma per lo più affidò la pubblicazione delle raccolte botaniche ad alcuni importanti specialisti: per le cactacee Charles Antoine Lemaire; per le orchidee Achille Richard (che avvalendosi dei suoi quaderni di campo pubblicò Monographie des orchidées mexicaines (1844); Trunius per le Poaceae; Martens per le felci. Con quest'ultimo nel 1842 pubblicò l'importante Memoire sur les Fougères du Mexique, et considérations sur la géographie botanique de cette contrée e collaborò a lavori sulle Gesneriaceae e le Solanaceae messicane. Intanto aveva preso la cittadinanza belga; intorno al 1850, colpita dalla crisi economica seguita agli eventi del 1848, la sua impresa fallì e fu costretto a cercare altre fonti di reddito. Dal 1852 divenne curatore del Journal d'Horticulture Pratique e nel 1853 accettò l'incarico di direttore dell'Orto botanico di Bruxelles. I cinque anni in cui diresse il giardino sono passati alla storia come "era Galeotti". Egli mise a frutto la sua esperienza di raccoglitore e la sua ampia rete di corrispondenti per incrementare gli scambi con altri orti botanici e acquisire collezioni di essiccata e piante vive; furono anche assunti altri giardinieri e accresciuta la biblioteca. Purtroppo, questa specie di età dell'oro durò poco: da tempo malato, Galeotti morì di tubercolosi a soli 44 anni. L'orto botanico di Bruxelles riuscì ad aggiudicarsi l'erbario, venduto dalla vedova.  La splendida Galeottia e la minuscola Galeottiella Oltre a diversi nomi specifici, come Senecio galeottii o Phyllantus galeottianus, il ricordo di Galeotti è affidato a due generi di orchidee, Galeottia e Galeottiella. Galeottia gli fu dedicato nel 1845 da Richard, sulla base di G. grandiflora, una bella specie raccolta dal dedicatario in Messico. Questo piccolo genere di una dozzina di orchidee epifite o terrestri è diffuso nelle foreste umide di bassa quota tra Messico e Sud America settentrionale. Affini a Zygopetalum, di medie dimensioni, portano fiori molto belli, con labello fimbriato, petali e sepali molti allungati con apici acuti, quasi a stella, rigati o macchiettati, il cui aspetto evoca qualche fantastico insetto tropicale. Per attirare i loro impollinatori, emanano un profumo complesso, greve, quasi intossicante. Si fanno notare molto meno le due specie del genere Galeottiella, creato da Schlechter nel 1920 separando da Spiranthes una specie raccolta da Galeotti in Messico. Con questa dedica, il botanico tedesco volle ricordare il grande contributo di Galeotti alla conoscenza delle orchidee messicane, aggiungendo un secondo genere a quello istituito da Richard. Si tratta di minute orchidee terrestri originarie delle praterie di alta quota del Messico e del Guatemala, con spighe di piccoli fiori tubolari caratterizzati dai sepali laterali con gli apici rivolti indietro, e petali e sepalo superiore quasi fusi a cappuccio. Nella stagione arida vanno in riposo, per spuntare e fiorire in quella delle piogge. Un sottile filo rosso lega la passione ottocentesca per le orchidee e la rivoluzione industriale: i progressi nella navigazione marittima accorciano le distanze, rendendo più accessibili i paesi esotici; le spedizioni dei cacciatori di piante si moltiplicano, finanziate non più solo dagli Stati e dalle istituzioni scientifiche, ma da cordate di affaristi e da grandi aziende vivaistiche, in spietata concorrenza; il collezionismo di piante esotiche diviene uno status symbol che investe nuove figure come banchieri, magnati del commercio e dell'industria, desiderosi di affermazione sociale. Ma soprattutto, l'incremento della produzione di acciaio e ghisa rende possibile la costruzione delle grandi serre ventilate indispensabili per coltivare le orchidee con successo. E non a caso, dopo le rivoluzioni del 1830-31, la mania per le orchidee, nata in Inghilterra intorno al 1818, attraversa la Manica e dilaga prima in Belgio, poi in Francia. Facciamo dunque anche noi tappa in Belgio per incontrare l'uomo che per primo, studiando le orchidee tropicali in natura, ne comprese le esigenze e gettò le basi per la loro coltivazione industriale: Jean Linden. Insieme a lui conosceremo i suoi collaboratori Nicolas Funck e Louis Joseph Schlim, che, a differenza del loro principale, sono onorati da due generi validi; di Orchidacee, ovviamente! 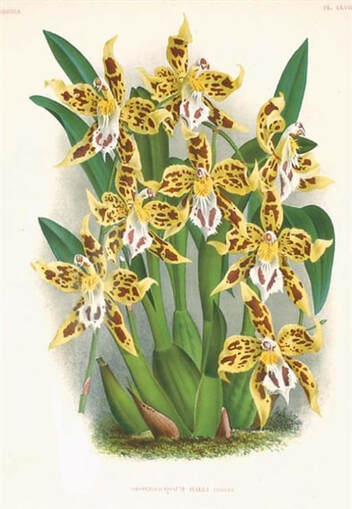 Linden, da cacciatore di piante a creatore di un impero commerciale Ottenuta l'indipendenza dai Paesi Bassi nel 1831, il neonato regno del Belgio affrontò una difficile congiuntura economica: nell'immediato, la perdita del mercato olandese si tradusse in una catastrofe per l'industria tessile e per il traffico marittimo con le colonie. Tra i settori più colpiti, anche quello florvivaistico, che, oltre ad essere danneggiato dal generale clima di crisi, venne escluso dal flusso di piante esotiche provenienti dalle colonie olandesi. Tuttavia, l'ambiente orticolo belga era vivacissimo e pronto a reagire trasformando le difficoltà in opportunità, sostenuto da una legislazione ultra-liberale che favoriva in ogni modo lo spirito imprenditoriale. A ridosso dell'indipendenza, nel 1828, un gruppo di borghesi appassionati di orticoltura aveva fondato la Société royale d'horticulture des Pays-Bas (dal 1837 Société royale d'horticulture de Belgique), una società per azioni privata con l'obiettivo di creare un orto botanico a Bruxelles, inaugurato nel settembre 1829 insieme alla prima esposizione orticola. Fu proprio la Societé royale a chiedere al governo ad aggregare una missione scientifica alla legazione commerciale inviata in Brasile nel 1835. Due gli scopi principali; da una parte, aprire possibili mercati, dall'altra cercare nuove fonti di approvvigionamento di piante esotiche, ora che erano venuti meno quelle garantiti dai Paesi Bassi. Nacque così la prima spedizione scientifica ufficiale della storia del Belgio, cofinanziata dallo stato e dalla Societé royale. Per la missione vennero scelti tre giovanissimi: il diciottenne di origini lussemburghesi Jean Jules Linden (1817-1898) come botanico, il conterraneo Nicolas Funck (1816-1896) come disegnatore e Auguste Ghiesbreght (1810-1893) come zoologo. A Rio de Janiero, i tre furono accolti dal console del Belgio Adolphe Tieberghien e dal pittore Benjamin Mary, che li accompagnarono nell'esplorazione degli stati di Rio, Spirito Santo e Minas Gerais; poi i tre giovani naturalisti proseguirono da soli a cavallo, estendendo le ricerche agli stati di São Paulo e Santa Catarina. I risultati furono eccezionali: casse e casse di materiali naturalistici che furono divisi tra le università di Gand e di Liegi, e ben cinquemila piante vive. Tra di esse, diverse specie di quelle che erano ormai diventate la passione, e l'ossessione, di Linden: le orchidee. Al loro rientro in Belgio, Linden e i suoi compagni furono accolti trionfalmente e ricevuti dal re in persona. La loro missione del resto non era che la punta di diamante di una sorprendente sequela di spedizioni botaniche in America latina made in Belgium: Achilles Deyrolle e Gidéon Crabbe in Brasile tra 1832 e 1834, Henri Galeotti in Messico tra 1835 e 1840, Louis van Houtte in Brasile tra 1834 e 1836. Ma torniamo a Linden e compagni, che appena assaporato il successo erano di nuovo in partenza per una seconda missione ufficiale: via l'Avana, furono inviati in Messico, con il duplice incarico di raccogliere esemplari scientifici per le istituzioni nazionali e informazioni sulle potenzialità economiche del mercato messicano. In Messico i tre incontrarono Galeotti, con il quale nell'agosto 1838 scalarono il maggiore vulcano del paese, il Pico de Orizaba. Le loro ricerche proseguirono poi soprattutto in Tabasco e Chapas. Benché funestata dalla scarsità di fondi, da una grave malattia di Linden, dalla situazione di guerra e dalla perdita di molte piante durante il viaggio in mare, la spedizione in Messico permise al botanico lussemburghese di studiare in natura le condizioni di crescita delle orchidee, comprendendo per primo che molte sono piante di montagna, provenienti da ambienti con grandi escursioni termiche e enormi variazioni stagionali della piovosità. Nel settembre 1840 Linden e Funck tornarono in Europa, mentre Ghiesbreght, che si era ormai trasformato in un raccoglitore professionista, rimase in Messico, dove continuò le sue ricerche da solo. Infine si stabilì a San Cristobal, in Chapas, dove creò un bell'orto botanico e continuò a raccogliere insetti, molluschi, orchidee, cactacee, agavi e bromeliacee. Ha lasciato il suo nome a diverse specie messicane, tra cui Agave ghiesbreghtii, I risultati scientifici della seconda spedizione Linden furono importanti, ma le prospettive economiche delusero il governo belga, che esitava a finanziare una terza spedizione; si decise a contribuire solo dopo che Linden a Parigi ebbe trovato altri finanziatori, in particolare una cordata di vivaisti statunitensi, che lo assunse come cacciatore di piante. Poté così ripartire alla volta di Venezuela e Colombia, accompagnato sempre da Funck e dal fratellastro Joseph Schlim; durante questa spedizione scoprì diverse nuove specie di orchidee, tra cui Anguloa x ruckeri. A. clowesii e Uropedium lindenii (oggi Phragmipedium lindenii). La missione si prolungò fino al 1844, quando gli esploratori tornarono in patria via Giamaica, Cuba, Messico e Stati Uniti. Al suo ritorno in Europa, Linden comunicò le sue scoperte a Lindley, che le pubblicò in Orchidaceae lindenianae. Ma il botanico lussemburghese aveva ormai deciso di abbandonare la vita di cacciatore di piante per trasformarsi in vivaista, anzi in "industriale delle orchidee". Nel 1846, grazie al finanziamento di una cordata di banchieri e industriali, in società con Funck fondò a Limperstsberg, un sobborgo di Lussemburgo, l'Etablissement d'Introduction des Plantes, il suo primo vivaio, specializzato nell'importazione e nella coltivazione di piante esotiche, prime fra tutte le orchidee. La sua idea vincente fu coltivarle in tre tipi diversi di serre (calda, temperata, fredda), rispettando le diverse esigenze di ciascuna specie. Nel 1853 l'azienda fu trasferita a Bruxelles e nell'arco di pochi anni diventò un vero e proprio impero commerciale, con filiali a Gand (1869), Parigi (1879), Costa azzurra (1888), secondo solo a quello di Sander per giro d'affari. Mentre Linden si muoveva tra Belgio e Francia per incrementare il suo successo commerciale, a viaggiare e a cercare nuove orchidee da immettere nel mercato erano ora i cacciatori di piante al suo servizio: tra il 1841 e il 1865, a inviargli piante sono almeno nove raccoglitori: Funck (Colombia e Venezuela), Ghiesbreght (Messico), Schlim (Colombia, Venezuela, Centro America), Libon (Brasile), Warscewicz (America centrale), Porte (Brasile, Filippine), Wagener (Venezuela, Colombia), Triana (Colombia), Braam (Colombia). Sapienza di conoscitore delle orchidee e spirito imprenditoriale si uniscono anche nelle due maggiori iniziative editoriali di Linden, allo stesso tempo monografie scientifiche, opere d'arte e vetrine commerciali, pensate per presentare al mondo le "sue" orchidee: Pescatorea (1854), finanziata da Jean-Pierre Pescatore e interrotta dalla sua morte precoce; e soprattutto la rivista Lindenia. Iconographies des orchidées, pubblicata in due serie, la prima in dieci volumi tra 1885 e 1894, la seconda, curata dal figlio Lucien, in sette volumi tra 1885 e 1901. Sono opere raffinatissime in grande formato, che presentano la descrizione di più di 800 tra specie e ibridi di orchidee, accompagnate da illustrazioni di grande pregio artistico. Linden (che nella sua vita ricevette onori di ogni tipo, dal titolo di commendatore dell'ordine di Leopoldo a quello di console onorario del Lussemburgo e console di Colombia a Bruxelles), per non parlare delle dozzine di medaglie collezionate dalle sue piante nelle esposizioni internazionali, fu invece relativamente sfortunato nella tassonomia botanica. Certo, sono decine le specie esotiche introdotte dai suoi stabilimenti che lo ricordano nel nome specifico, da Caladium lindenii a Dianthera lindeniana; tra le orchidee, citiamo almeno Phalaeonopsis lindenii, Dendrophylax lindenii e Broughtonia lindenii. Tuttavia oggi non è valido nessuno dei ben quattro generi che gli furono dedicati: Lindenia M. Martens & Galotti (sinonimo di Cyphomeris Standl.), Lindenia Benth. (sinonimo di Augusta Pohl), Neolindenia Baill. (sinonimo di Louteridium S. Watson). Lindeniopiper Trel. (sinonimo di Piper L.). Dunque, il nostro Linden è a tutti gli effetti un botanico senza Nobel. Se volete sapere qualcosa di più su questo eccezionale personaggio, non vi resta che navigare in questo sito.  Orchidee e parenti intellettuali: Funck e Funkiella Tuttavia, a tenere alto l'onore della famiglia (e a permettermi di forzare le regole del blog facendone il protagonista di questo post) ci sono le dediche di due generi validi a suoi principali collaboratori, e parenti: il compagno d'avventure, socio e cognato Nicolas Funck e il fratellastro Louis Joseph Schlim. Proviamo a conoscerli meglio. Di un anno più anziano di Linden, anche Funck era lussemburghese e si era spostato a Bruxelles, dove studiava architettura. Fu in qualità di disegnatore che accompagnò Linden nelle tre spedizioni in Centro e Sud America. Tra i due, conterranei e quasi coetanei, nacque una grande amicizia, che si strinse ancora di più quando divennero cognati. Tra 1845 e 1846, egli partecipò a una seconda spedizione in Colombia e Venezuela assieme a Schlim. Per prepararsi al viaggio, andò a Parigi per conoscere Humboldt, con cui da allora rimase in contatto. Le sue raccolte in Sud America sono importanti, ma andarono in buona parte perdute in un naufragio. Al suo ritorno in Europa, Funck intraprese la carriera accademica e fu attivo in molte società scientifiche: dal 1848 fu professore di scienze naturali e geografia all'Università di Lussemburgo; nel 1850 fu tra i fondatori della Société des sciences naturelles del Granducato del Lussemburgo, del cui gabinetto di botanica e zoologia fu nominato conservatore. Nel 1857 tornò in Belgio come direttore aggiunto de Jardin royal zoologique et botaniques di Bruxelles, di cui nel 1861 divenne direttore. Dal 1870 al 1886, diresse lo zoo di Colonia. Dopo il pensionamento, trascorse gli ultimi anni nella città natale. Fu prolifico autore di articoli scientifici soprattutto di botanica, pubblicati in diverse riviste belghe e lussemburghesi, e dal 1858 al 1862, curatore del mensile Journal d'horticulture pratique de la Belgique. Durante il periodo tedesco, pubblicò numerosi articoli divulgativi di zoologia. Comparvero invece postume le sue interessanti memorie di viaggio. Dotato di buone capacità di divulgatore e servito da una prosa limpida, si segnala anche per lo spirito di osservazione e l'apertura mentale. Molti anni dopo la sua morte, nel 1920, F.R.R. Schlechter volle ricordare il suo contributo alla botanica dedicandogli un'orchidea da lui raccolta durante il viaggio messicano, Funkiella hyemalis (precedentemente Spyrantes hyemalis A. Rich. & Galeotti). Oggi al genere Funkiella sono attribuite sette specie, distribuite tra Messico e America centrale. Sono orchidee terrestri, erbacee, di medie dimensioni, con infiorescenze di pochi fiori, in genere bianchi, talvolta con labello rosso. La specie più nota è proprio F. hyemalis, un'orchidea terrestre di alta quota, che si spinge fino 4000 metri sul livello del mare.  Orchidee e parenti poveri: Schlim e Schlimia In confronto a Funck (per non parlare di Linden) ben poche notizie sono reperibili su Louis Joseph Schlim; nato dal secondo matrimonio della madre di Linden, aveva appena due anni meno del fratellastro. Non sappiamo molto della sua formazione né della sua vita prima del 1841; forse era orologiaio. Tra il 1841 e il 1844, come abbiamo già visto, partecipò alla spedizione di Linden in Venezuela e in Colombia, ricevendo dal fratellastro una retribuzione per la sua attività di raccoglitore. Nel 1845 tornò in Venezuela con Funck. Come riconoscimento del suo contributo alla conoscenza del territorio nazionale, il governo del paese latino americano aveva nel frattempo donato a Linden la tenuta El Tocuyo, che divenne le base di Funck e Schlim, incaricati di procurarsi nuove specie per l'Etablissement d'Introduction des Plantes. Dopo il rientro di Funck, non conosciamo con precisione i movimenti di Schlim. Dalle etichette degli esemplari d'erbario, si deduce che rimase in America almeno fino al 1852, visitando America centrale, Venezuela e Colombia. Nel 1851 visitò il municipio di Ocaña con Jeronimo Triana. Non sappiamo praticamente nulla della sua vita negli anni successivi, tranne che assunse la cittadinanza belga, per poi trasferirsi a Parigi dove forse esercitò la professione di orologiaio e morì in ancora giovane età. Nel 1852 Jules Emile Planchon, che stava scrivendo una monografia sulla flora colombiana basata sulle scoperte di Linden e dei suoi raccoglitori, in collaborazione con lo stesso Linden gli dedicò Schlimia, un piccolo genere di orchidee, nativo della Costa Rica e del Sud America settentrionale. Oggi gli sono assegnate sei specie. Sono epifite, occasionalmente terrestri, delle foreste umide fredde andine, con centro di diversità in Ecuador. Vive invece tra Costa Rica e Colombia la specie tipo, S. jasminodora. Sono piante compatte, con graziosi fiori bianchi di consistenza cerosa, raccolti in infiorescenze pendule; i sepali laterali formano una specie di elmetto, da cui protrudono i petali, il sepalo dorsale e la colonna aranciata. Molto rare in natura, sono talvolta coltivate dagli appassionati di orchidee miniatura. In Sud America, tra Perù e Ecuador, c'era un tesoro vero e molto ambito: quello delle piante di quina, ovvero delle diverse specie di Cinchona la cui corteccia era l'unico rimedio conosciuto per la malaria. Ma fin dal tempo dei Conquistadores si favoleggiava di altri, più mitici tesori, come quello che uno degli ultimi capi Inca avrebbe nascosto tra le montagne dell'Ecuador. Partito dalla Spagna per il Sud America per studiarne i tesori naturali, il farmacista sivigliano Anastasio Guzman finì per farsi sedurre dal miraggio del tesoro perduto degli Inca e da solerte indagatore dei tre regni della natura si trasformò in una specie di sfortunato Indiana Jones. Ma prima aveva fatto tempo ad incrociare i protagonisti della seconda fase della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù nonché Bompland e Humboldt durante il loro soggiorno in Ecuador. Alla fine, conquistò davvero un tesoro: la dedica del genere Guzmania, noto a tutti grazie alla coltivatissima G. lingulata, una delle più comuni e amate piante d'appartamento.  Un naturalista visionario a caccia dei segreti della natura Probabilmente grazie alla testimonianza di Humboldt, diverse fonti qualificano Anastasio Guzmán come "eminente naturalista" o "famoso studioso"; in realtà sappiamo ben poco di questo farmacista andaluso morto in Ecuador nel 1807 mentre era alla ricerca del misterioso tesoro degli Inca. Non ne conosciamo neppure la data e il luogo di nascita. La prima notizia certa su di lui risale al 26 maggio 1794, giorno in cui, come riferisce la Gaceta de Madrid, "Don Anastasio de Guzman, professore di farmacia" fu onorato con il primo premio ai pubblici esami di botanica, alla conclusione del corso istituto dalla Reale società di Medicina di Siviglia. Poiché all'epoca in Spagna non era previsto l'insegnamento universitario della farmacia, probabilmente il titolo "professore di farmacia" significa semplicemente che era un farmacista provvisto della licenza, avendo superato l'apprendistato e l'esame di fronte al Tribunale del Protomedicato. Guzman ci teneva molto a questo titolo, visto che in Sud America si presenterà come "professore pratico di Farmacia, Galenica e Clinica, ricevuto e convalidato a Siviglia, Puerto de Santa Maria, Guayaquil e Quito, cattedratico, licenziato in botanica nella Reale società medica di Siviglia". Da questo pomposo curriculum (che mi ricorda irresistibilmente quello del dottor Dulcamara) deduciamo anche che per qualche tempo dovette esercitare la professione di farmacista a Puerto de Santa Maria, una piccola località nei pressi di Cadice. Non molto tempo dopo il brillante esame di botanica Guzmán deve essere partito per il Sud America per un viaggio di studio a proprie spese, intenzionato a studiare la chimica e le altre scienze della natura. Qualcuno si è chiesto ironicamente come potesse venire in mente in quei tempi di andare in Perù (dove non esistevano né scuole né laboratori) a studiare la chimica; eppure per un farmacista proprio qui c'era un grande oggetto di richiamo le cui proprietà chimiche e farmaceutiche valeva la pena di studiare sul posto: gli alberi di quina, ovvero di diverse specie di Cinchona, dalla cui corteccia si ricavava l'unico medicamento capace di tenere a bada la malaria. Anche le tappe del viaggio sudamericano di Guzmán sono note solo a grandi linee; la prima meta fu Montevideo, quindi Buenos Aires, da cui proseguì per il Cile a piedi, approfittando del viaggio per raccogliere esemplari dei tre regni della natura e dati su ogni genere di soggetto. Lo troviamo poi in Perù. A Lima i suoi passi si incrociarono con quelli di Juan José Tafalla, il capo della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù dopo il ritorno di Ruiz e Pavon in Spagna. Prima di proseguire con le sue avventure, dunque, fermiamoci un attimo anche noi per riannodare i fili della spedizione al punto in cui l'avevamo lasciata in questo post. Come avevamo visto, Madrid si preoccupò di garantire la continuità della spedizione anche quando i botanici spagnoli fossero rientrati in patria; a questo scopo, nel 1785 vi furono aggregati due "apprendisti", scelti su suggerimento del sovrintendente del Perù José Escobiedo tra i militari appena congedati dal reggimento di fanteria Soria, sciolto nel 1784 dopo aver partecipato alla repressione dell'insurrezione di Tupac Amaru. I due erano il navarrino Juan José Tafalla Navascués (1755-1811), appartenente a una famiglia di farmacisti e forse farmacista egli stesso, e Francisco Pulgar, pittore toledano. Nato nel 1755, Tafalla aveva trent'anni, mentre non conosciamo la data di nascita di Pulgar. Dopo essersi fatti le ossa partecipando alle campagne del 1785-1787 con Ruiz e Pavon, nel 1787 i due erano ormai in grado di continuare da soli le ricerche. Congiuntamente alla partenza di Ruiz, un decreto reale nominò Tafalla capo della spedizione e venne istituita per lui una cattedra di botanica presso il Collegio di Chirurgia di San Fernando di Lima. Inizialmente Tafalla e Pulgar lavorarono soprattutto nella zona di Huánuco, approfondendo lo studio degli alberi di quina e delle tecniche della sua estrazione. Nel 1790 accompagnarono in questa regione la spedizione Malaspina. Nel 1793 Tafalla ricevette da Ruiz, divenuto suo superiore come capo dell'Oficina de la Flora peruana y chilensis, precise istruzioni per l'invio di piante vive e essiccate, semi e disegni. Lo stesso anno la spedizione si arricchì di un secondo botanico, Juan Agustín Manzanilla, al momento come volontario senza paga. Tra il 1793 e il 1795 il gruppo erborizzò nelle montagne di Tarma. Tra il 1797 e 1798, si spostò nella provincia di Humalíes e nella valle del Monzón. Fu probabilmente in questo arco di tempo che Guzmán giunse a Lima, dove a quanto sembra visse per un anno; sappiamo che strinse amicizia con Tafalla e che i due erborizzarono insieme; l'interesse comune che li unì, al di là di una generica passione per la botanica, saranno stati proprio gli alberi di Cinchona, il tesoro verde di cui entrambi volevano scoprire i segreti.  Incontri botanici in Ecuador Più ancora del Perù, il vero regno della Cinchona era l'Ecuador. Ed è proprio questa la prossima meta sia di Guzmán sia di Tafalla e compagni. Nel 1799 a Tafalla fu ordinato di organizzare una grande spedizione in Ecuador; a tal fine, il gruppo fu integrato da due nuovi pittori (Pulgar era ormai uscito di scena), Xavier Cortés e il peruviano José Gabriel Rivera. Tra il 1799 e il 1802 i quattro naturalisti esplorarono i dintorni di Guayaquil, studiando soprattutto le piante atte a fornire legname per le costruzioni navali. Probabilmente nello stesso periodo anche Guzmán era Guayaquil, dove lavorava come sovrintendente delle haciendas di Jacinto de Bejarano, un grande proprietario terriero e futuro leader del movimento indipendentista; ma non amava il clima della costa e si trasferì nella sierra e quindi a Quito dove si trovava sicuramente nel 1800 (finalmente una data certa) e, secondo le sue parole, intendeva "esercitare la farmacia e la chimica e proseguire gli studi sui tre regni della natura, animale, vegetale e minerale". Nella città ecuadoregna Guzmán strinse amicizia con un giovane intellettuale, José Mejía Lequerica, che lo ospitò a casa sua in cambio di lezioni di scienze naturali; insieme esplorarono la flora dei dintorni in numerose escursioni botaniche e accumularono osservazioni geografiche, meteorologiche, minerarie, economiche. Guzmán, che era anche un eccellente disegnatore, aveva già messo insieme copiose collezioni, eseguito centinaia di disegni e redatto numerosi manoscritti, tra cui un proprio sistema di classificazione dei tre regni della natura, cui aveva dato il titolo linneano Sistema de la Naturaleza. Nei primi giorni del 1802, provenienti da Bogotà, arrivarono a Quito Bompland e Humboldt; incontrarono Guzmán il quale mostrò i suoi materiali al tedesco, che fu talmente ammirato dalla sua profonda conoscenza della natura da sostenere che nell'altopiano dell'Ecuador aveva trovato un naturalista la cui sapienza superava quella di Linneo. E' alla sua testimonianza che dobbiamo l'elenco delle numerose opere manoscritte redatte da Guzmán. La sua ammirazione è dimostrata anche dalla dedica del bellissimo e raro Ranunculus gusmannii, con queste significative parole: "Lo ha raccolto il nostro grande amico Guzman, farmacista, sul monte Corazon di Quito, proprio al limite delle nevi". Nel 1803 arrivò a Quito anche Francisco de Caldas, inviato da Mutis a studiare la quina; si trattenne nella zona fino al 1805 e divenne amico di Guzmán con il quale fece diverse escursioni; anche lui vide i manoscritti del naturalista andaluso, senza farsene impressionare più di tanto. Quanto a Bompland e Humboldt, dopo sei mesi trascorsi a Quito e nei dintorni, si spostarono a Loja e da qui in Perù; tornati in Ecuador, a Guyaquil incontrarono Tafalla e Manzanilla e erborizzarono con loro tra gennaio e febbraio 1803. Il tedesco confrontò il suo erbario con quello degli spagnoli e nelle sue successive pubblicazioni ne elogiò la padronanza della flora locale. Poi i due visitatori si congedarono dall'Ecuador e dai nuovi amici. Dobbiamo farlo anche noi, raccontando brevemente le loro ulteriori vicende prima di tornare a Guzmán. Tra 1803 e 1804, Tafalla e Manzanilla spostarono le loro ricerche nelle Ande ecuadoregne, in particolare nei dintorni di Cuenca e Loja, il centro riconosciuto del regno della quina. Divisi in due gruppi (Tafalla con Cortés e Manzanilla con Rivera), ne individuarono e descrissero 32 diversi tipi, studiando anche attentamente i metodi di estrazione e sfruttamento. Nel 1808 Tafalla tornò a Lima, incaricato di crearvi un orto botanico. Nel 1809, mentre Manzanilla lo sostituiva come professore supplente, fece una breve spedizione in Cile; morì quindi a Lima nel 1811. Manzanilla, che dal 1804 era diventato secondo botanico, gli succedette come capo della spedizione e professore di botanica al Collegio di chirurgia e fece ancora qualche invio fino al 1815. Poi la sua salute mentale si deteriorò; la spedizione fu dichiarata ufficialmente conclusa e nel 1818 il corso di botanica cessò di esistere. Nell'arco di ventisette anni (dal 1788 al 1815) Tafalla e Manzanilla effettuarono 101 invii di materiali a Madrid, 45 dal Perù e 56 dall'Ecuador, con oltre 750 disegni e migliaia di esemplari. Ruiz e Pavon se ne servirono come propri, e il contributo dei due ricercatori non venne mai riconosciuto. Solo in epoca recente (1989) lo storico Eduardo Estella Aguirre mise in luce l'importanza del lavoro di Tafalla e del suo gruppo, rendendosi conto che avevano più che raddoppiato le specie scoperte da Ruiz e Pavon. Grazie a lui venne anche pubblicato il manoscritto di Tafalla Flora Huayaquilensis (1989-1991); rimasto inedito per quasi duecento anni, costituisce la prima flora dell'Ecuador. 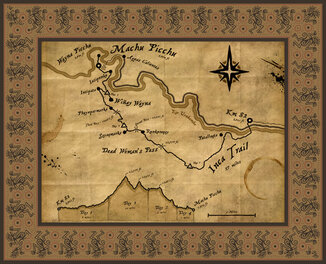 Un tesoro misterioso e maledetto E' ora di tornare a Guzmán, che, inquieto come sempre, aveva lasciato Quito e per breve tempo aveva gestito una farmacia a Latacunga, una città situata sull'altopiano. Qui venne a sapere di un favoloso tesoro nascosto nelle montagne di Llanganates. La storia che gli fu raccontata è, nelle grandi linee, la seguente: nel 1532 l'ultimo imperatore inca, Atahualpa, fu catturato da Pizarro; per riottenere la libertà, promise che come riscatto avrebbe riempito una stanza d'oro. Pizarro finse di accettare il patto, ma poi fece uccidere Atahualpa. Alla notizia della sua esecuzione, il valoroso generale Rumiñahui, che stava portando a Cajamarca ben 750 tonnellate d'oro come riscatto, tornò a Quito e portò il tesoro sui monti Llanganates, dove lo gettò in un lago o lo nascose in una grotta. Una cinquantina di anni dopo, un certo Valverde affermò di essersi arricchito dopo che la famiglia della moglie, una donna inca, lo aveva condotto sul luogo dove era nascosto il tesoro. Prima di morire, lasciò alcune indicazioni per ritrovarlo, il cosiddetto Derrotero de Valverde. Da allora il tesoro non fu mai trovato, e molti di coloro che lo cercarono fecero una brutta fine, compreso il nostro Guzmán. Il farmacista infatti si convinse della fondatezza della leggenda e cercò di ricostruire l'itinerario di Valverde. Durante le ricerche si imbatté in alcune vecchie miniere di rame e argento, e, sempre afflitto da problemi di soldi, pensò che avrebbe potuto arricchirsi in modo immediato e sicuro, riprendendone lo sfruttamento; litigi con i suoi collaboratori e risultati poco redditizi lo convinsero ben presto a desistere. Nel 1806 si spostò nel villaggio di Patate dove visse sotto la protezione del sindaco; qui, basandosi sull'itinerario di Valverde e altre dicerie, disegnò una mappa dei monti Llanganates, totalmente immaginaria visto che non si era mai addentrato nelle profondità di quelle misteriose montagne, sempre avvolte dalla nebbia. Una notte, mentre camminava nella campagna in preda ad un attacco di sonnambulismo, cadde in un burrone perdendo la vita. Nel 1860 la sua mappa fu scoperta dal viaggiatore e cacciatore di piante Richard Spruce che la pubblicò nel Journal of Royal Geographical Society rendendo popolare la leggenda. La maledizione degli Inca colpì anche il lavoro di naturalista di Guzman, perché i suoi manoscritti andarono perduti o dispersi. A ricordare questo naturalista avventuroso e visionario è così rimasto solo un elenco di titoli riportati da Humboldt, la cui portata scientifica non possiamo dunque valutare.  Le coloratissime brattee di Guzmania Messi in secondo piano da Ruiz e Pavon, che li considerarono semplici raccoglitori e si appropriarono senza scrupoli del loro lavoro, Tafalla e Manzanilla sono stati misconosciuti anche dalla terminologia botanica. Non c'è alcun genere a celebrare Manzanilla e i tre pittori della spedizione (di cui uno, Francisco Pulgar, di grandissimo valore); quanto a Tafalla, fu sfortunato anche in questo: nel 1794 Ruiz e Pavon crearono in suo onore il genere Tafalla, che tuttavia non è valido trattandosi di un sinonimo di Hedyosmum. Un secondo Tafalla, creato da Don nel 1831, è invece sinonimo di Loricaria. Il botanico navarrino è ricordato almeno da qualche nome specifico: Condea tafallae, Salvia tafallae, Mikania tafallana. Ad aggiudicarsi, almeno in questo campo, un vero tesoro, alla fine è stato Anastasio Guzman. Su istanza di Tafalla, nel 1802 Ruiz e Pavon gli dedicarono infatti Guzmania, uno dei generi più ampi e importanti della famiglia Bromeliaceae. Anche la loro dedica merita una citazione: "Abbiamo dedicato questo genere al farmacista Anastasio Guzman, industrioso e diligente ricercatore di piante, animali e di ogni altro corpo naturale nelle sue peregrinazioni per l'America". Guzmania comprende circa 120 specie di perenni epifite originarie delle foreste pluviali degli Stati Uniti meridionali, dell'America centrale e delle Antille, del Sudamerica settentrionale e occidentale. Il centro di diversità sono le foreste andine d'altura, con numerose specie anche in Ecuador, così appassionatamente esplorato da Guzman. Proprio nei Llanganates vive ad esempio la rara Guzmania puyeoensis. La specie più nota, una delle più diffuse e vendute piante d'appartamento, è però G. lingulata, originaria di un'area abbastanza vasta che si estende dall'America centrale al Brasile. E' molto apprezzata per la facilità di coltivazione e la prolungata fioritura; i fiori di per sé sono insignificanti, ma sono circondati da vistosissime brattee rosso vivo (ma anche arancio, giallo, rosa in alcune cultivar). Se questa è la Guzmania per eccellenza, non mancano altre specie di grande interesse, come l'enorme G. lindenii con infiorescenze alte più di tre metri, oppure G. sanguinea con le cui foglie si colorano di rosso al momento della fioritura, oppure G. wittmackii con delicate infiorescenze lievemente arcuate . Su queste e altre specie qualche informazione nella scheda. In gioventù, Joseph Dombey fu un uomo amabile, di notevole prestanza fisica e di mente acuta, uno scienziato versatile e un botanico appassionato; ma dalla grande spedizione in Sud America da cui si attendeva sicura gloria (è ironico che tutti la chiamino Spedizione di Ruiz e Pavón e non, come sarebbe giusto, Spedizione di Ruiz, Pavón e Dombey) fu totalmente distrutto nella salute fisica e mentale e nella stessa reputazione. Intorno a lui e alle sue piante scoppiò un caso diplomatico internazionale, l'affare Dombey, che coinvolse tre paesi in un momento storico delicatissimo: la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna. Ne vedremo qui la prima fase, quella di cui fu protagonista diretto. Unica consolazione in una vita infelicissima lo spettacolare genere Dombeya, dedicatogli da uno spagnolo che non si faceva condizionare dal nazionalismo, l'abate Cavanilles. 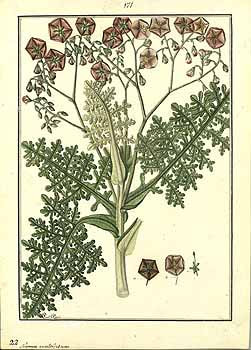 Una spogliazione o il rispetto di un contratto? Come ho raccontato in questo post, mentre i suoi compagni proseguivano le ricerche in Perù, il 14 aprile 1784 Joseph Dombey si imbarcò con le sue collezioni sul Peruano, lo stesso vascello che sei anni prima lo aveva condotto a Callao con Ruiz e Pavón. Portava con sé l'erbario, le descrizioni, le collezioni di conchiglie e minerali, reperti archeologici e etnografici; le raccolte degli spagnoli, molto più copiose delle sue, viaggiavano su una nave più piccola, la San Pedro de Alcantara. Il viaggio fu particolarmente lungo e difficile. Le due navi, partite insieme, ben presto furono costrette a separarsi . Appena superato Capo Horn, il Peruano fu investito dai venti contrari e solo con grande difficoltà riuscì a raggiungere Rio de Janeiro, dove dovette essere riaddobbato. Dombey, malato da tempo, versava in uno stato di grave prostrazione fisica a causa della dissenteria e dello scorbuto. Il soggiorno in Brasile, che si protrasse dall'inizio di agosto alla fine di novembre, gli permise di recuperare in parte la salute e di integrare le sue collezioni, soprattutto con acquisti di pietre preziose, uccelli impagliati e farfalle. E' dunque soltanto il 28 febbraio 1785 che un Dombey esausto e frastornato sbarca finalmente a Cadice; lo accoglie la notizia che, per ordine di Galvez, il Ministro delle Indie, le sue 78 casse verranno poste sotto sequestro in un locale della dogana. Poco dopo si viene a sapere che la San Pedro de Alcantara, per evitare il naufragio, è stata costretta a gettare a mare tutto il carico: le collezioni di Ruiz e Pavón sono perdute. In virtù di una clausola del contratto stipulato con la Spagna nel 1777, Dombey si era impegnato a consegnare metà delle sue collezioni all'orto botanico di Madrid. E' possibile che egli pensasse in tutta sincerità di aver già assolto questo obbligo con gli esemplari scambiati in Perù e in Cile con Ruiz e Pavón; è sicuramente con costernazione che ad aprile apprende che la Spagna intende rispettare alla lettera la clausola, imponendogli di spartire le sue raccolte per reintegrare il carico perduto della San Pedro de Alcantara. Obbedendo alle indicazioni che arrivano da Parigi, Dombey si rassegna, tanto più che, raccoglitore scrupolosissimo, ogni volta che gli è stato possibile ha conservato nel suo erbario dodici esemplari di ciascuna pianta; da Madrid però arriva una seconda richiesta, ancora più dolorosa: si chiede al botanico francese di promettere di non pubblicare nulla fino al ritorno dal Perù di Ruiz e Pavón, sempre sulla base del contratto del 1777. Dombey cerca di resistere, o per lo meno di temporeggiare, in attesa di istruzioni da Parigi; temendo il sequestro dei suoi diari di campo, li affida al capitano di una nave francese in partenza per la Francia. Di una cosa è certo: dietro tutti questi maneggi c'è una persona: Casimiro Gomez Ortega che ha organizzato tutto il complotto per riservare a se stesso (o ai suoi protetti) la gloria della pubblicazione della flora peruviana. Purtroppo per Dombey, per la diplomazia francese una collezione di piante secche o una pubblicazione botanica in più o in meno non valgono una crisi diplomatica: gli ingiungono di accettare tutto, anzi il Jardin des Plantes si impegna a non pubblicare prima degli spagnoli le specie inedite nate nel giardino dai semi inviati da Dombey dal Sud America. E qui l'"affare Dombey" si tinge di giallo. Il povero botanico si sente tradito, abbandonato, vittima di una congiura; sostiene di aver subito un attentato, che una persona che gli assomigliava è stata uccisa davanti alla sua porta. La sua partenza da Cadice, dopo dieci mesi di soggiorno forzato, è quasi una fuga. Imbarcatosi sulla Jeune Henry per le Havre con le 36 casse che gli restano, rientra a Parigi il 13 ottobre 1785.  Un uomo piegato e distrutto, una fine tragica L'uomo che rivede infine la dolce Francia è il fantasma del giovane e promettente botanico che ne era partito nove anni prima. Quel giovanotto dal carattere amabile è oggi un uomo ombroso, sospettoso, afflitto da un (giustificato?) complesso di persecuzione; sparite sono la forza fisica e l'acutezza del pensiero. Ben presto è travolto dalla depressione, tanto che, quando Jussieu gli offre il seggio dell'Accademia delle Scienze lasciato vacante dalla morte di Guettard, rifiuta; poco dopo (siamo all'inizio del 1786) lascia Parigi per cercare sollievo prima a Gex, poi a Lione, infine a Tullins. Nelle lettere che invia agli amici, sfoga il suo umore nero e l'odio per i suoi persecutori veri o presunti, ovvero Ortega e Galvez, Prima di lasciare Parigi, tuttavia, ha consegnato l'erbario e le sue note al Jardin des Plantes; Buffon a sua volta li ha trasmessi a L'Héritier de Brutelle, che l'anno prima ha pubblicato alcune delle "specie proibite" nate dai semi di Dombey al Jardin des Plantes in Stirpes novae; L'Héritier si mette al lavoro e annuncia la pubblicazione di una Flora peruviana. Gli spagnoli la prendono male (tornerò su questa seconda parte dell'affare Dombey in un prossimo post) e il povero Dombey è costretto a giustificarsi con il ministro Calonne, cui giura di non saperne nulla. Si sente sempre più vittima di un complotto, al punto che scrive ad André Thouin (da sempre il suo amico più caro) che è deciso ad abbandonare la Francia per sottrarsi ai suoi persecutori. Ritornato a Lione, in una crisi di disperazione nell'ottobre 1786 brucia tutti i suoi manoscritti. Vanno in fumo nove anni di osservazioni sui minerali, la geografia, la meteorologia, le miniere, il chinino e altri argomenti studiati dal versatile e sfortunato scienziato. Per sei anni vive una vita oscura di provincia. Chi lo visitò in quel periodo, come il botanico Villars, lo descrive come un uomo triste, chiuso, che ha abbandonato la lettura, gli studi, la vita pubblica, disinteressato anche agli eventi politici che scuotono il paese. Unica traccia dell'uomo del passato è il soccorso che come medico continua a prestare agli ammalati più indigenti. Furono forse i terribili eventi di cui fu teatro Lione durante il Terrore a riaccendere in lui il desiderio di partire e, allo stesso tempo, di servire nuovamente la scienza e la sua patria. A offrirgliene l'occasione fu Thomas Jefferson, all'epoca Segretario di Stato degli Stati Uniti. Tra le urgenze del nuovo stato c'era quello di uniformare il sistema dei pesi e delle misure, diverse da un angolo all'altro del paese. L'illuminista Jefferson era favorevole all'adozione del razionale sistema metrico decimale, che era stato da poco introdotto nella Francia rivoluzionaria; si rivolse perciò alla repubblica sorella perché inviasse un esperto. La scelta cadde sul nostro Dombey, che il 24 nevoso (17 gennaio 1794) partì da Le Havre su un brigantino statunitense, portando con sé un peso campione del chilogrammo. Costretto da una tempesta a riparare in Guadalupa, si trovò nel bel mezzo di uno scontro tra sostenitori e avversari della rivoluzione che lo trassero in arresto come inviato ufficiale della repubblica; liberato dai filo rivoluzionari, poté poi reimbarcarsi sul brigantino che lo aveva condotto nell'isola, ma appena la nave uscì dal porto fu catturata da vascelli corsari britannici. Dombey fu fatto prigioniero e condotto nell'isola di Montserrat. Così non giunse mai negli Stati Uniti, con due conseguenze: in quel paese tuttora si usano iarde, miglia, once e libbre, mentre Dombey, spezzato da tante disgrazie, morì in prigionia. Solo sei mesi dopo, nell'ottobre 1794, la notizia della sua morte arrivò a New York e da qui in Francia. Una sintesi della sua vita sfortunata nella sezione biografie.  Dombeya, dal Madagascar con fioriture A consolarci da questa tristissima storia, ci sono per fortuna le splendide piante del genere Dombeya. A dedicarlo al nostro sventuratissimo botanico nel 1786 fu Cavanilles, abbastanza equanime dal non farsi condizionare dalle accuse di tradimento e spergiuro che i suoi conterranei riversavamo sul povero Dombey. Un tempo incluso nella famiglia Sterculiaceae, oggi confluita in Malvaceae, Dombeya nell'attuale delimitazione è uno dei generi più ampi della famiglia, con circa 250 specie di piccoli alberi e arbusti diffusi in Africa, in Madagascar, nella penisola arabica e nelle isola Mascarene. Il centro di diversità è il Madagascar, dove si incontrano oltre 200 specie. Genere molto vasto e morfologicamente vario, cresce in habitat diversi, dal bosco tropicale alla boscaglia d'altitudine. Le foglie alternate e semplici possono essere lobate, cuoriformi, quasi rotonde, glabre o pelose; i fiori a cinque petali, simili a quelli della malva, bianchi, rosati, galli o rossi, sono raccolti in fitte cime o ombrelle pendule. Alcune specie sono coltivate come ornamentali nelle zone a clima mite. La più nota è probabilmente D. wallichii, originaria dell'Africa orientale e del Madagscar, le cui rosee infiorescenze globose le hanno guadagnato il nome improprio ma suggestivo di "ortensia tropicale". Ugualmente spettacolare grazie alle fitte cime di fiori rosa pallido con cuore porpora è la fioritura di B. burgessiae, una specie diffusa in una vasta area che si estende dal Sudan al Sudafrica, . Molto coltivato nei paesi tropicali è D. x cayeuxii, un ibrido orticolo tra le specie precedenti ottenuto dal francese Henri Cayeux nel 1895. La più stupefacente è forse un'altra malgascia, D. cacuminum, con infiorescenze rosso vivo. Qualche approfondimento su queste e altre specie nella scheda. Per la Spagna, il Settecento fu un secolo di grandi spedizioni geografiche e scientifiche: dal 1735 al 1800 se ne susseguirono una sessantina, geografiche, idrografiche, cartografiche, astronomiche e naturalistiche. Questo attivismo toccò il suo vertice con il regno di Carlo III (1759-1788) che promosse tre importanti spedizioni botaniche nei vicereami americani: il vicereame del Perù (che comprendeva Perú e Cile), quello di Nueva Granada (l'attuale Colombia) e quello di Nuova Spagna (Messico e America Centrale). La serie fu inaugurata dalla Expedición botanica al virreinato del Perú (1777-1788), frutto della cooperazione con la Francia, potenza alleata grazie al "patto di famiglia (su entrambi i troni sedevano esponenti dei Borboni) ma anche sospetta rivale per il dominio coloniale e il prestigio scientifico. I protagonisti furono tre giovani botanici: gli spagnoli Hipólito Ruiz e José Antonio Pavón e il francese Joseph Dombey. Tra vicissitudini di ogni genere, tra cui la più vasta rivolta della storia coloniale sudamericana, un naufragio che portò alla perdita di considerevoli raccolte, un incendio devastante, senza contare gli insanabili dissidi tra Dombey e i colleghi spagnoli, la spedizione ottenne risultati straordinari: oltre 3000 esemplari di piante essiccate, 2500 disegni botanici, con la scoperta di almeno 500 nuove specie e 140 generi. Molte furono pubblicate insieme da Ruiz e Pavón, che prima nella ricerca sul campo poi a Madrid costituirono un inossidabile sodalizio scientifico; anche a loro, che avevano dedicate dozzine dei generi da loro scoperti a uomini politici e scienziati, spetta l'ambito riconoscimento di un genere celebrativo: il monotipico Ruizia, endemico dell'isola di Réunion, e il ben più noto Pavonia. Entrambi si devono a Cavanilles, futuro direttore dell'Orto botanico di Madrid, e, per giustizia poetica, appartengono alla stessa famiglia, quella delle Malvaceae, mantenendo almeno in questo un legame tra i due inseparabili compagni. 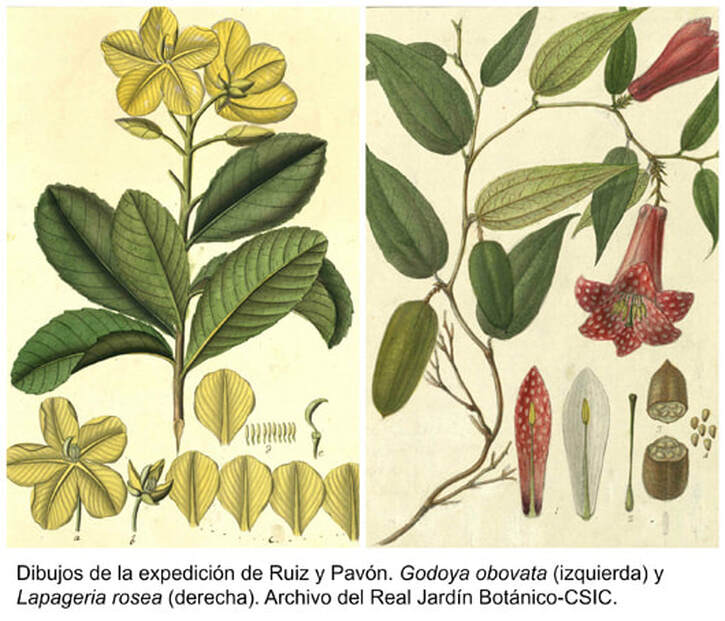 Una spedizione franco-iberica Nel 1774, di recente nominato Controllore generale delle finanze, il ministro francese Turgot chiese alla corona spagnola di autorizzare l'invio di un botanico francese in Sud America, per studiare la flora locale e cercare di recuperare le carte di Joseph de Jussieu che, rimasto in Perù 35 anni, era di recente rientrato in Francia in stato di estrema prostrazione. L'obiettivo principale era la ricerca e l'introduzione di specie alimentari nella Francia mediterranea e in Corsica, nella speranza di far fronte alle ricorrenti carestie. La proposta fu accolta con favore dal re di Spagna Carlo III, ma con due importanti modifiche: si sarebbe trattato di una spedizione congiunta, coordinata e diretta da Madrid, e il botanico francese sarebbe stato affiancato da colleghi spagnoli; alla Spagna inoltre spettavano la metà delle raccolte e la priorità della pubblicazione. In tal modo, la monarchia iberica, pur beneficiando delle conoscenze e della maggiore esperienza di un botanico formato al Jardin des Plantes parigino, avrebbe mantenuto il controllo della spedizione, con obiettivi parzialmente diversi da quelli francesi: la ricerca di piante industriali e medicinali (in particolare quelle da cui si ricavava il chinino), di cui intendeva riservarsi il monopolio. L'impresa fu posta sotto la tutela del Segretariato di Stato e affidata alla direzione scientifica di Casimiro Gomez Ortega, il direttore dell'Orto botanico di Madrid, che come primo farmacista reale era anche direttamente interessato alla scoperta e allo sfruttamento di medicamenti in regime di monopolio. Gli uomini scelti a Parigi e a Madrid era tutti giovani o giovanissimi: da parte francese, il trentacinquenne Joseph Dombey, che si era laureato in medicina a Montpellier, aveva partecipato a spedizioni botaniche in Provenza e sulle Alpi e si era perfezionato al Jardin des Plantes con Bernard de Jussieu e André Thouin; da parte spagnola, due studenti di farmacia allievi di Gomez Ortega, Hipólito Ruiz e José Antonio Pavón, entrambi ventitreenni. Per età, titoli ed esperienza, il più qualificato era certamente Dombey, l'unico laureato e il solo vero botanico; ma, per opportunità politica, a capeggiare la spedizione fu Ruiz, con il titolo di "primo botanico"; Pavón fu nominato "secondo botanico", mentre a Dombey toccò il ruolo collaterale di "botanico naturalista in qualità di accompagnatore dei botanici spagnoli della stessa professione". Non vera collaborazione dunque, ma una specie di convivenza forzata, nutrita di diffidenza reciproca. Dombey, che si era preparato con scrupolo alla missione studiando gli erbari di Joseph de Jussieu e imparando lo spagnolo, arrivò a Madrid all'inizio di novembre 1776, ma tra rinvii, ripensamenti e cambi di programma, la partenza per il Sud America avvenne solo un anno dopo, il 4 novembre 1777, quando i tre botanici si imbarcarono a Cadice alla volta di Callao, accompagnati da due pittori, Joseph Brunete e Isidro Gálvez, allievi della accademia di pittura di San Fernando. 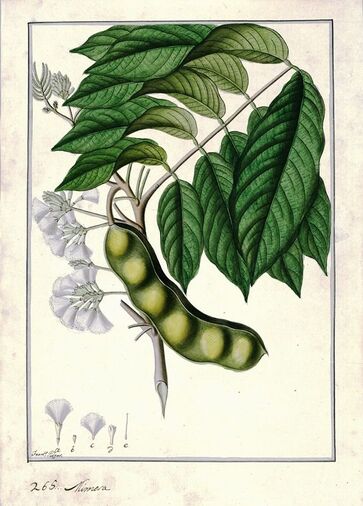 Dal Perù al Cile, con disastri Il gruppo giunse in Perù ad aprile e si mise alacremente al lavoro, stabilendo il proprio quartiere generale a Lima. Dapprima esplorarono i dintorni della capitale e le province costiere del nord, Huaura e Laurín. Sostenuti dall'entusiasmo, fecero importanti raccolte: i contadini, vedendo questi uomini ben vestiti, che percorrevano le campagne con una cartella sotto braccio in cui riponevano le piante, impressionati, li soprannominarono brujos yerbarteros, "stregoni erboristi". Già a settembre poterono spedire in Europa diciassette casse di materiali, dieci in Spagna e sette in Francia; l'invio di Dombey comprendeva anche alcuni reperti archeologici, raccolti presumibilmente a Laurin. Tuttavia non arrivò mai a Parigi: la nave su cui viaggiava fu intercettata dagli inglesi, e solo più tardi le sue preziose casse vennero restituite, ma alla Spagna. Nonostante il proficuo lavoro comune, l'atmosfera continuava ad essere improntata alla diffidenza; a Dombey era vietato muoversi da solo, a meno che gli fossero affidati compiti particolari dalle autorità (per la corona spagnola, era pur sempre uno straniero, dunque una potenziale spia) e la sua corrispondenza era sorvegliata; non poteva usufruire della collaborazione dei pittori, che erano al servizio esclusivo dei suoi colleghi spagnoli; inoltre, mentre le spese degli altri membri erano a carico della corona, lui doveva pagare tutto di tasca propria; e in colonia, dove ogni cosa doveva essere importata dall'Europa, la vita era molto cara. Anche i suoi rapporti personali con Ruiz, un giovane dal carattere vivo e amante della polemica, furono sempre piuttosto tesi; meglio andò con il pacato Pavón, che si assunse il ruolo di paciere, e divenne il suo compagno in molte escursioni. Nel maggio del 1779, il gruppo lasciò la costa per spostarsi tra le selve della Cordigliera, la cui vegetazione era all'epoca quasi sconosciuta alla scienza europea. Seguendo il sentiero inca, si spostò a La Oroya e Tarma, dove fissò la prima base. Poi si divisero: Ruiz e Galvez proseguirono fino al monastero francescano di Santa Rosa de Ocopa, mentre Pavón e Brunete andavano a Palca. Quanto a Dombey, fu inviato dal viceré a studiare le acque minerali di Cheuchin, per riunirsi con Ruiz e Galvez a Tarma, da dove i tre tentarono la scalata al monte Churupullana, dovendo desistere per la pioggia mista a grandine, Alla fine dell'anno tutto il gruppo si ricongiunse a Huasahuasi, rientrando a Lima alla fine del gennaio 1780 con la stagione delle piogge. Ad aprile ripartirono per la montagna, fissando la loro sede a Huanuco, al centro di una zona ricchissima di vegetazione, già alle porte dell'Amazzonia: la parte più difficile del loro viaggio, per l'assenza di sentieri segnati, il soffocante clima caldo-umido, le punture degli insetti, Tutti soffrirono di dissenteria e Ruiz si ammalò di febbri perniciose che furono sul punto di costargli la vita. In queste foreste i botanici trovarono molte piante ignote e importanti specie medicinali: alberi di coca (Erythroxylum coca) e soprattutto diverse specie di Cinchona, dalla cui corteccia si ricavava il chinino, il cui studio era uno degli obiettivi principali della spedizione spagnola. Mentre esploravano questa regione, incominciarono a diffondersi voci di una rivolta: erano le prime avvisaglie del sollevamento di Tupac Amaru, che sarebbe iniziato nel novembre 1780. A settembre, temendo un attacco, Dombey e Pavon rientrarono in fuga da Cuchero a Huanuco. L'avventura (poi rivelatasi un falso allarme) pesò molto negativamente sul morale di Dombey e minò il suo prestigio agli occhi dei compagni. Dopo essersi trattenuto a Huanuco fino a settembre egli rientrò a Lima, dove per mantenersi lavorò qualche mese come medico; solo a fine anno si ricongiunse ai suoi compagni, che nel frattempo avevano attivamente esplorato la provincia di Huamalies. Tutto il gruppo rientrò a Lima alla fine di marzo 1781. Nella seconda metà del 1781 gli spagnoli tornarono ad esplorare la provincia di Chancay, mentre Dombey rimase a Lima, come membro di una commissione incaricata di studiare le maree del porto di Callao. E' probabile che le autorità spagnole avessero preferito trattenerlo sulla costa, non desiderando che uno straniero fosse testimone di una ribellione tanto pericolosa. Il programma iniziale prevedeva che il gruppo proseguisse per Quito, da dove poi avrebbe dovuto raggiungere Cartagena per imbarcarsi alla volta dell'Europa. Fu probabilmente il dilagare della rivolta di Tupac Amaru a indurre Madrid a cambiare programma: nel gennaio 1782 la spedizione venne spostata in Cile. Giunti per mare a Talcahuano, i naturalisti stabilirono la loro base a Concepcion, dove si trattennero per circa un anno con escursioni a Arauco, Culenco e altrove; solo Pavón fece una puntata alla Cordigliera, per studiare il "pino del Cile", ovvero Araucaria araucana. Durante il loro soggiorno a Concepcion scoppiò un'epidemia di colera e Dombey prestò gratuitamente le sue cure agli ammalati come medico capo della città. Nel marzo 1783 la spedizione si spostò a Santiago, dove Ruiz si ammalò di febbre tifoidea, Dombey venne inviato a Coquimbo e Jarilla, per valutare le potenzialità economiche di alcune miniere abbandonate di mercurio. A ottobre si ritrovarono tutti a Santiago, per spostarsi insieme a Valparaiso, da dove si imbarcarono per Callao. Qui le sorti di Dombey e dei suoi compagni si separarono; mentre gli spagnoli rimanevano in Perù per continuare le esplorazioni secondo i nuovi ordini di Madrid, il francese, essendo ormai terminato il tempo fissato da Parigi, nell'aprile 1784 si imbarcò sulla nave El Peruano alla volta di Cadice. Lo attendevano sgradevolissime vicissitudini, su cui tornerò in un prossimo post. Su un'altra nave, la San Pedro de Alcantara, viaggiavano invece le 55 casse con le raccolte di Ruiz e Pavon; tuttavia, al largo del Portogallo, il vascello naufragò e tutto il materiale andò perduto. Nel frattempo, i botanici spagnoli avevano ripreso le ricerche, visitando nuovamente Huánuco e le montagne di Puzuzo. Poiché anche per loro si avvicinava il momento del ritorno, si decise di aggregare alla spedizione due apprendisti, che potessero continuare il lavoro dopo la loro partenza; la scelta cadde sul farmacista militare Juan José Tafalla come botanico e su Francisco Pulgar come pittore. Nel 1785 il gruppo così integrato continuò ad esplorare la ricca area di Huánuco, concentrandosi in particolare nello studio delle diverse specie di Cinchona; grazie all'esperienza accumulata, fu sicuramente il periodo più fruttuoso dell'intera spedizione; tuttavia mentre si trovavano a Macora un violento incendio distrusse la fattoria dove soggiornavano, mandando in fumo tre anni di diari di campo e quattro anni di descrizioni botaniche. La campagna dell'anno successivo li vide a Muña e ancora a Huánuco, Pillao e Chacahuasí. Durante uno degli spostamenti, Brunete si ammalò e morì; così furono solo in tre, Ruiz, Pavón e Galvez a imbarcarsi per Cadice, dove arrivarono il 12 ottobre 1788, a quasi 11 anni esatti dalla partenza. In Perù rimasero Tafalla e Pulgar che, con alcuni collaboratori, continuarono a inviare materiali alla Oficina de la Flora Peruviana y Chilense diretta da Ruiz fino al 1814, estendendo le ricerche anche all'Ecuador. 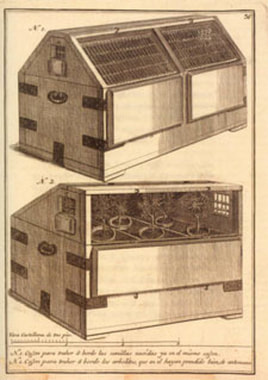 Una nuova flora tutta da scoprire e pubblicare Appena giunti in Spagna, Ruiz, Pavón e Galvez si recarono a Madrid per dedicarsi al'immane lavoro della pubblicazione delle raccolte. Li accolse una situazione di grande tensione, causata dalla pubblicazione, prima in Francia poi in Inghilterra, di alcuni dei materiali raccolti da Dombey, nonché dal conflitto più o meno latente tra Ortega e Cavanilles. I due botanici furono aggregati all'orto botanico di Madrid come "dimostratori" e nel 1792 fu creata per loro l'Oficina de la Flora Peruviana y Chilensis, diretta da Ruiz. Iniziò un intenso e metodico lavoro di studio delle raccolte, per classificare, nominare e descrivere correttamente le piante, in stretta collaborazione con Gomez Ortega come consulente e correttore. Intanto Galvez, assistito da un incisore e più tardi da un altro disegnatore, allestiva le illustrazioni. Il primo frutto di questo lavoro editoriale fu Quinología o tratado del árbol de la quina, pubblicato da Ruiz nel 1792, in cui descrisse sette specie di Cinchona raccolte in Perù; sull'argomento sarebbe tornato, insieme a Pavón, in Suplemento a la Quinologia (1801) in cui descrisse altre sette specie raccolte da Tafalla e polemizzò con una certa violenza con Mutis. Nel 1794, a quattro mani, usciva Florae Peruvianae, et Chilensis Prodromus, in cui - a mo' di anticipazione della più ambiziosa Flora - pubblicarono i caratteri distintivi di 149 nuovi generi, accompagnati da 37 tavole in bianco e nero. Nel 1798 iniziò ad uscire la monumentale Flora peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones, in cui le specie erano disposte secondo il sistema linneano; tra il 1799 e il 1802, ne uscirono altri due volumi, estendendo la pubblicazione fino alla classe linneana Octandria. Contemporaneamente, nel 1798 diedero alle stampe Systema vegetabilium florae peruvianae chilensis, un versione ampliata del Prodromus, priva di illustrazioni, contenente tutti i nuovi generi e le specie relative. Il nuovo contesto delle guerre con la Francia rivoluzionaria e napoleonica rese impossibile la pubblicazione di altri volumi della costosissima Flora peruviana, anche se i due autori riuscirono a preparare i manoscritti di ulteriori due volumi. Nel 1816 morì Ruiz (una sintesi della sua vita nella sezione biografie) e Pavón cercò di continuare da solo il lavoro comune; mentre il suo compagno non aveva problemi finanziari, avendo ereditato una farmacia da uno zio, egli doveva mantenersi solo con lo stipendio di botanico, che negli anni dell'occupazione francese venne a mancare. Per cercare di salvare il salvabile, fu così costretto a vendere a diversi collezionisti buona parte della sua biblioteca e molti esemplari di erbario (raccolti durante la spedizione o inviati da Tafalla o anche altri botanici); il lotto più cospicuo se lo aggiudicò Aylmer Bourke Lambert, cui tra il 1817 e il 1824 vendette oltre 15.000 campioni d'erbario, oggi custoditi al British Museum di Londra. Uno scempio che i botanici più giovani non perdonarono a Pavón; sempre più isolato, morì nel 1840; anche per la sua vita si rimanda alla sezione biografie. Il contributo della Spedizione botanica nel Vicereame del Perù alla conoscenze della flora sudamericana fu immenso: migliaia di essiccata, senza contare i semi e le piante vive inviati all'orto botanico di Madrid per essere moltiplicati e coltivati, 2000 disegni, circa 3000 specie, di cui non meno di 500 inedite e 140 nuovi generi. Va anche sottolineato che, essendo Ruiz e Pavón molto prudenti nella istituzione di questi ultimi, un'alta percentuale dei generi da loro creati è ancora oggi valida. Tra i più noti, vorrei citare almeno Aechmea, Aloysia, Bletia, Galinsoga, Guzmania, Gilia, Jovellana, Juanulloa, Lapageria, Masdevallia, Nierembergia, Peperomia, Salpiglossis.  Dediche di piante e scherzi del destino Nell'assegnare un nome ai loro nuovi generi, Ruiz e Pavon predilessero i nomi celebrativi, che utilizzarono talvolta per ingraziarsi il politico di turno (inclusi il re Carlo IV e sua moglie Maria Luisa, dedicatari di Carludovica e Aloysia, il ministro Godoy con Godoya, Napoleone con Bonapartea - oggi sinonimo di Agave - e l'imperatrice Giuseppina, con Lapageria), ma soprattutto per ricordare studiosi ed esploratori, prevalentemente ma non esclusivamente spagnoli. Ovviamente si resero omaggio l'un l'altro: Pavon ricordò il suo capo e amico con Ruizia, e Ruiz il fedele collaboratore con Pavonia; per sottolineare la loro amicizia, scelsero due arbusti della flora cilena piuttosto affini; appartenenti alla famiglia delle Monimiaceae, sono oggi entrambi sinonimi, il primo di Peumus, il secondo di Laurelia. Infatti le due dediche, pubblicate in Florae peruvianae et chilensis prodromus, erano state anticipate di qualche anno da Cavanilles, ancora prima del ritorno di Ruiz e Pavón dall'America. Per un caso singolare, i suoi Ruizia e Pavonia oggi appartengono alla stessa famiglia, le Malvaceae, insieme a Dombeya, il genere che, per non fare torto a nessuno, l'illustre botanico volle dedicare a Joseph Dombey. Visti i rapporti piuttosto elettrici di Ruiz con Dombey e con lo stesso Cavanilles (reo di aver pubblicato alcune piante peruviane senza il suo assenso), a posteriori questa dedica ecumenica appare piuttosto ironica, come lo sono la grandezza e l'importanza rispettiva dei tre generi: a Ruiz, il capo della spedizione e dell'Oficina de la Flora Peruviana y Chilensis è toccato il monotipico Ruizia, endemico di una piccola isola; al suo "secondo" Pavón il lussureggiante Pavonia, un grande genere di oltre duecento specie; al terzo incomodo Dombey l'ancora più spettacolare Dombeya (su questo genere, ovviamente, tornerò nel post a lui dedicato). Iniziamo dunque con Ruizia; proprio come Dombeya, fino a qualche anno era assegnata alla famiglia Sterculiaceae, che è confluita in Malvaceae, sottofamiglia Dombeioideae (uno scherzo del destino?). Comprende una sola specie, Ruizia cordata, un alberello endemico dell'isola della Réunion nell'Oceano indiano, dove è nota come bois de senteur blanc, ovvero "legno profumato bianco". Allo stato selvatico, dove è presente in aree collinari aride, è ridotta a pochi individui, mentre è coltivata nei giardini e negli orti botanici. Ha un'elegante chioma arrotondata e due tipi di foglie: più piccole, molto incise e verde chiaro quelle giovanili, più grandi, argentate e grossolanamente triangolari quelle più mature. E' dioica e presenta fiori maschili o femminili in piante separate; rosa salmone, hanno cinque petali e sono riuniti in infiorescenze lungo i rami. E' considerata una pianta magica e porta fortuna, con cui si fabbricavano feticci e amuleti scaccia-malocchio. Qualche approfondimento nella scheda. Molto più di recente, un secondo piccolo genere si è aggiunto a glorificare Ruiz. Durante una delle sue compagne, egli a Pozuzo in Perù aveva raccolto un esemplare che più tardi aveva classificato e pubblicato come Guettardia ovalis. Nel 1937 il botanico svedese Robert Elias Frias studiando questa pianta concluse che doveva essere assegnata a un genere proprio, che in onore del raccoglitore battezzò Ruizodendron (famiglia Annonaceae); R. ovale ne costituisce l'unica specie. E' un albero di grandi dimensioni originario della foresta pluviale del Sud America settentrionale, dove può superare i 40 metri; ha foglie con lamina cartacea da ellittiche a ovali e fiori crema, con petali di consistenza carnosa, seguiti da frutti verdastri. Qualche informazione in più nella scheda.  Pavonia, per prolungare le fioriture Anche Pavonia è una Malvacea, ma appartiene alla sottofamiglia Malvoideae, di cui costituisce uno dei generi più variegati, ricchi di specie e di più ampia diffusione, con circa 200-250 specie delle zone tropicali e temperate calde, 100 delle quali in Sud America, 50 sia in Nord America sia in Africa, cui sia aggiungono poche specie asiatiche e australiane. Sono erbacee annuali o perenni oppure arbusti, spesso con foglie cordate alla base, e grandi fiori a coppa in genere solitari, più raramente raccolti in racemi terminali; i fiori ricordano molto da vicino quelli dell'ibisco. Molto decorative, alcune specie hanno incominciato ad essere coltivate anche da noi per l'insolito periodo di fioritura, autunnale o anche invernale. Probabilmente la più diffusa è Pavonia hastata, di origine sudamericana; è un arbusto sempreverde dal portamento ordinatamente tondeggiante con foglie ovato-cordate e copiosa fioritura; i fiori a coppa, simili a quelli dell'ibisco, sono bianchi o rosati con una vistosa macchia scura al centro e sono prodotti dalla fine dell'estate all'autunno inoltrato. In realtà, un prima fioritura avviene già in primavera, quando il cespuglio si riempie di boccioli, che però non si aprono, sebbene siano seguiti dalla produzione di semi. Si tratta del fenomeno della cleistogamia: la pianta, per superare condizioni avverse, è in grado di autofecondarsi senza subire lo stress dell'apertura dei fiori. Proviene invece dal Texas e dal Messico P. lasiopetala, un'erbacea suffruticosa che forma bassi cespugli con foglie dentate o lobate persistenti e grandi fiori a coppa rosa vivo da giugno fino alla fine dell'autunno. Entrambe le specie sono abbastanza rustiche. E' invece adatta solo ai climi caldi o alla coltivazione in interno la brasiliana P. multiflora, nota come "candela brasiliana", caratterizzata da curiosi fiori con brattee lineari rosse o rosa fucsia che circondano i petali arrotolati su se stessi e gli stami prominenti blu scuro; è un grande arbusto con foglie lanceolate lucide verde scuro, la cui fioritura si prolunga dalla primavera all'autunno; in casa e nelle giuste condizioni, può invece fiorire per tutto l'inverno. Affine è P. x gledhillii, un ibrido di origine orticola tra P. makoyana e P. multiflora, con brattee rosse. Qualche approfondimento nella scheda. Aver partecipato a un viaggio intorno al mondo non bastava a spegnere la sete di conoscenza di Georg Heinrich von Langsdorff, uno dei naturalisti della spedizione Krusenstern. Così, invece di completare la circumnavigazione con i suoi compagni, al ritorno dal Giappone preferì andarsene in Alaska, e da lì in California, da dove rientrò in Russia due anni dopo gli altri, non senza aver attraversato a piedi la Siberia. Ce n'era abbastanza per gettare le basi di una brillante carriera accademica, ma quando gli si presentò l'occasione di andare in Brasile come rappresentante diplomatico dell'Impero russo, sentì irresistibile il richiamo di quel paradiso dei naturalisti che durante la spedizione Krusenstern aveva appena potuto intravvedere. In Brasile, dove sarebbe rimasto 17 anni, fondò una fazenda e la trasformò in un centro d'attrazione per i numerosi naturalisti che visitavano il paese; sostenne e sponsorizzò alcune spedizioni, ad altre partecipò di persona, come quella che lo vide esplorare lo stato di Minas Gerais insieme a Augustin de St. Hilaire. Ma soprattutto organizzò e diresse un'epica spedizione da Sao Paulo a Parà, sul Rio delle Amazzoni (1822-28), che purtroppo gli costò la salute fisica e mentale. Riportato dai suoi in Germania, visse ancora a lungo, ma, privo di senno, non ricordava neppure di essere stato in Brasile. Purtroppo per la scienza, ciò significò che le sue enormi collezioni giacquero dimenticate e inedite nei magazzini di varie istituzioni russe per oltre un secolo. Non era stato dimenticato però nella tassonomia botanica, dove lo ricorda il singolare genere parassita Langsdorffia. 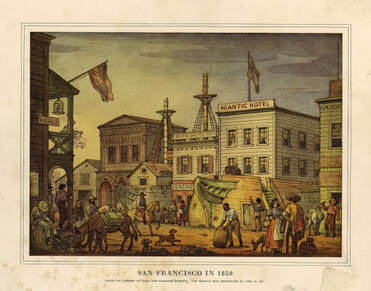 Fame in Alaska e una deludente visita a San Francisco La nostra storia inizia in un albergo di Copenhagen, in una giornata di fine agosto 1803. L'albergatore informa un cliente appena arrivato che proprio lì alloggiano alcuni ufficiali delle navi Nadežda e Neva. Quel viaggiatore è il medico tedesco Georg Heinrich von Langsdorff; qualche mese prima, quando ha saputo della spedizione, ha presentato la sua candidatura come naturalista, ma, nonostante le raccomandazioni, essa è stata respinta. Gli è stato detto che un naturalista c'è già (lo conosciamo, è Wilhelm Gottlieb Tilesius). Ma Langsdorff non è tipo da rassegnarsi; si è precipitato a Copenhagen per perorare la sua causa e ora il caso l'ha condotto nel posto giusto. Gli sembra un auspicio fortunato che lo incoraggia a presentarsi all'ambasciatore Rezanov il quale lo ascolta benevolo e lo accompagna dal comandante Krusenstern. Anche il capitano si convince, e Langsdorff diventa il secondo naturalista della prima circumnavigazione russa del globo. Al momento, aveva sono 29 anni, ma non era un novellino; era stato in Portogallo come medico militare, aveva visitato Londra e Parigi. Come il suo contemporaneo Humboldt, era posseduto dal sacro fuoco della ricerca e quel viaggio intorno al mondo sembrava fatto per lui. La realtà però si dimostrò inferiore alle aspettative: pochi soggiorni a terra, nessun aiuto nelle ricerche, difficoltà a preparare e conservare adeguatamente gli esemplari in quei climi estremi, la rivalità latente con il più anziano Tilesius. Così, quando si presentò l'occasione di abbandonare la spedizione per nuovi orizzonti, non ebbe molte esitazioni. Come ho già raccontato in questo post, dopo sei mesi di semi prigionia in Giappone (Langsdorff li aveva passati a studiare e descrivere pesci), nel giugno 1805 la Nadežda giunse in Kamčatka dove l'ambasciatore Rezanov trovò l'ordine di recarsi ad ispezionare gli avamposti russi in Alaska. Chiese dunque a Langsdorff di accompagnarlo come medico personale; il tedesco, nonostante temesse di offendere l'ottimo comandante Krusenstern, non poté resistere alla prospettiva di visitare quelle regioni remote, selvagge e quasi ignote alla scienza. Si imbarcò così con Rezanov e i suoi accompagnatori sulla Maria, alla volta prima delle Aleutine, poi di Sitka (o Novoarchangelsk). Nell'America russa trovarono una situazione allarmante, peggiorata dal loro stesso arrivo; le provviste incominciavano a scarseggiare e sempre più persone si ammalavano di scorbuto. Nel porto di Sitka giunse però, in cerca di acqua e del legname necessario per riparazioni, il mercantile americano Juno. Rezanov e il governatore Baranov lo acquistarono completo di tutte le attrezzature e lo inviarono a Kodiak per provvedere alle esigenze più immediate. Ma non bastò. Ormai la situazione era drammatica e peggiorava di giorno in giorno. Rezanov decise così di andare a cercare provviste a San Francisco, in California, che all'epoca consisteva di una missione francescana e di un presidio militare spagnolo. Ovviamente, Langsdorff lo accompagnò. Partita da Sitka alla fine di febbraio 1806, un mese dopo la Juno faceva il suo ingresso nel Golden Gate e, grazie al fascino e all'abilità diplomatica di Rezanov, a maggio ne ripartiva con le stive piene di provviste. La colonia era salva, ma Langsdorff ne aveva avuto abbastanza dell'America russa. Durante la sosta in California, aveva dovuto limitarsi a visitare i dintorni della missione; l'unica volta che era riuscito ad allontanarsi per un'escursione di tre giorni, al suo ritorno aveva trovato gli animali da lui catturati morti e tutte le piante spazzate via dalle onde. Obbligato a trascorre quasi tutto il suo tempo a bordo, senza alcun aiuto nelle ricerche naturalistiche, venne boicottato in tutti i modi (alcune pelli che aveva posto a seccare sul ponte furono gettate vie e la carta usata per essiccare le piante finì inavvertitamente nel fuoco). Alle sue proteste, gli era stato obiettato che era lì per fare il medico e l'interprete (grazie al portoghese e al latino, che gli permetteva di comunicare con i frati). Decise così che, appena rientrato a Sitka, avrebbe chiesto di andarsene sulla prima nave. Cosa che fece imbarcandosi il 18 giugno sulla Rostislav insieme al capitano Wolfe, l'ex comandante della Juno, con cui aveva stretto amicizia. L'imbarcazione era molto piccola e lenta ed arrivò in Kamčatka solo a settembre. Langsdorff dovette rassegnarsi a trascorrervi l'inverno. Nel frattempo, anche Rezanov aveva lasciato Sitka a bordo della Juno, molto più veloce, ed era arrivato a Okhotsk a settembre, proseguendo immediatamente per San Pietroburgo; gli premeva di arrivare al più presto perché a San Francisco si era innamorato, ricambiato, della figlia del comandante del presidio spagnolo, e per sposarla era necessario il permesso dello zar. Ma durante il viaggio si era ripetutamente ammalato e a marzo dell'anno successivo era morto a Krasnojarsk. Non appena sbarcato a sua volta a Okhotsk a giugno, Langsdorff ne fu informato e probabilmente si pentì di aver abbandonato il suo protettore quando aveva più che mai bisogno di lui, tanto che volle andare a rendere omaggio alla sua tomba. Dopo aver attraversato la Siberia a piedi, nel marzo 1808 era finalmente a San Pietroburgo, dove avrebbe potuto intraprendere una tranquilla vita di accademico. 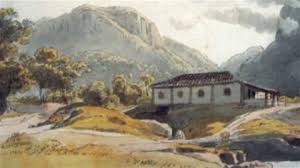 Brasile: una fazenda modello Il destino e la sua sete di avventure e conoscenza decisero altrimenti. Nel 1808, quando il suo paese fu invaso dai francesi, il re del Portogallo Giovanni VI aveva trovato rifugio con la sua corte in Brasile, stabilendosi a Rio. Nel 1812 lo zar decise di inviare un console a Rio de Janeiro e la sua scelta cadde su Langsdorff, che parlava perfettamente il portoghese e oltre che medico e naturalista era anche barone, e ormai suddito russo, con il nome russificato Grigorij Ivanovič Langsdorf. Era un'opportunità favolosa. Le frontiere del Brasile fino ad allora erano rimaste chiuse agli stranieri e i suoi immensi tesori naturalistici erano quasi totalmente sconosciuti alla scienza. Langsdorff, che ne aveva avuto un misero assaggio durante lo scalo della spedizione Krusenstern a Santa Catalina, era al settimo cielo. Deciso ad unire ai doveri diplomatici l'esplorazione scientifica, fece venire a San Pietroburgo come suo assistente il giovane zoologo Georg Wilhelm Freyreiss e partì con lui per il Brasile; obbligati a passare l'inverno in Svezia, giunsero a Rio solo nel 1813. Nel 1816 Langsdorff acquistò una proprietà a nord della capitale, nei pressi di Porto Estrella, con l'intenzione di trasformarla in una piantagione modello; chiamata Mandioca, era basata sulla policoltura di manioca, caffè (fu tra i primi a coltivarlo), miglio, batate, indaco e noce moscata e sull'impiego di tecniche agricole d'avanguardia. All'inizio era lavorata da schiavi, ma Langsdorff, deciso a sostituirli con salariati europei, tra il 1820 e il 1821 fece un viaggio in Europa per promuovere l'emigrazione di coloni in Brasile. A Mandioca portò poi con sé un gruppo di tedeschi, che ebbero difficoltà ad adattarsi e finirono per rivoltarsi e furono sostituiti da coloni svizzeri. Dopo la partenza di Langdsdorff per la sua grande spedizione, nel 1826, la piantagione fu espropriata, ma nei suoi dieci anni di vita fu un centro d'attrazione per i numerosi naturalisti europei che visitarono il paese, spesso proprio su invito o stimolo di Langsdorff, che l'aveva dotata di una eccellente biblioteca naturalistica, di un museo della flora e della fauna locale e di un curatissimo giardino botanico. A visitarla furono tantissimi: oltre alla coppia reale costituita dall'imperatore Pedro I e da sua moglie Leopoldina d'Asburgo, protettrice delle scienze, tra loro troviamo Friedrich Sellow, von Martius e von Spix, il Principe Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied, William Swainson, Augustin Saint-Hilaire. Inoltre, alternava all'attività diplomatica e alla gestione della piantagione brevi spedizioni nei dintorni di Rio. Finanziò la spedizione di Freyreiss e Sellow nel Nordeste e tra il dicembre 1816 e il marzo 1817 esplorò insieme a Saint Hilaire la provincia di Minas Gerais. Il suo sogno era però una grande spedizione nelle inesplorate regioni dell'interno. Nel giugno 1821, al termine del viaggio europeo, andò a San Pietroburgo a presentare il suo progetto al vice cancelliere Nasselrode e allo zar Alessandro I, che garantì il suo appoggio e larghi mezzi finanziari.  Una grandiosa e sfortunata spedizione A Langsdorff venne lasciata carta bianca nella scelta dell'itinerario e nell'organizzazione; rimase in Europa fino alla fine dell'anno, per acquistare l'equipaggiamento necessario e ingaggiare un'équipe di eccellenti specialisti. Ne facevano parte il botanico prussiano Ludwig Riedel, l'ufficiale cartografo russo Nester Gavrilovič Rubcov, lo zoologo francese Edouard Ménétries e il pittore bavarese Johann Moritz Rugendas. Tra i partecipanti, anche Karl von Drais, l'inventore della bicicletta, in qualità di agrimensore. Preceduto da Riedel, che si trovava già in Brasile, e da Rubcov, giunto a Rio in avanscoperta nel febbraio 1822, Langsdorf partì da Brema alla fine del 1821, insieme a Ménétries, Rugendas e 85 coloni tedeschi e giunse a Rio a marzo dell'anno successivo. Trattenuto nella capitale per i suoi doveri diplomatici in un momento delicato della vita politica brasiliana, poté dedicarsi all'organizzazione della spedizione solo all'inizio del 1824. Ottenuta l'autorizzazione imperiale a febbraio, la spedizione si mise in cammino all'inizio di maggio. Il progetto iniziale di Langsdorff era viaggiare in direzione nord seguendo il fiume Paraiba nella regione mineraria di Minas Gerais, per poi proseguire verso le province di Goais e Mato Grosso. Ma la strada diretta tra Minas Gerais e Mato Grosso risultò impraticabile per una spedizione di quelle proporzioni; inoltre Rugendas e Ménétries rifiutarono di continuare, per dissensi personali con Langsdorff. Fu gioco forza ritornare a Rio; qui i defezionisti furono sostituiti dal giovane zoologo prussiano Christian Friedrich Hasse e da due artisti francesi, Aimé-Adrien Taunay e Antoine-Hércule Florence. La spedizione poté ripartire solo nella seconda metà del 1825; mentre Riedel e Hasse si dirigevano a Sao Paulo via terra, gli altri si imbarcarono per il Porto di Santos, da dove avrebbero raggiunto Sao Paulo. Dopo diversi mesi trascorsi a esplorare quella provincia, nel giugno 1826 gli esploratori si imbarcarono a Porto Feliz per risalire il fiume Tietê fino a Cuiabá, la capitale del Mato Grosso, dove giunsero a gennaio 1827 e stabilirono il quartier generale fino a novembre. A questo punto si divisero in due gruppi: il primo, che comprendeva Langsdorff, Rubcov e Florence, si mosse verso nord per raggiungere Santarém sul Fiume delle Amazzoni, dove in effetti giunsero il 1 giugno 1828. Ma lungo la strada tutti si ammalarono di febbri tropicali, compreso il barone, che incominciò a dare segni crescenti di follia e nel maggio 1828, mentre si trovavano sul fiume Juruena, perse la memoria. L'altro gruppo, con Riedel e Tauney, risalì il fiume Guaporé, dove Tyaney annegò nel gennaio 1828; quindi continuarono lungo i fiumi Mamoré e Madeira fino a Manaus, dove li raggiunse l'ordine di andare al porto di Belem, sull'Atlantico, dove i due gruppi si ricongiunsero e si imbarcarono per Rio. Vi arrivarono nel marzo 1829, dopo aver percorso oltre 6000 km. Il barone Langsdorff versava in uno stato di estrema prostrazione fisica e di disordine mentale; mentre Pieter Kielchen, il viceconsole russo, provvedeva a spedire a San Pietroburgo i materiali raccolti (i più interessanti sono le testimonianze etnografiche sui numerosi popoli indigeni incontrati), insieme alle collezioni e ai manoscritti di Langsdorff, egli fu ricondotto in Germania da un amico. Visse ancora vent'anni, senza mai recuperare il senno e la memoria. Non ricordava neppure un giorno di quelli passati in Brasile. Per una sintesi della vita, si rimanda come al solito alla sezione biografie. Il frutto delle sue ricerche subì lo stesso destino. La sua spedizione e il suo contributo alla conoscenza della natura brasiliana furono dimenticati. Le raccolte finirono a Pietroburgo, disperse tra i magazzini del Museo Etnografico, del Museo Navale, del Museo Zoologico e dell'Accademia delle Scienze, i manoscritti non furono pubblicati fino al 1948, quando ne uscì una parziale edizione russa. Solo il bicentenario della nascita, nel 1974, celebrato con un convegno internazionale, ha portato alla riscoperta di questa eccezionale figura. Da quel momento l'interesse per l'opera di Langsdorff non ha fatto che crescere, come dimostra anche una splendida mostra tenutasi a Brasilia nel 2010, che ha permesso per la prima volta di vedere molti degli spettacolari acquarelli realizzati dai tre pittori della spedizione.  E' una pianta o un fungo? Certamente non lo avevano dimenticato i tanti botanici di cui fu mentore e generoso ospite a Mandioca. Due di loro vollero ricordarlo con la dedica di un genere Langsdorffia (o Langsdorfia): nel 1814 von Martius, che visitò la tenuta insieme a von Spix prima di partire per l'Amazzonia; nel 1820 l'italiano Raddi, che lo incontrò alla fine del 1817 e forse esplorò con lui i dintorni di Rio. Si aggiunsero nel 1821 il frate Leandro do Sacramento, futuro direttore dell'orto botanico di Rio; nel 1832 Willdenow, nel 1836 Rafinesque, nel 1863 Regel. Ovviamente ad essere valido è solo il primo, Langsdorffia Mart., un genere davvero singolare della curiosa famiglia di piante parassite Balanophoraceae. A prima vista, le infiorescenze della specie tipo, Langsdorffia hypogea, ricordano singolarmente la cappella di un fungo color rosso vino sorretto da un gambo terroso; come la Rafflesia, che appartiene a una famiglia diversa ma vive nel medesimo habitat, il sottobosco delle foreste umide, è visibile solo in fioritura, quando dal tubero sotterraneo emergono i fiori unisessuali; le infiorescenze maschili e femminili hanno una struttura simile, un corpo semisferico circondato da brattee, ma le prime sono più grandi. Incapaci di sintetizzare la clorofilla, traggono i nutrienti dalle radici di altre piante, installandosi anche piuttosto in profondità; infatti, nello stato di Manais Gerais, oltre che nelle foreste, sono reperibili anche in caverne e miniere abbandonate. Un'altra curiosità di questo genere singolare è la distribuzione disgiunta: due specie sono americane, una vive in Madagascar, una in Papua-Nuova Guinea (dove convive appunto con Rafflesia). Qualche approfondimento nella scheda. Estremo lembo orientale della Siberia, la Kamčatka è una penisola lunga circa 2000 km, stretta tra il golfo d'Okhotsk a occidente e l'oceano Pacifico ad oriente. Anche oggi quasi disabitata (con un territorio poco maggiore di quello italiano, conta circa 300.000 abitanti), con un clima subartico e paesaggi mozzafiato, dominati dai numerosissimi vulcani, è un paradiso della biodiversità, con ambienti geologici unici, un fitto manto forestale, una ricchissima fauna - famosi su tutti gli orsi, che ne sono un po' il simbolo - e una flora varia e diversificata. Nel XVIII secolo, era abitata da circa 50.000 persone di etnia itelmena, che vivevano di caccia e pesca; la penetrazione dell'impero russo, che vi inviò nuclei di cosacchi e impose un tributo in pellicce ai locali, era iniziata da pochi decenni. Il primo a studiarla in modo sistematico fu Stepan Krašeninnikov, il più promettente degli studenti che parteciparono alla Grande spedizione del Nord. Secondo il progetto iniziale, a esplorare la penisola avrebbero dovuto essere i professori del distaccamento dell'Accademia, ma essi preferirono rimanere in Siberia e inviare al loro posto l'allievo. Giunto in Kamčatka nell'autunno del 1737, egli nell'arco di tre anni ne percorse in un lungo e in largo il territorio, raccogliendo una grande massa di informazioni benché lavorasse in condizioni difficilissime. Soltanto alla fine del 1740 arrivò da San Pietroburgo Georg Wilhelm Steller, che prese su di sé il comando della missione e gli ingiunse di rientrare nella capitale. L'arroganza del tedesco non lo ha tuttavia privato della gloria di essere stato il primo naturalista ad esplorare e descrivere la Kamčatka; gli si deve infatti Opisanie zemli Kamčatki, "Descrizione della terra di Kamčatka", il primo resoconto geografico, etnografico, linguistico e naturalistico della penisola, per la cui redazione Krašeninnikov poté avvalersi anche dei materiali di Steller. Titolare della cattedra di botanica e scienze naturali e curatore dell'Orto botanico dell'Accademia di San Pietroburgo, fu tra i primi russi ad essere ammesso in questa istituzione all'epoca ancora dominata da studiosi stranieri. A ricordarlo, oltre a diverse località della Kamčatka, il nome specifico di varie piante che fu il primo a descrivere, e il genere Krascheninnikovia, dedicatogli da un altro esploratore delle terre russe, Johann Anton Güldenstädt. Krašeninnikov l'esploratore Dominata da vulcani attivi, ricca di fiumi dalle acque purissime, con un manto forestale che offriva rifugio e alimento a una abbondante fauna selvatica, all'inizio del XVIII secolo la Kamčatka era abitata da circa 50.000 nativi che vivevano di caccia e di pesca. I russi li chiamavano Kamčadal, ma essi si definivano Itelmen. I primi nuclei russi, costituiti da distaccamenti militari di cosacchi incaricati di imporre ai nativi un tributo in pellicce, vi arrivarono nel corso del Seicento, creando piccoli insediamenti soprattutto sulla costa occidentale. Il più importante era il forte di Bolšeretsk, in realtà un minuscolo accampamento fortificato che nel 1728, quando Bering vi giunse durante la Prima spedizione in Kamčatka, contava appena 14 abitazioni. Proprio muovendo da Bolšeretsk Bering e i suoi uomini tra l'autunno e l'inverno 1728-29 compirono una difficile marcia attraverso le montagne per raggiungere la costa orientale, dove la primavera successiva costruirono la nave con la quale avrebbero esplorato il Pacifico settentrionale alla ricerca del passaggio a Nord est. Era il primo contatto scientifico con la penisola, sufficiente a mostrarne il grande interesse geologico e l'enorme potenziale naturalistico e economico (vale la pena ricordare che le pellicce erano la prima voce nelle esportazioni dell'Impero russo). L'esplorazione sistematica del suo territorio fu dunque uno dei principali obiettivi scientifici della Seconda spedizione in Kamčatka; ad occuparsene avrebbero dovuto essere i professori del distaccamento dell'Accademia, ma le cose andarono diversamente. Infatti, quando giunsero a Yakutsk, dove si trovava il quartier generale di Bering, Müller e Gmelin cambiarono programma. Il primo era seriamente ammalato, mentre il secondo aveva perso buona parte delle sue raccolte in un incendio. Decisero così di rimanere in Siberia e di inviare in avanscoperta in Kamčatka il loro studente più promettente, Stepan Petrovič Krašeninnikov, che intendevano raggiungere in un secondo tempo. Cosa che non avvenne mai. Fu così che il primo studioso a esplorare la penisola, e più tardi a pubblicare i risultati nella sua lingua madre, non fu uno dei numerosi scienziati tedeschi che dominavano l'Accademia della scienze, ma un figlio della grande madre Russia. In tal modo, il viaggio in Kamčatka di Krašeninnikov costituisce una tappa importante della nascita della scienza russa e della sua emancipazione dai mentori occidentali. In una Russia che non aveva conosciuto né il Rinascimento né la Rivoluzione scientifica, non esisteva infatti personale scientifico formato. Per sopperire in tempi rapidi a questa lacuna, su suggerimento di Leibnitz, con il quale si era intrattenuto a lungo durante il suo viaggio in Europa, Pietro il Grande volle creare l'Accademia russa delle Scienze (l'atto di fondazione è del 1724, poco prima della morte dello zar), che era allo stesso tempo una società scientifica e un centro didattico, da cui dipendevano un ginnasio e un'università. Le lezioni, in lingua latina, erano tenute dagli accademici, tutti stranieri provenienti da università dell'Europa occidentale; nel disegno di Pietro, in tal modo sarebbe stata formata una leva di giovani studenti russi che sarebbero diventati gli studiosi di domani, nonché i tecnici e i funzionari necessari al progresso del paese. Capiamo dunque bene perché la seconda spedizione in Kamčatka, cui l'Accademia fornì personale e supporto scientifico, accanto a tecnici e studiosi stranieri, come lo stesso Bering, danese, oppure il francese de l'Isle de la Croyère e i tedeschi Müller, Gmelin e Steller, abbia visto la partecipazione di un gruppetto di promettenti studenti russi, provenienti dai ranghi del ginnasio o dell'università dell'Accademia, oppure dalla migliore delle scuole moscovite, l'Accademia slavo-greco-latina. La spedizione, in tal modo, fu anche un gigantesco laboratorio didattico in cui gli studenti apprendevano il metodo e il linguaggio scientifico affiancando i propri professori sul campo. Uno di loro era il nostro protagonista, Stepan Petrovič Krašeninnikov. Figlio di uno soldato povero, si era distinto tra gli studenti dell'Accademia slavo-greco-latina, che offriva un corso di studi ancora tradizionale, basato essenzialmente sullo studio delle lingue classiche e della logica aristotelica. Proprio in vista della spedizione, nel 1732 (all'epoca era ventenne) fu inviato a San Pietroburgo dove venne istruito dai professori che poi avrebbe accompagnato nella spedizione, in particolare Gmelin e Müller. Partito con loro nell'agosto 1733, li accompagnò fino a Yakutsk; durante il lungo viaggio, durato circa tre anni, fece osservazioni meteorologiche con Gmelin e fu coinvolto in diverse escursioni a breve raggio, in cui via via affinò la sua capacità di studiare un territorio in ogni suo aspetto, dalla geografia alla geologia, dagli animali e dalle piante alle risorse economiche, senza trascurare la storia, gli usi, i costumi e le lingue delle popolazioni locali (campo in cui dimostrò un'eccezionale attitudine). Tra l'altro, fu incaricato di studiare due caverne e dipinti rupestri nei pressi di Krasnoyarsk e nel luglio 1735 diresse la sua prima spedizione indipendente, in cui esplorò e studiò le sorgenti calde sul fiume Onon. Il progetto iniziale prevedeva che tutto il gruppo proseguisse con Bering e si imbarcasse per la Kamčatka; come ha già anticipato, Müller e Gmelin rimasero invece in Siberia e ordinarono a Krašeninnikov di recarsi in Kamčatka a preparare il campo dove lo avrebbero raggiunto in un secondo tempo. Nel luglio 1737 Krašeninnikov partì dunque con il gruppo di Bering per Okhotsk, raggiunto dopo un faticoso cammino di 47 giorni; si imbarcò quindi con gli altri sulla nave Fortuna in direzione di Bolšeretsk, ma, poiché il battello era sovraccarico, dopo nove ore in balia delle onde, per proseguire si dovette buttare a mare buona parte dei bagagli (Krašeninnikov perse così le provviste per due anni e una parte dell'attrezzatura). Appena sbarcati, nell'ottobre 1747, sperimentarono anche gli effetti di un terremoto, uno tsunami con epicentro nelle Curili, la lunga dorsale di isole che unisce la Kamčatka al Giappone. Mentre il resto della spedizione proseguiva il suo cammino verso la costa orientale, dove sarebbero state costruite le navi per l'esplorazione del Pacifico settentrionale, Krašeninnikov rimase a Bolšeretsk per preparare il campo base e iniziare l'esplorazione della penisola. Era una regione difficile e ostile (oltre a terremoti e al clima rigido, erano frequenti le ribellioni dei locali, poco disposti ad assoggettarsi al tributo imposto dai russi), ma estremamente varia e interessante da ogni punto di vista; intanto, una geologia peculiare con circa 160 vulcani, 29 dei quali attivi, campi di geyser, fonti di acque termali; una grande ricchezza di acque, con migliaia di corsi d'acqua alimentati da oltre 400 ghiacciai e centinaia di migliaia di laghi; un clima fondamentalmente subartico, ma con forti differenze, tra le valli e le cime, le zone interne e quelle costiere, tra la fredda costa orientale e la più mite costa occidentale; ambienti naturali altrettanti vari, in cui alla tundra arida e alle torbiere si alternano praterie erbose, boscaglie e foreste di conifere e latifoglie; una fauna estremamente ricca (lo è ancora oggi, e tanto più lo era trecento anni fa) con numerosi mammiferi, tra cui l'orso, il re e il simbolo animale della penisola, uccelli stanziali e di passo, un eccezionale patrimonio ittico. Appena giunto a Bolšeretsk, Krašeninnikov si attivò per preparare il terreno per l'arrivo dei professori, creando un campo base che includeva un piccolo giardino di acclimatazione per le piante, secondo le indicazioni di Gmelin. Dedicò questi primi mesi a brevi escursioni nella regione più meridionale, quindi nella primavera del 1738, accompagnato da un interprete e da un drappello di soldati, partì per la prima delle undici spedizioni nel corso delle quali avrebbe battuto in lungo e in largo la penisola. Percorse sia lunghi tratti della costa sia l'interno da sud a nord, per un totale di oltre 3500 km. Fu così in grado di descrivere le quattro penisole orientali della Kamčatka e i golfi da esse formati, i maggiori vulcani (tra cui il vulcano attivo più alto d'Eurasia, Ključevskaja Sopka, 4688 metri), i campi di geyser delle valli dei fiumi Paužetka e Banna. Seguirono numerose escursioni minori e una seconda lunga spedizione, iniziata nell'autunno del 1739, in cui Krašeninnikov risalì il fiume Bystra, per poi raggiungere le sorgenti del fiume Kamčatka che scese fino al forte cosacco di Nižne-Kamčatsk, dove raccolse informazioni sull'aurora boreale, chiaramente visibile nel marzo di quell'anno. I suoi informatori erano sia i pochi russi presenti nell'area, sia soprattutto i locali, da cui acquistava manufatti e che interrogava sulle pratiche di caccia e pesca, oltre ad osservarne gli usi e i costumi, secondo le precise indicazioni di Müller. Ovviamente, durante i suoi viaggi non mancava mai di raccogliere esemplari naturalistici che poi inviava a Gmelin, accompagnati da lettere-relazione in latino. Nel settembre 1740, giunsero a Bolšeretsk de l'Isle de la Croyère e Steller. Krašeninnikov, dopo tre anni di esplorazione solitaria, si ritrovò all'improvviso nei panni dello studente. Il tedesco infatti era stato incaricato di prendere il comando delle operazioni in Kamčatka e non senza arroganza ordinò al giovane russo di consegnargli i suoi materiali e di obbedire ai suoi ordini. Nell'inverno del 1740, Krašeninnikov mosse ancora una volta a nord, con l'intento di studiare i Coriachi (stanziati a nord della Kamčatka) e ebbe modo di osservare l'eruzione del vulcano Tolbačik. Tra l'inverno e la primavera del 1741, esplorò insieme a Steller la zona a sud di Bolšeretsk; durante questo viaggio, furono i primi naturalisti a vedere un raro mammifero marino poi denominato "leone marino di Steller", Eumotopias jubatus. Nel frattempo però erano giunti nuovi ordini da San Pietroburgo e Steller ingiunse a Krašeninnikov di raggiungere Gmelin e Müller in Siberia e di rientrare con loro nella capitale. Krašeninnikov l'accademico Krašeninnikov obbedì, ma senza fretta. Lasciata la penisola nel giugno 1741, arrivò a Turinsk, dove lo aspettavano i professori, solo ad ottobre, muovendosi lentamente per arricchire le sue collezioni. Insieme ai suoi maestri, svernò a Yakutsk, dove si sposò con la figlia del governatore locale. Ripercorrendo in parte il cammino dell'andata per completare le raccolte e le osservazioni, il gruppo, che ora includeva anche la neosposa, giunse finalmente a San Pietroburgo nel febbraio 1743. La lunga avventura in Oriente aveva fornito allo studioso russo gli strumenti e le credenziali per entrare nel mondo accademico. Due mesi dopo il suo ritorno, insieme ad altri studenti che avevano partecipato alla spedizione, sostenne un esame orale di botanica e latino, di fronte a una commissione costituita da Gmelin e da Siegesbeck, all'epoca curatore dell'orto botanico dell'Accademia. Nel 1745 venne accolto nell'Accademia come professore aggiunto, discutendo una tesi di dottorato su alcuni pesci della Kamčatka; iniziò anche a lavorare all'orto botanico come assistente di Siegesbeck, che poi sostituì quando questi fu costretto a dimettersi (1747). Krašeninnikov divenne così uno dei primi membri russi dell'Accademia delle scienze. Nel 1749 fece parte della commissione incaricata di respingere le "scandalose" tesi dell'antico maestro Müller, che aveva sostenuto (a ragione) l'origine vichinga dei fondatori della Russia, che egli respinse con forza insieme a Lomonosov e altri studiosi russi. Nel 1750 divenne titolare della cattedra di botanica e scienze naturali e qualche mese dopo fu nominato rettore dell'Università. Intanto, nel 1745 Steller era morto in Siberia, lasciando un manoscritto tanto ricco quanto indecifrabile, in cui al latino si alternavano il russo e il tedesco. L'Accademia decise di consegnarlo a Krašeninnikov, l'unica persona in grado di venirne a capo, per il perfetto dominio delle tre lingue, la sua lunga esperienza in Kamčatka e la collaborazione con lo stesso Steller. Integrando le note del tedesco con le proprie copiose osservazioni, intorno al 1748 Krašeninnikov incominciò così a scrivere un'opera sulla Kamčatka, che uscì nel 1755, poco dopo la sua morte, con il titolo di Opisanie zemli Kamčatki, "Descrizione della terra di Kamčatka". Di carattere enciclopedico, è divisa in due tomi, il primo dedicato alla geografia, alla fauna e alla flora, il secondo alla storia, alla cultura e alle lingue dei popoli nativi. Il primo tomo si apre con una sezione sulle caratteristiche generali della penisola e delle terre confinanti, con particolare attenzione ai fiumi; segue una sezione dedicata alla storia naturale, con approfondimenti sui vulcani, i geyser, gli animali e le piante, il commercio delle pellicce di zibellino, le maree. Nel capitolo dedicato alle piante, oltre a descrivere numerose specie fin ad allora sconosciute alla scienza, si dimostra soprattutto attento al loro uso come medicinali o alimenti, sulla base delle informazioni raccolte dai nativi. Analogamente, anche il secondo tomo è diviso in due parti: la prima descrive i popoli della penisola, le loro usanze, le loro lingue; la seconda espone la storia della conquista russa e le condizioni di vita dei russi e dei locali. Incuriosito e a volte indignato dai costumi di questi ultimi, Krašeninnikov oscilla tra la condanna per ciò che gli appare rozzo o lascivo e l'ammirazione per la libertà e la totale sintonia con il mondo naturale. Nazionalista e convinto assertore dell'imperialismo russo, non manca la difesa del "mite" dominio russo, condita con elogi cortigiani dell'imperatrice (all'epoca regnava Elisabetta, la figlia di Pietro). Accanto alla stesura di quest'opera, negli anni di San Pietroburgo, il principale interesse di Krašeninnikov fu la botanica, cui dedicò quasi tutti gli articoli pubblicati negli Atti dell'Accademia delle scienze. Studiò la flora dei dintorni di San Pietroburgo, lasciando un manoscritto che molti anni dopo fornì materiali a Grigorij Sobolevskij per la sua Flora petropolitana (1799). Nel 1752 visitò il lago Ladoga e Novgorod per studiarne la flora; i materiali da lui raccolti, sistemati da David de Gorter seguendo il sistema linneano, vennero pubblicati nel 1761 sotto il titolo Flora ingrica. Probabilmente minato dai lunghi anni trascorsi in Siberia, morì appena quarantaquattrenne, subito dopo aver terminato la prefazione di Opisanie zemli Kamčatki; secondo la testimonianza di un contemporaneo, si spense proprio il giorno in cui terminò la stampa del suo capolavoro. Nel 2015 le sue avventure in Kamčatka sono state raccontate nel documentario Expedition to the End of the Earth con la regia di A. Samoilov. Una sintesi della sua vita come sempre nella sezione biografie.  Krascheninnikovia, una lanosa pianta delle steppe Come pioniere dell'esplorazione della Kamčatka, Krašeninnikov è ricordato da un certo numero di nomi geografici della regione e delle aree limitrofe, come il vulcano Krašeninnikov o la penisola Krašeninnikova. Gli è stato dedicato anche un asteroide e il nome specifico di qualche animale (ad esempio, il salmonide Salvelinus malma krascheninnikova) e di una decina di piante, come Gipsophila krascheninnikovii o Astragalus krascheninnikovii. Nel 1772, un altro grande protagonista dell'esplorazione dell'Impero russo, Johann Anton Güldenstädt (il primo a studiare sistematicamente il Caucaso) volle onorarlo con il genere Krascheninnikovia (famiglia Amaranthaceae). Una seconda dedica giunse molti decenni dopo (1840) da parte del botanico Nikolaj Stepanovič Turčaninov, che intorno agli anni '30 dell'Ottocento ripercorse alcuni dei territori siberiani visitati da Krašeninnikov e dai suoi maestri durante la Grande spedizione del Nord. Anche se la grafia è lievemente diversa, questo genere Krascheninikovia (famiglia Dianthaceae) non è valido per la regola della priorità. Krascheninnikovia Guldenst. è un piccolo genere di arbusti tipico delle steppe aride e fredde dell'emisfero boreale. Il numero di specie è discusso (da uno a tre), perché quella più diffusa, K. ceratoides, è estremamente variabile, con numerose varietà a diffusione locale che in passato sono state considerate specie a sé. Oggi le si riconoscono fondamentalmente due sottospecie: l'euroasiatica K. ceratoides sub. ceratoides e l'americana K. ceratoides sub. lanata. La prima è presente dall'Europa centrale all'Asia nord-orientale, con alcune colonie isolate in Marocco, Egitto e Spagna (relitti di una fase interglaciale a clima più freddo e arido); la seconda negli altopiani e nei deserti freddi dell'America nord-occidentale, dal Canada al Messico settentrionale, con una presenza particolarmente significativa in California. Si tratta di un arbusto o suffrutice alto circa un metro, eretto o prostrato, con piccole foglie tomentose dalle forme assai variabili; le infiorescenze sono dense spighe allungate, con numerosi fiori maschili protetti da grandi brattee lanose e pochi fiori femminili raggruppati in posizione terminale, con brattee più piccole. I semi sono provvisti di lunghi peli setosi bianchi che ne favoriscono la dispersione grazie al vento. La sottospecie americana, nota con il nome comune winter fat, ha un ruolo ecologico molto importante come foraggio per gli erbivori selvatici soprattutto nella stagione invernale. Oggi è talvolta anche coltivata per la bellezza delle foglie argentee, ma anche per le soffici fioriture. Qualche approfondimento nella scheda. Se il professor Moris poté completare la ricognizione della flora sarda nonostante i crescenti impegni accademici e politici lo trattenessero a Torino, gran parte del merito va al giardiniere Domenico Lisa, che lo sostituì nel lavoro sul campo. Non minore fu il contributo di Maddalena Lisa Mussino, moglie di Domenico, che disegnò e dipinse la maggior parte delle illustrazioni di Flora sardoa. Questa grande artista fu l'ultima esponente dello straordinario gruppo di disegnatori che tra il 1753 e 1868 realizzò un'opera che ha pochi uguali nella storia dell'illustrazione botanica, Iconographia taurinensis. A Domenico - ma io credo un po' anche a Maddalena - è stato dedicato il genere Lisaea. 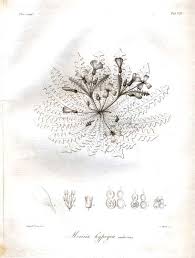 Le raccolte di Domenico... Nella primavera del 1828, il professor Moris, ammalato, lasciò la Sardegna per andare a curarsi in Piemonte. A continuare le ricerche rimase però Domenico Lisa, che già era stato suo compagno nelle spedizioni dei due anni precedenti. Nell'estate di quell'anno Lisa visitò il nord dell'isola, un'area che era rimasta fuori dalle escursioni di Moris, rientrando poi a Cagliari attraverso l'altopiano centrale. Tra le località toccate nel suo ampio giro, Porto Torres, Alghero, Nurra, Porto Conte, Asinara, Sassari, l'isola della Maddalena, Vignola, Tempio, Luogosanto, il monte Limbara, Olbia, Tavolara, il Monte Albo di Siniscola, Orosei, Galtellì, Nuoro, il Monte d’Oliena, Tonara, Monti di Sadali e Maracalagonis, Serrenti. Negli anni successivi, Lisa tornò almeno altre tre volte in Sardegna. Nel 1837 visitò le isole di Maddalena, Budelli, Barrentini. Nel 1840, partendo questa volta da Porto Torres anziché da Cagliari, tornò a percorrere la Sardegna settentrionale e centro-settentrionale, dedicando però maggiore attenzione alla costa (zona malsana per la malaria) e alle isole minori. Le località citate nel suo itinerario sono Porto Torres, Sassari, Scala di Giocca, Torralba, Tempio, Aggius, Limbara, La Maddalena, l'isola dei Cappuccini, Olbia, Capo Figari, le isole di Figarolo e Tavolara, S. Teodoro, Siniscola, il Monte Albo, Orosei, Galtellì, Nuoro, il Monte d’Oliena, Orgosolo, Urzulei, con rientro a Porto Torres attraverso Aggius, Limbara, Tempio, Torralba, Sassari. Nel 1852 Moris lo inviò un'ultima volta in Sardegna, per completare le ricerche in vista del terzo volume di Flora sardoa. Le zone citate per questa spedizione sono Bonorva, Silanus, Nuoro, Galtellì, Onifai, Orosei, Dorgali e le sue montagne, Flumineddu di Dorgali, il Monte d’Oliena, Orgosolo, Urzulei, i monti di Nuraminis. Indubbiamente il contributo di Lisa fu importante, e Moris lo riconobbe esplicitamente sia citandolo con elogio nella prefazione di Flora sardoa sia dedicandogli Oenanthe lisae, un endemismo sardo noto come finocchio acquatico. Ma non fu il solo merito del giardiniere torinese, che continuava degnamente la tradizione dei colti erbolai dell'orto del Valentino. Entrato in servizio nel 1821, oltre che all'esplorazione della Sardegna partecipò anche alla ricognizione floristica delle valli piemontesi. Nel 1852 divenne custode e giardiniere capo, carica che mantenne fino alla morte nel 1862. Curò con competenza le collezioni di fanerogame del giardino e l'allestimento degli esemplari dell'erbario. Come botanico, si interessò a un gruppo di piante allora ancora poco studiato, i muschi, dedicando loro una monografia (Elenco dei muschi raccolti nei dintorni di Torino, 1837). Allestì anche un erbario personale ricco di circa 2000 esemplari che alla sua morte volle legare all'istituzione dove aveva servito per quarant'anni. Una sintesi della sua vita nella sezione biografie. 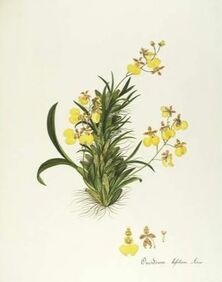 ... e gli acquarelli di Maddalena Ma è ora di parlare di un altro membro della famiglia Lisa il cui contributo a Flora Sardoa non fu meno importante. Mi riferisco a Maddalena Lisa Mussino (1805-1869), moglie di Domenico e autrice della maggior parte delle tavole che illustrano l'opera. Grazie a lei, facciamo un breve excursus sugli illustratori botanici che operarono nell'arco di un secolo e mezzo presso l'orto torinese, creando quella splendida opera collettiva che va sotto il nome di Iconographia taurinensis. Si tratta di 7470 tavole disegnate e acquarellate, raccolte in 64 volumi, che illustrano le piante coltivate nel giardino botanico torinese oppure le specie di nuova scoperta. L'idea di far ritrarre le piante del Regio orto botanico fu del primo direttore, Bartolomeo Caccia, che fece venire da Milano il pittore botanico Giovanni Battista Morandi, il quale realizzò circa quattrocento tavole acquarellate. Tuttavia, Iconographia taurinensis esordì ufficialmente solo nel 1752, grazie a Vitaliano Donati, che affidò la realizzazione delle tavole a Francesco Peyroleri (1710?-1783). Come ho già raccontato in questo post, Peyroleri era un vero fils du jardin; entrato al servizio dell'istituzione torinese da ragazzo come garzone, aveva sviluppato un notevole talento per il disegno, tanto che proprio per lui fu creata la nuova figura professionale di "disegnatore delle cose botaniche" o "olitore botanico". Fu attivo almeno fino al 1773, operando al fianco prima di Donati e poi di Allioni, per il quale disegno anche le tavole di Flora pedemontana. Con Peyroleri, Iconographia taurinensis (cui contribuì con diverse migliaia di tavole) divenne un affare di famiglia; Francesco fu affiancato dal figlio, che dipinse alcune tavole ma poi si specializzò nell'incisione, e dal nipote Giovanni Battista Bottione. Istruito dallo zio, Bottione gli succedette nel 1783 e fu attivo fino a fine secolo. A sua volta egli insegnò il mestiere alla figlia Angela Maria (che preferiva firmarsi Angelica), sposata Rossi, cui l'incarico fu affidato ufficialmente nel 1807. E finalmente entra in scena la nostra Maddalena Mussino; nata nel 1805, arrivò al giardino botanico poco più che bambina nel 1816 come apprendista della cugina Angela. Le prime tavole che possiamo attribuire a lei con una certa sicurezza risalgono al 1825. Da quel momento per un decennio affiancò la maestra (sono opera comune i volumi XLIX-LIV), fino al 1838 quando le subentrò come disegnatrice. Il suo contratto prevedeva l'esecuzione di quaranta disegni ogni anno, ritraendo dal vero in particolare le specie esotiche che fiorivano nelle serre del Giardino. Si devono integralmente alla sua mano i volumi LV-LXIV, per un totale di oltre 1200 tavole. Alla sua morte, nel 1868, il ruolo di disegnatore fu soppresso, e con esso ebbe termine anche Iconographia taurinensis. La collaborazione di Maddalena con Moris per quella che sarà Flora sardoa inizia nel 1827. Sulla base di alcune lettere di Moris, risulta che la giovane donna raggiunse il marito a Cagliari nella primavera di quell'anno e si trattenne nell'isola almeno fino a settembre; con grande soddisfazione del professore, ritrasse dal vero con grande esattezza una cinquantina di specie nuove o non presenti nell'iconografia. Quando poi Moris allestì Flora sardoa, Maddalena contribuì con 81 delle 111 tavole. I suoi disegni si distinguono per la finezza e la precisione del tratto, non disgiunte da una certa freschezza. Va anche sottolineato che fu la prima artista del gruppo torinese ad affiancare ai tradizionali pigmenti naturali alcuni pigmenti artificiali, come possiamo anche rilevare dai colori luminosi e brillanti dei suoi acquarelli.  Una dedica ambigua Nel 1844 Pierre Edmond Boissier, un botanico svizzero allievo di de Candolle, dedicò a Domenico Lisa il genere Lisaea. Al solo Domenico? La motivazione desta qualche perplessità: "Dedicato all'illustre Lisa benemerito per i suoi studi sui muschi italiani, illustratore della flora piemontese e sarda". Come andrà inteso il latino illustrator? in senso reale o metaforico? Viene il sospetto che Boissier abbia confuso marito e moglie; è strano, visto che era di casa in Italia ed era passato anche da Torino. In ogni caso, il dedicatario ufficiale è Domenico, e a questo mi attengo, anche se vorrei difendere la causa di Maddalena. Il genere Lisaea, della famiglia Apiaceae, poco noto e non molto studiato, comprende tre specie di annuali erbacee diffuse tra il Mediterraneo orientale e l'area irano-caucasica, in ambienti aridi anche d'altura. Hanno foglie pinnate, fiori solitamente bianchi e caratteristici frutti spinosi che li distinguono dai generi affini come Turgenia. Qualche informazione in più nella scheda. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
March 2024
Categorie
All
|
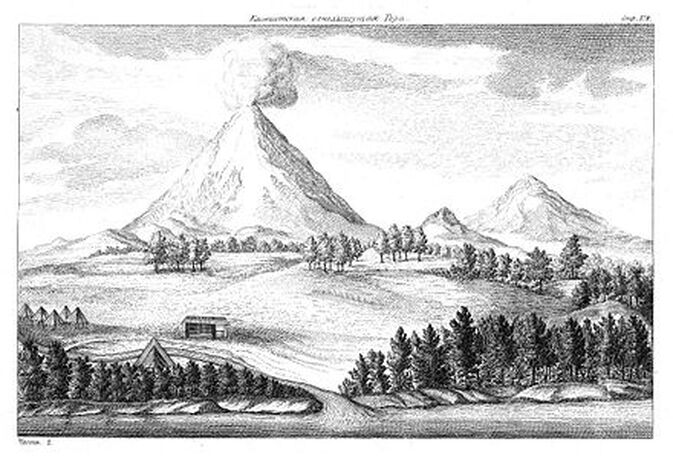
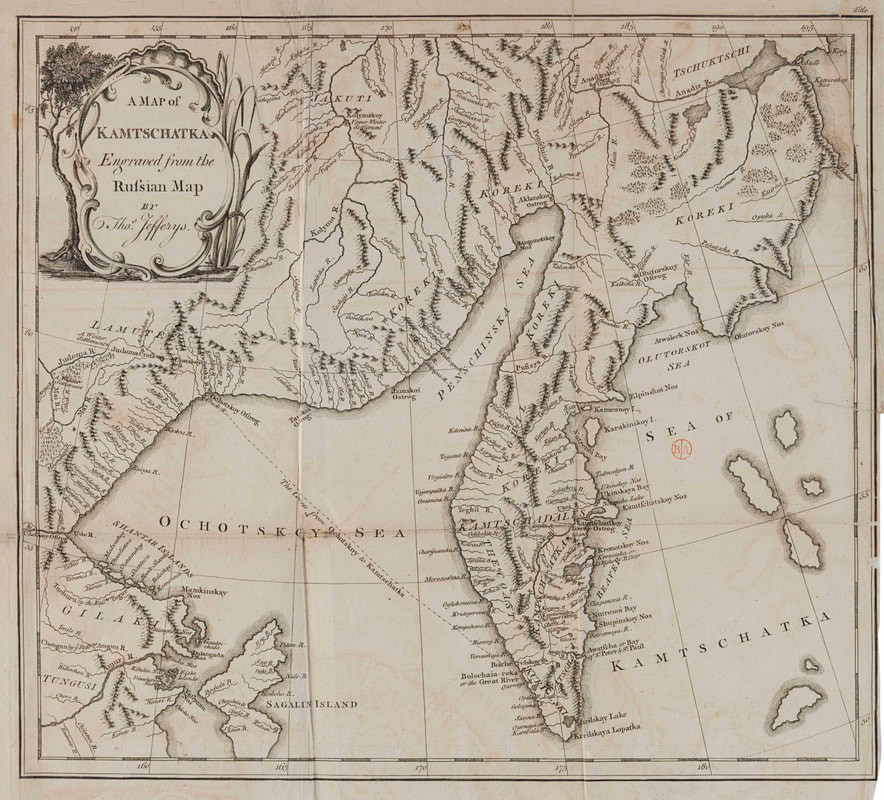
 RSS Feed
RSS Feed