|
Nella prima metà dell'Ottocento, il numero di piante esotiche coltivate in Europa cresce esponenzialmente. Orti botanici, grandi vivai, istituzioni scientifiche sono in prima fila per inviare alla loro ricerca cacciatori di piante; ma ci sono anche raccoglitori indipendenti desiderosi di piazzare le loro scoperte (siano semi o esemplari d'erbario) ad un prezzo accettabile. A mettere in contatto raccoglitori e potenziali acquirenti - siano essi privati o istituzioni - e a mediare tra le loro esigenze si inserisce una nuova figura professionale: l'agente botanico. A rappresentarla nel modo migliore, stando alle testimonianze, dovette essere l'eccellente John Hunneman, dedicatario del genere Hunnemannia.  Come un libraio inventò un nuovo mestiere Nel 1827, una settimana prima di Natale, Johann Heinrich Friedrich Link, direttore dell'orto botanico di Berlino, scrive al suo omologo di Kew, William Jackson Hooker, per informarlo che, avendo saputo che era alla ricerca di semi di Nelumbo speciosum [oggi N. nucifera, il loto], ha raccolto per lui tutti quelli disponibili e glieli ha inviati, insieme a semi di Euryale ferox e alcuni altri che coltiva nel suo giardino, tramite Mr John Hunneman, 9 Queen Street, Soho Square, Londra. La cortese lettera di Link, oggi conservata nell'archivio dei Kew Gardens, è solo una delle numerose testimonianze della preziosa attività di mediazione svolta dal libraio e agente botanico John Hunneman (ca. 1760-1839) . Anche se oggi non conosciamo molto della sua vita personale, il nome di Hunneman (scritto anche Hunnemann e talvolta Hunneyman) era ben noto negli ambienti botanici della prima metà dell'Ottocento, e ricorre frequentemente nella corrispondenza e nelle riviste dell'epoca. Anche se era presumibilmente nato a Londra, come si può dedurre dal cognome era di origine tedesca, forse parente del pittore Christopher William Hunneman, che negli ultimi anni del Settecento viveva a Soho Square dove, come si legge nella lettera di Link, si trovava anche la libreria di John Hunneman. Il negozio era specializzato in testi di botanica, soprattutto importati dal continente, ma Hunneman aveva anche clienti all'estero cui procurava libri e riviste inglesi. Era particolarmente abile a trovare per gli uni e gli altri testi rari. In tal modo egli venne a trovarsi al centro di una rete di scambi tra botanici britannici e continentali; godeva di fama di grande affidabilità e a un certo punto oltre ai libri incominciò a trattare stampe botaniche, esemplari d'erbario e parcelle di piante vive. Almeno dal 1816 organizzò diversi ingenti trasporti di piante - in gran parte provenienti dai vivai Loddiges o in subordine da vivai tedeschi - per il parco e le serre di Eisenstadt come "agente botanico e orticolo" del principe Esterházy. Dai documenti conservati nell'archivio del genero William Pamplin, che fu suo stretto collaboratore e alla sua morte ne proseguì l'attività, a partire dal 1817 risultano pagamenti da parte di Christoff Friedrich Otto, ispettore dell'orto botanico di Berlino, per invii di piante e semi provenienti da vari vivai inglesi. Ma almeno dagli anni '20 il ruolo più tipico di Hunneman fu quello di "agente botanico" che metteva i raccoglitori di piante indipendenti in contatto con i possibili acquirenti, curandosi degli invii e dei trasporti e del rispetto dei contratti e dei pagamenti. Come tale figura in un'inserzione pubblicata nel 1829 su The Gardener's magazine in cui si comunica che un certo Mr. Fanning "proprietario dell'orto botanico di Caracas" ha portato con sé varie piante "molte delle quali nuove per questo paese"; entro poche settimane sarebbe rientrato a Caracas, ma "nel frattempo, sarebbe stato felice di entrare in corrispondenza con i naturalisti interessati. Il suo agente è Mr. Hunneman di Queen Street, Soho". Sappiamo che almeno alcuni di quegli esemplari furono acquistati da Lambert, nel cui erbario si trovano ancora. Tra i botanici-raccoglitori, il suo cliente più celebre è senza dubbio Nathaniel Wallich, che, tra la fine degli anni '20 e gli anni '30, grazie alla sua mediazione riuscì a vendere esemplari d'erbario agli orti botanici di Berlino, Liverpool, Londra ed Edimburgo, nonché a collezionisti privati. Probabilmente era entrato in contatto con lui attraverso William Jackson Hooker, quando questi era ancora professore a Glasgow. Infatti in The American journal of science and arts del 1820 leggiamo l'annuncio della prossima pubblicazione di due volumi in folio dedicati alle felci dell'India orientale, curati da Hooker e basati su raccolte di Wallich e Wight; a ricevere le sottoscrizioni dall'estero sarà "John Hunneman, Esq., No. 9 Queen street, London". Il volume non uscì mai e non sappiamo se Hunneman era stato coinvolto anche come potenziale editore; come tale figura invece nel frontespizio del secondo e del terzo volume di The genera and species of orchidaceous plants di John Lindley. Insomma, seppe rendersi indispensabile in vari modi ai botanici al di qua e al di là della Manica, come è evidente dal necrologio pubblicato dopo la sua morte nel 1839 sulla rivista della Botanical society: "Dobbiamo lamentare [...] la morte del nostro eccellente socio Mr John Hunneman. Non potrebbe esistere persona che più volentieri si prendesse ogni genere e grado di disturbo per compiacere i suoi amici e per stabilire utili scambi tra i botanici europei; [...] la sua perdita sarà un grave ostacolo alla libera comunicazione che da molti anni esiste tra loro. Era conosciuto da tutti, amato da tutti, e quella reciprocità di gentilezza che aveva il diritto di aspettarsi la rivolgeva spontaneamente a ogni botanico che desiderava introdurre nella confraternita scientifica che aveva fondato e che desiderava allargare".  Papaveri d'oro dal Messico La medesima stima, riconoscenza ed ammirazione era stata espressa qualche anno prima (1828) da Robert Sweet nel terzo volume di The British flower garden nel dedicare al libraio e agente botanico il genere Hunnemannia: "Lo abbiamo nominato in onore del nostro amico Mr John Hunnemann, il quale, attraverso i suoi numerosi corrispondenti in vari paesi, è stato strumentale all'introduzione nelle nostre collezioni di un numero di piante maggiore di ogni altro individuo, tanto che siamo un po' sorpresi che nessun genere gli sia stato dedicato in precedenza". Per creare il nuovo genere, Sweet si basò su una pianta di cui aveva ricevuto i semi da Robert Barclay, un ricco birraio e proprietario di un raffinato giardino, il quale a sua volta li aveva ricevuti dal Messico. Si tratta di Hunnemannia fumariifolia, una della due specie di questo genere della famiglia Papaveraceae; a lungo è stata l'unica nota. Affine a Eschscholzia, è un papavero piuttosto alto con grandi fiori dorati a coppa e foglie glauche finemente divise, endemico degli altipiani del Messico (deserto di Chihuahua e Sierra madre orientale) tra 1500 e 2000 metri di altitudine. Relativamente rustico, è una perenne di breve vita solitamente coltivata come annuale. La seconda specie, Hunnemannia hintoniorum, fu scoperta e pubblicata solo nel 1992. Endemica del Nuevo León, differisce dalla precedente perché più bassa, scaposa, con fusti non ramificati e foglie più strette e limitate alla rosetta basale.
0 Comments
Creato nel 1902, il Big Basin Redwoods State Park è il più antico della California. La sua nascita si deve alla battaglia di un gruppo di cittadini, con il sostegno dell'università di Stanford e del capo del suo dipartimento di botanica, William Russell Dudley, che ebbe un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di una delle meraviglie della natura, la sequoia della California (Sequoia sempervirens), che in meno di un secolo era stata portata alla soglia dell'estinzione dagli abbattimenti indiscriminati. Dudley era uno specialista di conifere e un appassionato raccoglitore; gli si deve la fondazione dell'erbario Dudley. A ricordarlo, il genere Dudleya, endemico dell'Oregon, della California e della Baja California. 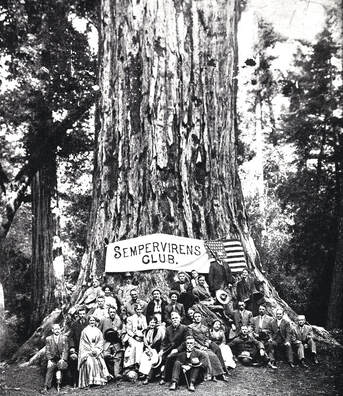 Salvare le sequoie Nell'ottobre 1899, un incendio scoppiò nei boschi delle Montagne di Santa Cruz presso Felton in California. Presto raggiunse le case di Wrights Station e l'azienda vinicola Mare Vista Winery; per scongiurare lo scoppio di un serbatoio di gas, il proprietario non esitò ad ordinare ai suoi dipendenti di estinguere le fiamme con 4000 galloni di vino rosé. Il fatto era abbastanza curioso da attirare l'attenzione della rivista inglese The Wide World Magazine che commissionò un articolo a C.F. Holder, presidente dell'accademia delle scienze della California, il quale chiese al noto fotografo e pittore californiano Andrew P. Hill di illustrarlo con le sue fotografie. Hill, oltre all'area devastata, per mostrare il contrasto, pensò di scattare qualche fotografia alle maestose sequoie (Sequoia sempervirens) secolari di un parco privato, il Welch’s Big Trees Grove (oggi parte dell'Henry Cowell State Park); aveva appena sistemato il suo cavalletto e scattato tre foto, quando arrivò l'infuriato proprietario che pretese i negativi, sostenendo che quelle foto avrebbero danneggiato la sua vendita di cartoline ai turisti. Hill ribatté che le fotografie erano per una rivista straniera e, anzi, sarebbero state un'ottima pubblicità. L'altro gli ripose piccato che la pubblicità non gli interessava, perché presto quegli alberi sarebbero diventati traversine ferroviarie e legna da ardere. La risposta sconvolse e indignò Hill: come, quella meraviglia della natura era destinata a perire? Da quel momento, salvare le sequoie della California divenne lo scopo della sua vita. Convinse due amici, l'avvocato e poeta di San Jose John E. Richard e la scrittrice Josephine Clifford McCrackin, che aveva perso la casa nell'incendio di Wrights Station, a denunciare la situazione sui giornali locali. Nel marzo 1900 McCrackin scrisse una lettera aperta al Sentinel di Santa Cruz intitolata "Salviamo gli alberi" che fu il primo atto pubblico della campagna. Il secondo fu una riunione convocata il 1 maggio 1900 da Hill e dal presidente dell'ateneo di Stanford David Starr Jordan nella biblioteca dell'Università, per discutere azioni concrete per salvare le sequoie. Durante la riunione emerse che i naturalisti dell'università avevano già individuato come area più adatta alla nascita di un parco naturale il Big Basin (molto più vasto e con alberi più grandi e antichi rispetto al bosco di Felton) e fu deciso di inviarvi in esplorazione un comitato, che includeva giornalisti, uomini d'affari e politici, presieduto da Hill e da Carrie Stevens Walter del San Jose Woman's Club. Due settimane dopo il gruppo visitò l'area e decise di costituirsi in associazione, denominata Sempervirens club dall'eponimo di Sequoia sempervirens, con un capitale iniziale di 32 dollari, raccolti facendo passare un cappello tra i presenti. Come presidente fu scelto l'avvocato di San Francisco Charles Wesley Reed, che contava diversi appoggi politici, affiancato da varie personalità più o meno eminenti come vicepresidenti onorari. A rappresentare la scienza, William Russell Dudley (1849-1911), capo del dipartimento di botanica sistematica di Stanford, che aveva partecipato al meeting del 1 maggio e da tempo denunciava i rischi di estinzione della sequoia della California. Dudley era cresciuto in una fattoria del Connecticut e fin da bambino si era innamorato della natura; ventunenne si iscrisse alla Cornell University, dove per qualche tempo si pagò gli studi mungendo le mucche della fattoria universitaria. Caso volle che suo compagno di stanza fosse David Starr Jordan che abbiamo già incontrato nelle vesti di presidente dell'università di Stanford; David divenne ittiologo, mentre Willie (come lo chiamavano in famiglia) scelse la botanica. Già prima di laurearsi fu lettore di botanica alla Cornell, che lo utilizzò anche come raccoglitore. Dopo essersi laureato nel 1876, si perfezionò per qualche tempo a Strasburgo e Berlino, dopo di che insegnò botanica alla Cornell fino al 1892, quando venne nominato a Stanford, dove prese servizio nell'autunno 1893, reclutato dall'amico Jordan che era appena stato scelto come presidente del neonato ateneo. Il dipartimento di botanica era tutto da inventare, non c'erano né strutture né laboratori, ma per Dudley, che fino ad allora si era occupato della flora degli Stati uniti orientali (i suoi principali lavori riguardavano le flore della contea di Cayuga, della contea di Lackawanna e del Wyoming) ogni fatica era ricompensata dalla ricchissima flora californiana. Il suo più grande amore divennero gli alberi, in particolare le conifere, di cui studiò le relazioni evolutive e la distribuzione geografica. Era facile incontrarlo con i suoi studenti in escursioni botaniche in varie parti dello stato, specialmente nella Sierra Nevada e nella Sierra Santa Lucia. Più conosceva la flora californiana, più crescevano le sue raccolte (oggi formano il nucleo principale del Dudley Herbarium dell'Università di Stanford) ma anche la consapevolezza della devastazione degli habitat naturali e la preoccupazione per gli alberi minacciati dalla speculazione. Nel 1892 fu uno dei primi membri del Sierra Club, una delle primissime associazioni ambientaliste, fondata da John Muir per proteggere la Sierra Nevada e i suoi boschi di sequoie giganti Sequoiodendron giganteum. Nel 1895, insieme allo stesso Muir e al geologo di Berkeley Joseph Le Conte, fu uno dei portavoce del club in un forum pubblico tenutosi a San Francisco sul tema "Parchi nazionali e riserve forestali", in cui sostenne che bisognava cessare di cedere a privati le terre demaniali, che andavano invece convertite in parchi nazionali. In un articolo pubblicato sul bollettino del Sierra club tra la fine del 1895 e l'inizio del 1896, riferì che le sue indagini sul campo dimostravano che i due milioni di acri di sequoie che un tempo si estendevano per cinquecento miglia lungo le colline costiere dell'Oregon e della California stavano scomparendo a un ritmo tale che l'antica specie rischiava l'estinzione. Insieme a un collega di Stanford, il docente di ingegneria civile Charles Wing, visitò e mappò l'area del Big Basin, scoprendo che i migliori boschi di sequoie erano stati venduti a compagnie di legname e decimati. L'unico modo per salvarli era acquistare i boschi e trasformarli in un parco statale, e l'area più adatta era proprio il Big Basin, che la distanza dalla ferrovia e le peculiarità topografiche avevano preservato pressoché intatto; tuttavia, i boscaioli avevano già iniziato il loro lavoro e, se non venivano fermati, scrisse in un articolo pubblicato nel marzo 1900, entro due anni "la regione, invece di un Eden, diventerà peggio del Sahara". Nella fatidica riunione del maggio 1900 nella biblioteca di Stanford, l'indignazione di Hill e la competenza di Dudley si incontrarono. Tra l'estate e l'autunno la campagna per salvare le sequoie del Big Basin prese il volo, con ogni membro del club impegnato a suo modo per smuovere l'opinione pubblica, coinvolgere altre associazioni, arruolare politici e convincere gli industriali che i turisti attirati dal parco avrebbero portato più soldi dello sfruttamento del legname. L'argomentazione fece breccia almeno su Henry L. Middleton che si dichiarò disposto a vendere i 14000 acri che la sua compagnia possedeva nel Big Basin offrendone al club l'opzione di acquisto per un anno. Dudley, che da tempo era membro dell'American Forestry Association, fece da tramite con il servizio forestale nazionale e ottenne l'appoggio del suo capo, Gifford Pinchot. Reed scrisse una proposta di legge per l'istituzione di un parco statale che nel gennaio 1901 fu presentata all'Assemblea dello Stato della California da un politico amico; respinta nella forma iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 500.000 dollari per l'acquisto di 5000 acri, fu approvata quando venne ridotta a 250.000 dollari e a 2500 acri. Era una grandissima delusione per il Sempervirens club che puntava su un grande parco da 35.000 a 60.000 acri; anche Dudley riteneva che "per gli scopi scientifici, e anche per un buon parco pubblico" il minimo fossero 35.000 acri. L'istituzione del California Redwood Park (dal 1927 avrebbe mutato nome in Big Basin Redwoods State Park) venne approvata dal senato con voto quasi unanime nel marzo 1901. Per presiedere alla sua realizzazione, venne creata una commissione, formata dal governatore e da quattro membri di sua nomina, tra cui il professor Dudley, che ne fu il segretario fino allo scioglimento nel 1905. Finalmente, nel settembre 1902, con l'acquisto di 2500 acri di foresta, più 800 acri di chaparral e 500 acri di terreno da riforestare donati da Middleton, il parco divenne realtà. Molto più piccolo di quanto sperato, era comunque un inizio, nonché il primo dei circa 280 tra parchi statali e riserve naturali che oggi esistono in California. Il Sempervirens Club non si sciolse, ma continuò la sua battaglia per estenderne i limiti. Negli anni successivi arrivarono piccole donazioni di altri terreni e nel 1916 il parco incorporò quasi 4000 acri convertiti da terre federali, estendendosi così fino alla costa. Oggi la sua estensione è di 10,800 acri (44 Km2). Oltre ad ospitare il più grande gruppo di Sequoia sempervirens a sud di San Francisco, include una varietà di ambienti che vanno dalle foreste miste di sequoie, altre conifere e querce al chaparral, ai canyon umidi, alla vegetazione costiera, estendendosi dal livello del mare a circa 600 metri di altitudine. Purtroppo nell'agosto 2020 è stato catastroficamente investito dagli incendi che hanno devastato la California settentrionale; sono andate distrutte tutte le strutture del parco e almeno 15.000 alberi, principalmente abeti di Douglas. Anche alcune sequoie sono cadute, ma la maggior parte di quelle più antiche sono rimaste in piedi. Dopo essere rimasto chiuso per due anni, oggi il parco è di nuovo aperto, sebbene in modo limitato. Il paesaggio ha mutato volto ma, secondo gli esperti sta lentamente recuperando. La maggior parte delle sequoie è sopravvissuta, e dai tronchi anneriti dall'incendio stanno rispuntando ciuffi di fogliame. Non è certo la prima volta che questi antichi giganti affrontano il fuoco: si sono evoluti con gli incendi e si riprendono molto più facilmente di altre specie, grazie alla corteccia spessa più di 30 cm che protegge gli strati più interni dal fuoco, ai tannini che proteggono le eventuali ferite dagli attacchi di funghi e insetti, alle gemme dormienti sia alla base sia lungo il tronco e i rami che permettono loro sia di emettere germogli basali sia di rigermogliare dai rami e dallo stesso tronco.  Perché i botanici cambiano i nomi: il caso di Dudleya Ma è ora di ritornare al prof. Dudley che tanto fece per far nascere il parco. Anche negli anni successivi continuò ad impegnarsi nelle battaglie ambientaliste. Nel 1904, insieme all'amico Jordan e alla botanica Alice Eastwood, partecipò a una manifestazione indetta a San Francisco dal California Club per bloccare la vendita di 1000 acri di foresta contenenti antiche sequoie ai piedi del Monte Tamalpais. Era un insegnante innamorato della sua materia e amato dagli studenti e nei suoi 18 anni di insegnamento a Stanford formò intere generazioni di eccellenti botanici; era uno studioso coscienzioso, ma forse fin troppo autocritico e forse per questo le sue pubblicazioni californiane si limitano ai numerosi articoli, dedicati soprattutto alle foreste e agli alberi della California, che egli pubblicò tra il 1889 e il 1910 sul Bollettino del Sierra Club e su The Forester, la rivista dell'American Forestry Association. Progettò a lungo un lavoro complessivo sulle conifere degli Stati Uniti occidentali, ma il progetto non andò mai oltre lo stadio di manoscritto incompleto. Nel 1908 andò Persia per esplorarne le foreste; in Egitto contrasse una grave bronchite che degenerò in tubercolosi, che nel 1910 lo costrinse a lasciare l'insegnamento e nel 1911 lo portò alla morte. Grande esploratore della flora californiana, è ricordato dall'eponimo di vari funghi (fu anche micologo) e di piante come gli endemismi Triteleya dudleyi, Pedicularis dudleyi e Polystichum dudleyi. Nel 1903 Britton e Rose gli dedicarono il genere Dudleya, endemico di ambienti rocciosi lungo la costa pacifica, dall'Oregon meridionale alla Baja California settentrionale, con una laconica nota: "Nominato in onore del prof. William R. Dudley della Stanford University". Questo genere di una cinquantina di piante succulente della famiglia Crassulaceae è caratterizzato da una grande varietà morfologica (dalle piccole geofite decidue alte pochi cm alle grandi sempreverdi con rosette di 50 cm di diametro), con fiori a stella simili a quelli di Sedum, oppure tubolari o amcora pendenti e campanuliformi come quelli di Echeveria. Solo recentemente tanta varietà è stata ricondotta a un unico genere, mentre i primi botanici che si occuparono di queste piante le attribuirono variamente ai generi Echeveria, Cotyledon e Sedum. Queste incertezze sono perfettamente testimoniate da Dudleya cespitosa, una geofita tuberosa endemica della California meridionale, la prima ad essere descritta. Nel 1803 Haworth la pubblicò come Cotyledon cespitosum, mentre nel 1811 von Jacquin la classificò come Sedum cotyledon e Aiton come Cotyledon linguiformis. Altre due specie, Dudleya pulverulenta e D. lanceolata, furono invece pubblicate nel 1840 da Nuttall come Echeveria pulverulenta e E. lanceolata. All'inizio del Novecento una vera rivoluzione fu attuata da Nelson e Rose che sistemarono questo gruppo di piante in ben tre nuovi generi: Dudleya, cui attribuirono una sessantina di specie, 40 delle quali descritte da loro per la prima volta, Stylophyllum con 12 specie, e Hasseanthus con 4 specie. Negli anni '30, Alwin Berger li ritenne tutti e tre superflui, spostando Dudleya e Stylophyllum in Echeveria e Hasseanthus in Sedum, i due generi da cui riteneva si fossero rispettivamente evoluti. Le sue conclusioni furono largamente accettate dai botanici fino alla metà del Novecento, quando incominciarono ad apparire le prime analisi filogenetiche molecolari. Nel 1942, Reid Moran separò nuovamente Dudleya e Stylophyllum da Echeveria, riunendoli in Dudleya come sottogeneri; mantenne Hasseanthus come genere distinto, ma strettamente imparentato. Fu il punto di partenza delle ricerche successive che hanno dimostrato che Dudleya si è evoluto in epoca relativamente recente (5 milioni di anni fa) da Sedum, non da Echeveria, come si riteneva in precedenza, e va assegnato alla tribù Sedoideae. Anche se rimangono molti punti da chiarire, oggi al variabile genere Dudleya sono assegnate circa 50 specie, divise in tre sottogeneri: Dudleya (Eududleya secondo la terminologia di Moran), caratterizzato da rosette di foglie appiattite e fiori con petali saldati in un tubo; Stylophyllum, caratterizzato da foglie strette che assomigliano a dita o più raramente da foglie piatte, e petali non fusi che si allargano al centro; Hasseanthus, caratterizzato da cormi sotterranei, piccole foglie che cadono dopo la fioritura, fiori ampiamenti diffusi. Le Dudleya in genere si presentano come succulente da piccole a grandi con foglie carnose, in alcune specie appiattite, in altre tubolari, in altre ancora orbicolari, riunite a rosetta; in diverse specie sono ricoperte da un rivestimento ceroso, detto farina, generalmente bianco, gessoso o farinoso; in poche specie a proteggere le piante dal sole è un sottile strato oleoso e appiccicoso. Il colore del fogliame varia dal verde al grigio. Le rosette possono essere solitarie o cespitose, con diverse rosette che partono da un caudex centrale. Mentre, ad eccezione delle specie più grandi, nel resto dell'anno rimangono piuttosto nascoste nelle fessure delle rocce che sono il loro habitat tipico, al momento della fioritura al centro delle rosette emergono uno o più robusti gambi carnosi che in genere si dividono all'apice in divesri rami, ciascuno dei quali portano 10-15 piccoli fiori (o più) comunemente bianchi o gialli, ma anche rosa, arancio o rossi. Nelle specie di maggiori dimensioni, come D. brittonii (non ha caso nota come "giant Dudleya"), la rosetta raggiunge i 50 cm di diametro e l'infiorescenza può arrivare anche a un'ottantina di cm, mentre nelle minuscole specie del sottogenere Hasseanthus come D. brevifolia le foglie rimangono quasi sepolte nella terra e il peduncolo florale non supera i 4 cm. A differenza di Echeveria, con il quale è ancora spesso confuso, Dudleya non è ancora largamente coltivato, ma purtroppo ha attirato fin troppo l'attenzione dei collezionisti: uno dei pericoli maggiori per la sopravvivenza di molte specie, endemiche di aree piuttosto ristrette, è la raccolta indiscriminata in natura di quelle più rare, che vendono vendute a carissimo prezzo soprattutto sul mercato asiatico. Una recente legge ha introdotto una multa di 5000 dollari per ogni esemplare di Dudleya raccolto su suolo pubblico, che salgono a 40.000 alla seconda infrazione. A minacciare le Dudleya sono anche l'espansione degli ambienti urbani e sempre più i cambiamenti climatici, ed in particolare la siccità invernale: ad differenza di altre succulente, sono per lo più originarie di aree con piogge invernali, che è anche la stagione del loro massimo rigoglio, mentre l'estate, quando la temperatura supera i 30°, è la stagione del riposo. Quando ancora non si chiamavano così, l'ungherese János Orlay è stato un cervello in fuga. Quando capì che in patria le sue prospettive erano ben poche, non esitò a cambiare mestiere e a trasferirsi in Russia, dove fece una carriera formidabile, divenendo segretario dell'Accademia di medicina e chirurgia, medico di corte, consigliere imperiale. Uomo dai molteplici interessi, oltre che di medicina si occupò di mineralogia, storia, linguistica, didattica e forse un pochino anche di botanica, Quanto meno, abbastanza da meritare la dedica dell'aereo genere Orlaya.  Come un ex seminarista ungherese divenne medico imperiale Nel 1794, allo Josephinum, l'accademia medica di Vienna voluta da Giuseppe II, si iscrive un perfezionando giunto da San Pietroburgo; si fa chiamare Ivan Orlov e si passa per russo, ma, almeno per gli studenti ungheresi e la comunità magiara della capitale austriaca, nonché per l'occhiuta polizia politica, la sua vera identità è un segreto di Pulcinella: si chiama János Orlay (1770-1829), è un ungherese della Transcarpazia, quindi suddito di sua maestà l'imperatore cesareo. E' a Vienna per completare la sua formazione medica, ma anche per una missione speciale: reclutare intellettuali ungheresi disposti a trasferirsi in Russia, dove promette brillanti prospettive di carriera. E' esattamente ciò che ha fatto lui quando si è reso conto che nella patriarcale, arretrata e cattolica Ungheria esse sono invece ben scarse. Orlay era nato nel 1770 a Palágy, un villaggio nei pressi di Ungvár (oggi Užhorod, in Ucraina), la capitale storica della Rutenia subcarpatica. Palágy era un'enclave ungherese in un'area popolata prevalentemente da slavi di lingua russina o rutena, quindi il bilinguismo e la doppia cultura dovettero essere per lui assolutamente naturali fin dall'infanzia. La sua famiglia era nobile, ma impoverita; il ragazzo, che doveva essere brillante, frequenta le scuole inferiori in diverse località della Transcarpazia. Come era usuale all'epoca per i ragazzi poveri ma dotati, è destinato alla Chiesa; nel 1787, diciassettenne, si iscrive alla facoltà teologica di Leopoli, completa gli studi al Collegio teologico di Eger e al seminario di Pest e nel 1789 entra nell'ordine degli Scolopi. Il suo destino sembra segnato; diventerà sacerdote e insegnante. E infatti già nel 1789, diciannovenne, è assegnato al liceo dei Padri Scolopi di Nagykároly (oggi Carei in Romania) come insegnante di lingue classiche, storia, geografia, aritmetica. Sappiamo che era dotatissimo per le lingue, e scriveva perfettamente tanto l'ungherese quanto il russo. Presto - non sappiamo come e perché - qualcosa si spezza; dopo appena un anno, Orlay chiede di essere trasferito a una scuola laica, ma incontra un netto rifiuto, come fallisce la sua aspirazione a un posto di assistente all'Università di Pest. In questo contesto matura la decisione di imprimere una svolta drastica alla sua vita: il 6 maggio 1791 lo troviamo a San Pietroburgo come borsista presso l'Istituto medico e chirurgico e come tirocinante presso l'ospedale militare. L'arrivo in Russia sarà certo stato preceduto e preparato da contatti, presumibilmente con l'ambasciata a Vienna, ma non ne sappiamo nulla. Orlay János, divenuto Ivan Semënovič Orlov (avrebbe mantenuto questo cognome fino al 1797, per poi tornare a quello originale) nel febbraio 1793 supera l'esame davanti al Collegio medico statale, continua a lavorare all'ospedale militare e incomincia a farsi notare per la sua abilità come medico e per la sua profonda e versatile cultura. Nel settembre dello stesso anno viene nominato vicesegretario scientifico del Collegio medico imperiale (ovvero della facoltà di medicina) e provvede a riordinarne la biblioteca e il gabinetto anatomico. Stringe amicizia con un altro medico immigrato, lo scozzese James Wylie, che presto diventerà medico di corte e metterà mano alla riforma della medicina militare. Forse è proprio grazie a lui che nel luglio 1794 viene inviato a Vienna a perfezionarsi allo Josephinum. Il sedicente Ivan Orlov arriva a Vienna accompagnato da un "cavaliere russo" (come ci informa un rapporto di polizia), per tre anni studia con diligenza e frequenta la comunità ungherese e gli ambienti scientifici; nel 1797 rientra in Russia dove riprende il suo ruolo sia all'ospedale militare sia al Collegio medico. Negli anni successivi la sua carriera procede brillantemente; è medico del reggimento Semenovsky, poi medico dell'ufficio postale di San Pietroburgo, infine dal 1800 chirurgo di corte. In seguito a questa nomina, si dimette dal ruolo di segretario del Collegio medico, anche se continua a collaborare con traduzioni e lavori originali, come quello che nel 1804 dedica agli slavi tra i quali ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza, i russini della Carpazia. I suoi interessi si sono infatti allargati all'etnografia, all'archeologia, alla mineralogia; è via via ammesso a diverse società scientifiche tanto russe quanto tedesche. La sua reputazione scientifica è attestata dagli onori che riceve in occasione di un viaggio all'estero tra il 1805 e il 1806: l'università di Königsberg gli conferisce la laurea honoris causa in lettere, a Dorpat si laurea in medicina e chirurgia con una tesi sulle virtù mediche della natura, a Jena incontra Goethe e diventa membro della Società mineralogica. La carriera medica raggiunge l'apice nel 1805, quando è nominato medico aggiunto dello zar Alessandro I, come primo assistente di Wylie. Nel 1806 lascia il lavoro di medico ospedaliero per affiancare Wylie nella redazione della farmacopea militare russa (Pharmacopoea castrensis Ruthenica) e nella creazione dell'Accademia di Medicina e Chirurgia di San Pietroburgo, di cui diventa segretario scientifico. Nel 1809 è nominato consigliere di collegio e nel 1811 gli è affidata la direzione della rivista dell'Accademia; la pubblicazione è tuttavia sospesa in seguito all'invasione napoleonica. Orlay ritorna a lavorare in ospedale come medico capo e lo fa con tanto zelo che alla fine della guerra lo zar gli conferisce una medaglia e onorificenze degli ordini di San Valdimiro e di Sant'Anna. Nel 1816 è nominato consigliere di stato. Il micidiale clima pietrino sta però minando la sua salute. Nel 1817 si dimette da segretario dell'Accademia, di cui rimane membro onorario, e chiede di essere assegnato un nuovo incarico in una zona più calda; intanto fa un lungo viaggio nel Caucaso, sia per rimettersi, sia con l'obiettivo di cercare la patria degli ungheresi e l'origine della loro lingua. Wylie si oppone a lungo al suo trasferimento e lo sconsiglia di accettare una cattedra alla facoltà di medicina di Mosca; solo nel 1821 è desinato a nuovo incarico: è un ritorno agli 'antichi interessi didattici, con la nomina a preside del neo istituito liceo di Nežyn (oggi Nižyn in Ucraina); tra gli allievi dell'istituto c'è anche il futuro scrittore Nikolaj Gogol'. Orlay si distingue per le capacità amministrative e pedagogiche; nel 1825 è nominato ispettore del distretto di Char'kov (oggi Charkiv in Ucraina), nel gennaio 1826 è promosso consigliere di stato effettivo e traferito come preside al liceo Richeliu di Odessa. In questa città muore nel 1829.  Orlaya, fiori di pizzo Quando fece carriera e poté permetterselo, Orlay creò una vasta biblioteca e una collezione di manoscritti che riflette i suoi molteplici interessi, di cui fece dono alla Società di storia e antichità russe di Mosca. Come medico, certamente anche la botanica non gli era estranea; tra i manoscritti donati, figura anche il resoconto del viaggio negli Altai di Gottlob Schober, un medico che esplorò la Russia meridionale all'epoca di Pietro il Grande. Certo si trattava però di un interesse secondario; sufficiente d'altra parte a farlo definire "botanofilo", assicurandogli la dedicata del genere Orlay da parte del botanico tedesco Georg Franz Hoffmann, un altro membro della "legione straniera" di intellettuali al servizio della Russia: era infatti il direttore del dipartimento di botanica dell'università e dell'orto botanico di Mosca. Egli infatti così scrive in Genera Plantarum Umbelliferarum (1814): "In onore di un uomo illustrissimo, da lodare per dottrina, prudenza, perizia, l'insigne botanofilo János Orlay". Segue una sfilza di titoli, che fa sospettare che quella dedica a un uomo all'epoca assai influente non fosse poi così disinteressata. Orlaya Hoffm. è un piccolo genere dalla famiglia Apiaceae (Umbelliferae), con tre specie native dell'Europa sudoccidentale e dell'Asia centrale, Orlaya daucoides, O. grandiflora, O. daucorlaya, tutte presenti anche nella flora italiana. Le prime due sono considerate da alcuni sinonimi, da altri specie indipendenti. Sono annuali con foglie finemente divise e umbelle di fiori rosati o bianchi che sono state paragonate a pizzi. Infatti, la specie più frequentemente coltivata O. grandiflora in inglese si chiama laceflower, fiore di pizzo. Un tempo era una comune infestante dei campi arati, ma l'uso di erbicidi ne ha molto limitato la diffusione. In compenso, è diventata una pianta da giardino molto apprezzata per la lunga fioritura, adatta sia alle bordure miste sia in massa a prati naturali. La meno comune Orlaya daucorlaya ha distribuzione essenzialmente balcanica; come la precedente, preferisce luoghi incolti, aridi e assolati. Vive in Grecia, Bulgaria, Albania, ex Yugoslavia; in Italia è presente in poche località dell'Abbruzzo. Il 20 giugno 1837 sale al trono la regina Vittoria, destinata a regnare sul Regno Unito per 63 anni, dando il nome a un'intera epoca. Caso vuole che proprio negli stessi giorni giunga in Inghilterra la notizia della scoperta in Amazzonia di una magnifica e gigantesca ninfea; per il nome, lo scopritore ha già pensato a lei, all'epoca ancora principessa, e propone di chiamarla Nimphaea victoria. Quale migliore simbolo per inaugurare un regno che si spera rinverdisca i fasti imperiali della Gran Bretagna? Il nome della nuova pianta diventa quasi un affare di Stato e scatena la rivalità di società scientifiche e botanici. Alla fine, grazie al potente appoggio di Hooker, la spunteranno Lindley e il nome Victoria regia. Si susseguono sfortunati tentativi di coltivarla in Inghilterra, finché l'abile giardiniere Joseph Paxton riesce a farla fiorire per la prima volta. La mette in mostra a Chatsworth House con un'installazione che farà epoca; gli stupefatti visitatori ne ammirano i fiori e le foglie gigantesche, su una delle quali sta composta una bimba elegantemente vestita: è Annie, la figlioletta del giardiniere. Da quel momento una Victoria lily house, ovvero una serra tropicale di cui la spettacolare pianta è il maggiore punto di attrazione, diventerà irrinunciabile per orti botanici e ricchi collezionisti. La pianta era indubbiamente regale, per non dire imperiale, e la regina Vittoria accolse lusingata l'omaggio. Quando era giovane forse le piante e i giardini erano per lei una piacevole cornice, dove amava sedere e passeggiare. Il vero appassionato di famiglia era il marito, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. Ma quando rimase vedova prendersi cura delle piante che lui aveva piantato e proseguire i suoi progetti orticoli divenne un compito quasi sacro. Tra le sicure benemerenze della sovrana, il sostegno che diede alla nascita di quello che è oggi il Chelsea Flower Show, la più importante esposizione floricola della Gran Bretagna, forse del mondo. 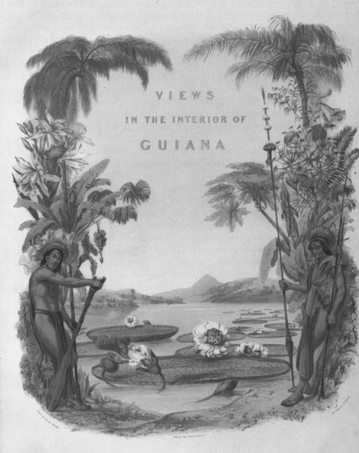 Una scoperta plurima e una polemica nominalistica Con le sue enormi foglie che assomigliano a tondi vassoi galleggianti, dal diametro fino a tre metri, e i meravigliosi fiori dagli innumerevoli petali, ammirare le Victoria nel loro ambiente naturale deve essere un'esperienza indimenticabile. Ovviamente gli indigeni le conoscevano da sempre, e le chiamavano con molti nomi; il più poetico è forse auapé-yaponna, da auapé (Jacana incana), un piccolo uccello di ripa che si vede spesso correre sulle foglie di Victoria amazonica. Ma per i primi botanici europei che le "scoprirono" fu addirittura un'esperienza mistica. Il primo in assoluto sembra sia stato Thaddäus Haenke, il botanico della spedizione Malaspina. Alla fine del viaggio, si era fermato in Sudamerica e nel 1801, in Bolivia, si imbatté in Victoria amazonica mentre esplorava il Rio Marmoré, uno dei tributari superiori del Rio delle Amazzoni. Ne fu folgorato al punto da cadere in ginocchio adorante. Quasi vent'anni dopo, nel 1819, nella stessa area la vide anche Aimée Bonpland, l'ex compagno di viaggio di Humboldt; non cadde in ginocchio, ma si gettò fuori dalla zattera per ammirarla da vicino e per un mese non parlò d'altro. Nel 1825, ne inviò semi e una completa descrizione a Mirbel, professore di orticultura al Jardin des Plantes di Parigi, ma il suo invio rimase quasi inosservato. Più posate le reazioni di Alcide d'Orbigny, lo scopritore della specie più meridionale, Victoria cruziana. La scoprì nel 1827 su due tributari del Rio della Plata, il Paranà e il Riochuelo, nella provincia argentina di Corrientes, presso la frontiera con il Paraguay; riempì la sua barca di fiori, foglie e frutti; la disegnò accuratamente, la descrisse, e spedì esemplari d'erbario, disegni e descrizioni al Jardin des Plantes. Continuando i suoi viaggi in Sudamerica, visitò anche la Bolivia e nel 1832 vide fluttuare la specie amazzonica sul Rio Madeiras; fu così il primo a capire che si trattava di due specie diverse. Più o meno contemporaneamente, il botanico e esploratore tedesco Eduard Poeppig la vide presso il Rio Solimões, e nel 1832 fu il primo a pubblicarne la descrizione sulla rivista di Weimar Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, assegnandola come Euryale amazonica al genere Euryale, di cui si conosceva già una specie asiatica, E. ferox. Infine, il primo gennaio 1837 un altro esploratore tedesco, Robert Schomburgk, che però lavorava per la Royal Geographical Society (RGS) britannica, la trovò sul Berbice River nella Guiana Britannica; rimase non meno folgorato dei suoi predecessori, la misurò, la disegnò e si affrettò a inviare disegni, descrizione e campioni d'erbario alla RGS. Nulla sapeva delle scoperte precedenti; riteneva si trattasse di una specie ignota di Nymphaea e suggerì che la "più interessante delle mie scoperte" fosse dedicata alla "nobile ninfa vivente, la giovane principessa Vittoria", con il nome Nymphaea victoria, sempre che ella concedesse il suo assenso. Lettera e materiali giunsero a Londra proprio in coincidenza con il delicato passaggio della salita al trono della diciottenne Vittoria (Alexandrina Victoria di Kent), succeduta allo zio Guglielmo IV, morto il 20 giugno 1837. Era l'unica erede di una dinastia che rischiava di estinguersi; in lei, salutata come la "rosa d'Inghilterra", si ponevano tutte le speranze del paese. Assicurarsi il suo alto patronato era importante per le società scientifiche, ed era vitale per la stessa sopravvivenza dei Kew Gardens. Il sovrano defunto se ne era disinteressato, con il risultato di un degrado tale che il Tesoro per verificare la situazione e valutare se mantenerli o dismetterli nominò una commissione composta dai giardinieri Joseph Paxton e Joseph Wilson e dal botanico John Lindley, strenuo difensore della loro sopravvivenza nonché segretario della Horticultural Society; anche quest'ultima necessitava del sostegno regio per risolvere i suoi annosi problemi finanziari. Per ragioni diverse, il grazioso patrocinio di sua Maestà era quanto mai indispensabile anche per la neonata Botanical Society of London, presieduta da John Edward Gray, il curatore della sezione zoologica del British Museum, e fondata appena un anno prima in polemica non tanto velata con le più antiche e prestigiose Linnean Society e Horticultural Society. Proprio a lui Schomburgk, che aveva potuto constatare il disinteresse della RGS per le scienze naturali, chiedeva di passare i materiali per la pubblicazione; inoltre in una seconda lettera privata al presidente della RGS, il capitano Washington, lo pregava di darsi da fare per ottenere l'assenso della principessa (così era quando egli la scrisse) e di fare eseguire da un illustratore professionista una copia del suo migliore disegno da donare alla illustre dedicataria; la spesa poteva essere coperta dalla somma che la Horticultural Society gli doveva per certi materiali botanici spediti dalla Guyana. Washington contattò Lindley che capì che non di una Nymphaea si trattava, ma di un genere nuovo; facendo in parte propria la proposta di Schomburgk, propose di battezzarla Victoria regia. Seguirono intensi contatti tra Washington e Lindley, ambedue intenzionati ad approfittare dell'occasione per assicurarsi il patrocinio della sovrana per le rispettive istituzioni. Fu la RGS a compiere i passaggi previsti dal protocollo, ottenendo l'assenso della regina sia per la dedica sia per il nome proposto da Lindley. Solo a questo punto, i materiali furono comunicati anche a Gray. Anche quest'ultimo, che credeva gli fosse stata consegnata l'unica copia, riconobbe in modo indipendente che si trattava di un nuovo genere; forzando un po' la mano nella speranza di ottenere il patronato della fino ad allora sfuggente Vittoria, il 7 settembre 1837 in una riunione della Botanical Society lesse il resoconto della scoperta di Schomburgk, quindi propose di fare della magnifica pianta il nuovo emblema della società sotto il nome Victoria regina (attenzione! c'è una enne in più). Due giorni dopo il resoconto della seduta e il nuovo nome venivano pubblicati nella rivista divulgativa Athaeneum. Nel frattempo l'Horticultural Society si era affrettata a far giungere le sue congratulazioni ufficiali alla nuova regina; e lo aveva fatto con un messaggio decorato con un'immagine di Victoria, copiata da miss Drake per incarico di Lindley da uno dei disegni originali di Schomburgk. Lo stesso Lindley aveva ricevuto dalla RGS l'incarico di preparare la pubblicazione ufficiale della scoperta. Il risultato fu la lussuosa monografia A Notice of Victoria Regia; in grande formato (62 x 48 cm), comprendeva una dedicatoria - che conteneva tra l'altro l'augurio che "il regno della regina Vittoria possa distinguersi negli annali della storia come la maestosa pianta che d'ora in poi porterà il suo regale nome è preminente nella Flora del suo paese natale" -, una copia del migliore disegno di Schomburgk colorata a mano e tre pagine di descrizione; ne vennero stampate solo 25 copie, da presentare alla regina e da riservare a un pubblico selezionatissimo. Uscì ad ottobre, un mese dopo l'articolo di Athaeneum. A questo punto iniziarono a circolare entrambi i nomi e iniziò anche una polemica piuttosto aspra tra Gray e Lindley per quella enne in più o in meno, con accuse reciproche di furto e plagio; vi si inserì anche d'Orbugny, indignato che Lindley gli avesse rubato il diritto di primogenitura. Finché nel 1850 - vedremo in quali circostanze - Hooker, con tutto il peso della sua autorità, optò per Victoria regia, che divenne il nome prevalente, tanto che lo stesso Gray finì per accettarlo, inchinandosi al fatto compiuto. A dire il vero, già nel 1847 il tedesco Klotzsch aveva fatto notare che la precedenza andava a Euryale amazonica di Poepping, quindi il nome corretto secondo le regole era Victoria amazonica; ma nessuno in Inghilterra era disposto ad ammetterlo, almeno finché la regina era viva. Infatti questo nome fu accettato solo dopo la sua morte nel 1901. Come Victoria amazonica fiorì per la prima volta in Inghilterra Attraverso queste ingarbugliate vicende, la spettacolare ninfea dell'Amazzonia divenne l'emblema della nuova monarchia britannica e del suo destino imperiale. Ma finora in Europa si erano visti solo disegni e esemplari d'erbario; ora il massimo desiderio era possederla e coltivarla. Il primo a provarci fu lo stesso Schomburgk che tentò di coltivarla a Georgetown in Guyana ma i suoi esemplari morirono tutti. Hooker mise in azione la rete dei corrispondenti dei Kew Gardens e fu all'origine di diversi tentativi di introduzione. Nel 1845 l'esploratore, botanico e cacciatore di piante Thomas Bridges visitò la Bolivia, cadde puntualmente innamorato dell'ammaliatrice Victoria, ne scrisse un'entusiastica descrizione per il Journal of Botany e ne spedì in Inghilterra i semi; per mantenerli umidi, li sistemò in una bottiglia con argilla bagnata. Dei 25 ricevuti nel 1846 dai Kew Gardens, solo tre germinarono, due pianticelle sembrarono prosperare, ma morirono l'inverno successivo. Nel 1848 Edward G. Boughton, un medico inglese residente a Leguan nella Guiana britannica, spedì a Kew alcune radici in una cassa di Ward, ma quando fu aperta risultarono marce e inservibili; separatamente spedì anche alcune capsule contenenti semi e altri semi in una bottiglia di acqua fangosa, ma nessuno germinò. Il successo arrise l'anno dopo a Hugh Rodie, un altro medico, e a un certo Luckie di Demerara, sempre nella Guyana Britannica, che invece sistemarono i semi in piccole fiale di acqua pura; il primo invio raggiunse Kew il 28 febbraio 1849, seguito da altri tre. Alcuni di questi semi germinarono e nell'estate del 1849 si erano sviluppate sei pianticelle; tre vennero trattenute a Kew, una fu inviata a Regent Park, dove la Botanical Society aveva la sede, due furono affidate ai duchi di Devonshire e di Northumberland, che possedevano serre adatte a piante tropicali rispettivamente a Chatsworth House e a Syon House. Il capo giardiniere di Chatsworth House era l'abilissimo Joseph Paxton, che abbiamo già incontrato come membro del comitato incaricato di valutare l'eventuale sopravvivenza di Kew. Andò a prendere personalmente la pianticella a Kew (era piccolina, con appena 4 foglie non dispiegate, la maggiore di 12 cm di diametro) e la portò il più rapidamente possibile a Chatsworth, dove la sistemò in un barile di acqua pura, che poi collocò in un lettorino a 30°, mentre provvedeva a creare una grande vasca riscaldata. Appena fu pronta, la sistemò al centro, su una collinetta di terra preparata; in due mesi e mezzo, la pianta occupò l'intera vasca, e il 1 novembre emerse il primo fiore. Il 14 era totalmente aperto; Paxton partì immediatamente per Windsor e il giorno dopo presentò il fiore e una foglia a sua Maestà. Perfettamente coltivata, la sua pianta continuava a prosperare: a un anno dalla prima fioritura, aveva prodotto 150 foglie e 126 fiori, senza mai smettere di fiorire. Era necessario provvederle una nuova casa. Paxton disegnò per lei una serra speciale in ghisa e vetro, con al centro la vasca della meravigliosa pianta; quando arrivavano visitatori illustri, per stupirli ancora di più metteva la figlioletta Annie di sette anni in posa su una foglia, che ormai aveva raggiunto il diametro di due metri. Ottenne uno straordinario successo mediatico, tanto che nel 1851, benché non avesse alcuna esperienza come architetto, gli fu affidata la costruzione del Crystal Palace, la sede della prima Esposizione universale; Paxton per la prima volta si avvalse di moduli prefabbricati e nel disegnare la cupola e il frontone replicò la struttura delle foglie della Victoria. La regina omonima lo premiò con il cavalierato. La tecnologia messa a punto da Paxton fu impiegata anche a Syon House e a Kew, dove due Victoria fiorirono l'anno successivo; quella di Kew iniziò a fiorire nel giugno 1850 e la fioritura si protrasse fino a Natale. William Jackson Hooker, che dal 1841 era direttore dei Kew Gardens, ne seppe sfruttare il fascino per rilanciare il giardino e trasformarlo in un centro di studi botanici di importanza mondiale. Quando assunse l'incarico, i Kew Gardens, in stato miserevole, misuravano appena 8 acri; quattro anni dopo, grazie alla generosità della sovrana e al passaggio dal patrimonio regale alla nazione, avevano raggiunto 650 acri. Nel 1847 Hooker dedicò alla "ninfea reale" il primo numero dell'anno del Curtis's botanical magazine; vi sintetizzò tutte le vicende dell'incontro dei botanici europei con la quella meraviglia della natura, accludendo un puntuale confronto con il genere Euryale, una nota di Bridges sulle condizioni di crescita e 4 tavole riprese dai disegni di Schomburgk. Quando finalmente la Victoria di Kew fiorì, la regina, accompagnata dal presidente della Repubblica francese (che poi sarebbe diventato Napoleone III) visitò il giardino per ammirarla. Hooker si mise al lavoro per preparare una monografia degna di tanta pianta e di tanto onore; i testi erano un rielaborazione di ciò che aveva già scritto per il Curtis's, ma la vera novità era costituita dalle tavole botaniche, che egli commissionò a Fitch, che disegnò i fiori in tutti i particolari, sulla base degli esemplari di Kew e Syon House; era un lussuoso ma smilzo in folio che fu stampato e presentato alla regina nel 1851, in tempo per l'esposizione universale. Approfittando di un nuova linea di autobus, furono moltissimi coloro che fecero il viaggio fino a Kew per ammirare i giardini e la fioritura della sua maggiore attrazione, la Victoria regia finalmente conquistata: mentre nel 1844 i giardini erano stati visitati da 15.000 persone, nel 1851 furono 240.000. Nel pieno della moda per le serre e la coltivazione di piante esotiche, possedere una Victoria (e una serra adatta ad ospitarla) divenne uno status symbol. Non era neppure più necessario andare fino in Bolivia o in Guyana per procurarsela: infatti le piante di Chatsworth e Kew avevano incominciato a produrre semi vitali e ad essere riprodotte. Semi o pianticelle vennero distribuiti in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Ad assicurarsi la prima fioritura al di fuori della Gran Bretagna fu van Houtte di Gand nell'aprile 1850 (anticipando anche Kew). Nel 1851 fu la volta degli Stati Uniti, dove la prima Victoria amazonica fiorì nel giardino di Caleb Cope, il presidente della Horticultural Society della Pennsylvania. 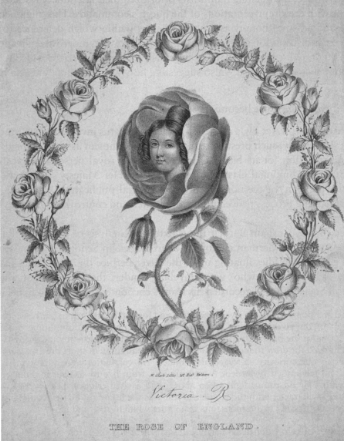 La regina Vittoria e i suoi giardini La spettacolare ninfea dell'Amazzonia, giunta in Inghilterra per singolare coincidenza proprio all'esodio del regno di Vittoria, ne divenne dunque il simbolo, quasi l'incarnazione. Era rara ed esotica, ma l'ingegno e la tecnologia britannici erano riusciti a rapirla e imbrigliarla; gigantesca come lo stesso impero britannico; costosissima ma allo stesso tempo disposta a farsi ammirare da tutti al modico prezzo di un biglietto di entrata; sensuale e delicata, ma allo stesso tempo indomabile. Era perfetta per rappresentare l'Inghilterra vittoriana, esattamente come la regina, con il suo regno protrattosi per più di sessant'anni. Secondo le tradizioni di famiglia (dopo tutto, Kew era stato fondato dai suoi bisnonni e reso splendido dal nonno Giorgio III), certamente amava le piante, ma il vero appassionato di orticultura era il marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, che la sovrana sposò nel 1840. Sotto la supervisione del principe consorte, i vari giardini delle residenze reali londinesi che in precedenza provvedevano allo scopo furono sostituti dal grande orto-frutteto (Kitchen Garden) di Winsor, dove si producevano le verdure e la frutta per la tavola regale, e anche fiori da taglio; era dotato di serre e considerato tra i più avanzati ed efficienti dell'epoca. Alberto profuse la sua passione per le piante soprattutto nelle residenze private. Vittoria e Alberto ne crearono principalmente due, Osborne House nell'isola di Wight e il castello di Balmoral in Scozia. Osborne fu costruito a partire dal 1844. Dato che la baia ricordava ad Alberto quella di Napoli, la casa e i giardini si ispirarono allo stile italiano, con terrazze formali, parterre, balaustre, fontane e statue. C'erano piante da tutto il mondo e per la prima volta per le aiuole estive vennero usate grandi quantità di annuali, coltivate a tale scopo nelle serre. Per i bambini (la coppia ne ebbe nove) fu costruito uno chalet in stile svizzero attorniato da un giardino con aiuole dove essi potevano coltivare personalmente le loro piante. C'era anche un giardino murato con alberi da frutto e due serre. Balmoral fu invece acquistato nel 1852. Anche in questo caso, la costruzione deve molto ad Alberto, che lo fece edificare in uno stile eclettico che mescola elementi della sua nativa Turingia con reminiscenze elisabettiane. Al contrario del formale Osborne, ad eccezione dei parterre più vicini al castello, si tratta di un vastissimo parco in stile paesaggistico, reso suggestivo da un panorama "romantico" e circondato da una densa foresta. Alberto vi fece piantare molte conifere esotiche, sovrintese alla creazione di parterre, di deviazioni della strada principale, di un nuovo ponte e di vari edifici agricoli, tra cui un caseificio modello. Nel 1861, ad appena 42 anni, Alberto morì di febbre tifoidea. Da quel momento per Vittoria, che lo aveva amato teneramente e ne venerava la memoria, preservare le piante che egli aveva piantato e mantenere i suoi progetti per Osborne e Balmoral divenne un sacro dovere. Fedele al suo lascito, completò l'acquisto della foresta di Ballochbuie, salvando dalla distruzione uno dei più significativi resti dell'antica foresta di conifere della Caledonia. Inclusa nella tenuta di Balmoral, fu uno dei primi progetti di conservazione del patrimonio forestale scozzese. Osborne e Balmoral continuarono a essere luoghi della memoria, dove ogni albero le parlava del marito defunto e dove a sua volta fece piantare molti alberi commemorativi. Ma con il passare degli anni il suo giardino del cuore divenne quello di Frogmore House, all'interno del parco di Windsor, dove fece costruire i mausolei per la madre, Victoria di Sassonia-Saalfeld, per il marito e per se stessa. Altri edifici si aggiunsero: una casa da tè e un chiosco indiano; nei suoi ultimi anni, in estate non era raro vederla sbrigare la corrispondenza in una tenda allestita nel giardino. Da Alberto, Vittoria ereditò anche il ruolo istituzionale di patrona di varie istituzioni connesse con l'orticultura e il giardinaggio. Particolarmente stretta fu la relazione della coppia reale con l'Horticultural Society: nel 1858 il principe consorte ne divenne presidente; nel 1861, ottenuto il patrocinio reale, l'associazione mutò nome in Royal Horticultural Society. L'inaugurazione del nuovo giardino della RHS a Kensington il 5 giugno 1861 fu l'ultima apparizione pubblica di Alberto, che sarebbe morto a dicembre. Vittoria avrebbe voluto succedergli ella stessa come presidente della RHS, ma ne fu dissuasa dai suoi consiglieri. Seguì un lungo periodo di lutto e quasi di autoreclusione; quando lo zio Leopoldo del Belgio, per lei quasi un secondo padre, la avvertì che non mostrarsi in pubblico avrebbe potuto alienarle l'affetto dei sudditi, riprese a farlo, ma sempre raramente. Faceva eccezione proprio per la RHS; nel 1864 la sua prima visita pubblica dopo il periodo di isolamento fu proprio al giardino di Kensington, dove era stata organizzata una festa per celebrare il suo compleanno. Successivamente, visitò con una certa assiduità il Great Spring Show (ovvero quello che è oggi noto come Chelsea Flower Show; ai suoi tempi si teneva in altre sedi). Nel 1897, in occasione del sessantesimo anniversario dell'ascesa al trono della sovrana, "a perpetua memoria del glorioso regno di sua Maestà" la RHS istituì la Victoria Medal of Honour, assegnata ai migliori orticultori britannici. La regina Vittoria è la più celebrata dei monarchi britannici, ricordata da innumerevoli monumenti, edifici, parchi, località in tutto l'impero; non stupisce che, oltre al genere Victoria, le siano state dedicate anche altre piante, in genere di notevole impatto estetico: Agave victoriae-reginae, probabilmente la più nota, Dendrobium victoriae-reginae, Banksia victoria, Lobelia cardinalis 'Queen Victoria'. Sembra però che la sua preferenza andasse a fiori più modesti: le violette e le primule che, si dice, inviava in dono al primo ministro con cui ebbe più feeling, Benjamin Disraeli.  Il genere Victoria E' ora di dire qualche parola in più del genere Victoria e delle sue tre specie. Appartenenti alla famiglia Nymphaeaceae, sono piante acquatiche galleggianti che vivono nelle acque calme, nelle lanche e nelle praterie allagate dei bacini del Rio delle Amazzoni (Victoria amazonica e V. boliviana) e del Rio della Plata (V. cruziana). Victoria boliviana è stata riconosciuta come specie a sé solo nel 2022. Nel 2016 due orti botanici boliviani, quelli di Santa Cruz de La Sierra e di La Rinconada, donarono ai Kew Gardens semi di Victoria provenienti dai Llanos de Moxos, nella provincia di Beni. Potendo osservare fianco a fianco nelle serre di Kew sia questa pianta sia Victoria amazonica, Carlos Magdalena, uno degli orticoltori botanici senior di Kew, nonché esperto di ninfee, poté notare che si trattava di due specie diverse. Le sue osservazioni sono state poi confermate dall'analisi del DNA, e hanno portato nel 2022 alla pubblicazione della nuova specie come V. boliviana. Nuova fino a un certo punto: essa infatti assomiglia in modo impressionante a un disegno di Walter Hood Fitch tratto da un esemplare raccolto in Bolivia nel 1845 (presumibilmente uno di quelli inviati da Bridges). V. boliviana si distingue dalle altre specie del genere per la diversa distribuzione delle spine, la mancanza di tricomi sui tepali esterni e l'ovario e la forma dei semi; ha anche strappato a V. amazonica il record di "ninfea più grande del mondo", quando le foglie di un esemplare coltivato a La Rinconada hanno raggiunto un diametro di 3.2 metri. Abbiamo già visto che V. cruziana fu identificata come specie a sé da Alcide d'Orbigny che la pubblicò nel 1840 dedicandola al presidente della Bolivia Andrés de Santa Cruz che aveva reso possibile la sua spedizione. Rispetto alle altre due specie, può crescere in acque più fresche, il che permette la sua coltivazione all'aperto anche in zone temperate. Cresce in acque ferme fresche, ma perché il fiore possa sbocciare sono necessarie alte temperature ambientali. Ha fiori lievemente più piccoli di V. amazonica e foglie con la pagina inferiore viola invece che rossa e ricoperta da una peluria simile a quella delle pesche; al contrario di quelli della specie amazzonica, i boccioli non sono tozzi ma appuntiti e glabri anziché spinosi. Durante la loro crescita, tutte e tre le specie spingono gradualmente da parte le altre piante, escludendole via via dalla luce del sole, finché rimangono le sole ad occupare quel tratto d'acqua. Il fiore si forma sott'acqua ed emerge quando è pronto alla fioritura. Tutti i fiori di un singolo cespo di V. amazonica si aprono nella stesso momento, nella tarda serata, e hanno petali candidi; un meccanismo di riscaldamento noto come termogenesi fa sì che la temperatura interna superi anche di 10 gradi quella esterna, aiutando a rilasciare un intenso profumo fruttato che attrae gli scarabei dei genere Cyclocaephala, che trovano una ricompensa amidacea negli staminoidi (stami non funzionali). Mentre banchettano, al calar della notte il fiore cessa di emettere profumo, si chiude e intrappola gli insetti nelle sue appendici carpellari. Il giorno successivo la pianta rilascia antociani e il fiore cambia colore, virando dal bianco al rosa, segno che è stato impollinato. La seconda sera si riapre per lasciare uscire gli scarabei, che passando attraverso gli stami si ricoprono di polline. Andranno così a fecondare i fiori di un altro cespo. E' possibile anche l'autoimpollinazione (abbiamo visto che le piante di Kew e Chatsworth produssero semi vitali) ma di solito viene evitata; in serra e in coltivazione al fuori delle zone d'origine l'impollinazione è dunque effettuata a mano, Un'altra caratteristica affascinante delle Victoria, che come abbiamo visto colpì ed ispirò Paxton, è la struttura delle foglie. Sono tonde, piatte, simili a grandi vassoi con un bordo rialzato. La pagina inferiore, rossastra in V. amazonica e violacea in V. cruziana, è coperta di spine che la proteggono dagli attacchi dei pesci e segnata da una fitta rete di costolature rilevate che da una parte formano camere che intrappolano l'aria permettendole di galleggiare, dall'altra ne irrobustiscono la struttura tanto che possono reggere il peso anche di una 40 di kg (vi ricordate della piccola Annie Paxton?). Nella seconda metà del secolo scorso si è anche cominciato a incrociare V. amazonica e V. cruziana per ottenere ibridi con lle migliori caratteristiche dei genitori, compresa la rusticità della specie più meridionale; il primo, tuttora in produzione, fu ottenuto nel 1961 presso i Longwood Gardens (Pennsylvania); è 'Longwood Hybrid', caratterizzato da grandi foglie con belle nervature, bordo rossastro, tolleranza al freddo; successivamente negli Stati Uniti e in altri paesi ne sono stati prodotti numerosi altri, tra cui 'Adventure', con fiori bianco crema la prima notte e rosa medio la seconda; 'Atlantis', con petali lievemente appuntiti bianchi la prima notte, rosso scuro la seconda notte in acque calde, rosati in acque più fresche; 'Columbia', con petali arrotondati, che virano dal bianco crema al rosa chiaro; 'Challenger', caratterizzata da bordi ondulati; 'Discovery', con fiori che virano dal bianco al rosa scuro. Il medico alsaziano Gustav Mülhenbeck per quasi trent'anni esplorò la flora della sua regione, condivise generosamente le sue raccolte, si fece un nome come esperto di crittogame. Tuttavia non scrisse mai nulla di botanica, e la morte gli impedì di scrivere l'opera sui funghi che progettava. Il suo vero lascito è un enorme erbario, perfettamente montato e accuratamente classificato secondo gli standard dell'epoca, oggi parte dell'erbario dell'Università di Strasburgo. A ricordarlo provvede anche il variabile genere Muehlenbeckia, di cui almeno una specie (o forse due) è coltivata anche nei nostri giardini.  Un raccoglitore generoso, modesto e instancabile Con oltre mezzo milione di esemplari, l'erbario dell'Università di Strasburgo è uno dei più grandi d'oltralpe. Oltre alla collezione generale ed erbari specifici per la flora alsaziana e le crittogame, conserva separatamente anche una serie di erbari storici. Tra i più importanti l'erbario H. G. Mülhenbeck, risalente alla prima metà dell'Ottocento e qui depositato dalla Société Industrielle de Mulhouse. A crearlo fu l'alsaziano Henri Gustave Mulhenbeck (in tedesco Heinrich Gustav Mülhenbeck, 1798-1845), medico di professione e botanico e micologo per passione. Nato a Sainte-Marie-aux-Mines, una cittadina mineraria a ridosso dei Vosgi e rimasto presto orfano, Mülhenbeck studia medicina e chirurgia a Strasburgo e Parigi, dove si laurea nel 1822. La scoperta della botanica avviene negli anni universitari a Strasburgo, quando è allievo di Christian Gottfried Nestler, che gli trasmette la passione per le erborizzazioni, le crittogame e gli erbari. Da diversi anni, Nesteler affianca Jean-Baptiste Mougeot nella creazione di una grande collezione di exsiccata di crittogame (Stirpes cryptogamae vogeso-rhenanae) i cui fascicoli di cento esemplari o centuriae sono via via pubblicati anche in una versione a stampa a partire dal 1810. Il giovane allievo viene coinvolto nelle ricerche e stringe amicizia con Mougeot che sarà per lui un punto di riferimento e un modello di vita: proprio come più tardi Mülhenbeck, egli si divideva infatti tra la medicina e le scienze naturali, e per più di sessant'anni percorse instancabilmente i Vosgi alla ricerca di fossili e piante. Simile è anche la vita di Mülhenbeck, quando, fresco di laurea, si stabilisce come medico generico a Guebwiller, una cittadina ai piedi del Ballon d'Alsace all'imbocco della Valle del Florival. Nell'agosto 1823 così scrive proprio a Mougeot: "Percorrendo la valle per visitare i malati, si trova la strada meno lunga grazie alla diversità dei prodotti di Flora"; e una volta a casa, nel proprio gabinetto medico "non si può trovare società migliore dell'erbario, che è dunque il mio migliore amico e diventa di giorno in giorno più caro: si tra tranquilli con lui!". Nel tempo libero, le passeggiate si allungano per esplorare la flora delle colline calcaree dei dintorni, dove scopre diverse piante segnalate per la prima volta nella regione. Non che il giovane dottore sia un asociale. Nel 1828 viene iniziato alla loggia massonica La Parfaite armonie di Mulhouse, dove incontra un medico dalle idee progressiste, Pierre Paul Jaenger, che più tardi aderirà alle idee socialiste di Fourier. La loggia è soprattutto l'espressione della borghesia imprenditoriale della città, un importante centro tessile, i cui membri, quasi tutti protestanti calvinisti di idee liberali, negli anni napoleonici avevano avuto un ruolo di primo piano nella vita politica locale e ora, negli anni della restaurazione, promuovono iniziative economiche, educative, assistenziali. Nel 1825 viene fondata la Societé industrielle de Mulhouse (SIM); tra i 22 soci fondatori, 12 sono membri della loggia. L'obiettivo principale della SIM è "fare passere l’industria dallo stato empirico al rango di una vera scienza"; per perseguirlo, nel 1829 la società si doterà di un Comitato di scienze naturali (Comité des sciences de la Nature), che con gli anni diventerà una vera e propria società scientifica, con tre sezioni dedicate alla botanica, all'ornitologia e alla paleontologia. Mülhenbeck ne diventa il segretario e nel 1831 è tra i membri fondatori della Société médicale du Haut-Rhin. Ormai molto riconosciuto nella sua professione, nel 1833 egli si traferisce a Mulhouse, dove vive ed esercita fino alla morte. Si interessa di storia locale e nei primi anni '30 pubblica diversi articoli sulla Revue d'Alsace. Anche se la botanica non è mai dimenticata, per qualche anno passa un po' in secondo piano. Ritorna prepotentemente al centro della sua vita grazie all'amicizia con Wilhelm Philippe Schimper, che nel 1836 pubblica insieme a Philipp Bruch il primo dei sei volumi di Bryologia europea; i due lo coinvolgono nelle loro ricerche; Mülhenbeck erborizza con loro, condivide le sue raccolte e nel 1839 li accompagna in una lunga escursione attraverso le Alpi; nel 1844, sarà di nuovo con loro nei Grigioni. Con Schimper, Bruch e Mougeot, ormai anziano ma sempre attivo, scopre diverse specie di muschi precedentemente mai segnalate in Svizzera, appartenenti alla flora nordica, da considerare relitti della flora preglaciale. Esplora anche l'area di Basilea e comunica diversi ritrovamenti a Carl Meissner e Karl Friedrich Hagenbach, che lo cita ripetutamente nel secondo volume di Tentamen florae basileensis. Come Schimper, oltre che ai muschi, si interessa ai fossili e alla paleontologia, ma non scrive nulla né di questi argomenti né di botanica, accontentandosi di condividere generosamente le sue raccolte con amici e corrispondenti. Progetta invece di scrivere un libro sui funghi e inizia addirittura a farne disegnare e dipingere un gran numero; ma il progetto non si concretizzerà, perché muore prima dei cinquant'anni, nel 1847.  Un genere variabile... con qualche confusione Della sorte delle illustrazioni di funghi, che dopo la sua morte secondo Kirschleger furono acquistate dal banchiere Édouard Vaucher, non sappiamo nulla. Rimane invece come maggiore lascito proprio "l'amico erbario". Mülhenbeck non aveva mai cessato di arricchirlo fin da quando, studente universitario, partecipava alle prime escursioni con Nestler e Mougeot; alla sua morte, contava ben 20.000 esemplari, accuratamente montati e classificati secondo il sistema che andava alla maggiore ai suoi tempi, quello di de Candolle. Le sue raccolte personali erano considerevoli, molto l'ottenne con scambi con altri botanici, ma soprattutto non lesinò spese per acquistare esemplari messi in vendita da altri raccoglitori. Così quell'erbario, che nel 1857 Kirschleger, autore di Flore d'Alsace, definì "magnifico", oltre a specie della flora dell'Alsazia e della Svizzera o più un generale europea, comprende anche exsiccata di piante esotiche: tra le altre, piante raccolte in Algeria da Bové; in Medio Oriente da Boissier, Kotschy e Pinard ; nel Caucaso da Hohenacker; in varie parti dell'Asia da Helfer; in Indonesia da Kollman; in Sudafrica da Ecklon, Zehyer e Drège; in Australia da Preiss; nelle Americhe da Hartweg, Hostmann, Blanchet e von Martius. In tal modo costituisce un'importante testimonianza dell'attività di alcuni dei principali raccoglitori della prima metà dell'Ottocento. Alla morte di Mülhenbeck , l'erbario fu messo in vendita dagli eredi; con un notevole sforzo finanziario e ricorrendo a una sottoscrizione, riuscì ad aggiudicarselo per 10.000 franchi la Societé industrielle de Mulhouse; ospitato in un'intera stanza della sede dell'istituzione, il prezioso lascito riuscì a superare indenne le vicissitudini e i bombardamenti di due conflitti mondiali, finché, non avendo né le risorse finanziarie né le strutture per assicurarne l'adeguata conservazione, la società decise di depositarlo presso l'Università di Strasburgo. Nel 2007 ne è iniziata la digitalizzazione, compito non facile vista l'ingentissima mole. Come tappa preliminare, si è provveduto all'inventario delle famiglie e dei generi rappresentati, inizialmente sotto la nomenclatura usata dallo stesso Mühlenbeck. Si passerà poi all'allineamento con la nomenclatura attuale, anche allo scopo di scegliere le famiglie o i generi da digitalizzare in modo prioritario. A ricordare il medico alsaziano, oltre al gigantesco erbario, ha provveduto da tempo la dedica di alcune piante, come il muschio Bryum muehlenbeckii, e il genere Muehlenbeckia. A dedicarglielo nel 1841, dunque quando Mühlenbeck era ancora in vita, fu uno dei suoi corrispondenti, lo svizzero Carl Meissner, professore di botanica dell'Università di Basilea, che così scrive: "Ho dedicato questo genere al chiarissimo amico Gustav Mühlenbeck, dottore in medicina, medico a Mulhouse, esploratore e osservatore instancabile della flora alsaziana, specie di quella crittogamica, autore di un'opera micologica che sarà presto pubblicata". Meissner scrisse tra l'altro una monografia sulle Polygonaceae e pubblicò molte piante australiane. E infatti creò il genere a partire da due specie del continente australe, M. australis, originaria della Nuova Zelanda, e M. adpressa, originaria dell'Australia meridionale. Oggi al genere sono assegnate circa 25 specie distribuite tra la Papuasia e l'Australasia e dall'nord America subtropicale al Sud America. La sua caratteristica saliente è la variabilità: raccoglie infatti erbacee perenni, arbusti eretti più o meno legnosi, liane tanto rampicanti quanto tappezzanti. Tutte hanno radici rizomatose, ma differiscono in tutto il resto: nella forma delle foglie, dotate o meno di picciolo, sempreverdi o decidue; nelle dimensioni dei fiori, verdastri e insignificanti in alcune specie, relativamente vistosi in altre; alcune specie sono dioche, altre ginodioche, altre monoiche. Nei nostro giardini la più coltivata è M. complexa, anche se non di rado è commercializzata sotto il nome arbitrario di M. axillaris. Le due specie, in effetti, entrambe originarie della Nuova Zelanda (M. complexa è presente anche in Tasmania e nell'Australia meridionale), si assomigliano, anche se non al punto di confondersi. M. axillaris è una tappezzante bassa che forma densi tappeti anche di un metro di diametro, espandendosi sia tramite rizomi sia radicando ai nodi. In estate produce masse di minuscoli fiori bianco crema, portati in gruppi fino a tre all'ascella fogliare. M. complexa ha fusti volubili molto più sottili, che possono ricedere o arrampicarsi sulle rocce o sulla vegetazione circostante e forma molti rami che tendono a intrecciarsi strettamente. Porta foglie picciolate sempreverdi (possono però cadere negli inverni più rigidi), lucide, più o meno arrotondate, ma variabili nella forma e nelle dimensioni anche sulla stessa pianta. I piccoli fiori a stella, raccolti in spighe lunghe circa 2 cm che emergono all'ascella dei rami, sono profumati e seguiti da bacche traslucide. Ottima come ricadente da muretti, è adatta anche alla coltivazione in vaso. Forse perché limitatamente rustiche, le Muehlenbeckia da noi non hanno finora manifestato le potenzialità invasive delle sorelle Fallopia e Reynoutria. Ma non è ovunque così: in California M. complexa è diventata così problematica da essere sottoposta a programmi di eradicazione. Per un approfondimento sulle specie neozelandesi, in tutto cinque, due delle quali endemiche, nonché su qualche altra specie interessante o curiosa, si rinvia alla scheda. La dedica del genere Klattia, il terzo dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae, è senza sorprese: ad aggiudicarsela è stato un tassonomista tedesco, specialista appunto di queste piante, nonché di Asteraceae. Operosissimo, pubblicò una quarantina tra articoli e contributi, collaborando anche ad alcune tra le maggiori opere del tempo, come la Flora brasiliensis di von Martius o il Conspectus floræ Africæ di Durand e Schintz. Eppure non era un botanico di professione, e quando gli venne offerta una cattedra universitaria la rifiutò. Per qualche anno gestì una scuola privata, poi insegnò scienze naturali in varie scuole della sua città natale, Amburgo, fin quasi all'ultimo istante della sua vita. 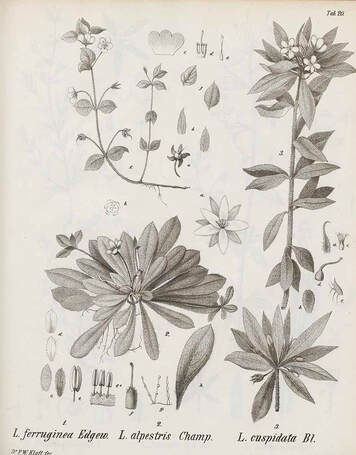 Insegnante per necessità, botanico per passione Se il destino non avesse giocato con lui in modo crudele, forse Friedrich Wilhelm Klatt (1825-1897), anziché insegnante e botanico, sarebbe diventato pittore. Nato in una famiglia povera di Amburgo e presto orfano del padre, fin da studente mostrò un notevole talento artistico; incoraggiato dai suoi insegnanti, nel 1842 inviò i suoi migliori disegni ad una mostra che metteva in palio borse di studio per i giovani artisti più promettenti. Ma, prima dell'inaugurazione, nella notte tra il 4 e il 5 maggio scoppiò il grande incendio che imperversò fino al giorno 9 e distrusse un terzo della città, inclusi i locali che ospitavano la mostra e le opere di Klatt. Anche le sue speranze andarono in fumo: il diciassettenne Klatt così abbandonò i sogni artistici, completò gli studi liceali e si volse all'insegnamento. Nel 1854 insieme a un fratello assunse la gestione di una scuola per ragazzi, che fu chiusa in seguito alla guerra franco-prussiana del 1870; egli però continuò ad insegnare scienze naturali in varie scuole femminili e maschili della sua città. Nel frattempo aveva incominciato a farsi conoscere come botanico dilettante. Fece le sue prime raccolte nei dintorni di Amburgo e lungo la costa del mare del Nord, ma era anche interessato alle piante esotiche e incominciò a frequentare l'orto botanico di Amburgo e il suo erbario. Nel 1854 il suo fondatore, Georg Christian Lehmann, gliene affidò la cura e lo incoraggiò ad approfondire lo studio della tassonomia. Nel 1856 Klatt pubblicò su "Linnaea" il suo primo lavoro scientifico, la trattazione della famiglia Pittosporeae (oggi Pittosporaceae) nell'ambito di Plantae muellerianae, ovvero la pubblicazione delle raccolte australiane di Ferdinand von Mueller. Nel 1860, come esecutore testamentario del suo mentore Lehmann, si occupò della vendita dell'erbario del professore, che fruttò una notevole cifra ma comportò anche la dispersione della collezione. A Klatt rimasero solo gli esemplari di Primulaceae, una delle famiglie su cui aveva concentrato i suoi studi tassonomici, insieme a Asteraceae e Iridaceae. E proprio a queste ultime dedicò il suo lavoro forse più noto, l'importante Revisio Iridearum, uscito su "Linnaea" tra il 1863 e il 1866. La pubblicazione della prima parte gli guadagnò la laurea honoris causa dall'Università di Rostock, che qualche anno dopo gli offrì una cattedra universitaria; egli però la rifiutò, non desiderando allontanarsi da Amburgo, dalla famiglia e dalla moglie cui era affezionatissimo. In questi anni il suo interesse si divideva ancora tra la flora locale e quella esotica che poteva studiare nei ricchi erbari delle università tedesche. Tra il 1860 e il 1865 pubblicò sia una flora della Germania settentrionale sia una flora del Granducato di Lauenburg e nel 1868 una flora crittogama di Amburgo. Tuttavia, in seguito divenne sempre più uno specialista di flora esotica; dei suoi oltre 40 scritti, gran parte si concentrano sulle già citate famiglie Iridaceae e Asteraceae, Oltre a pubblicare varie monografie su particolari generi (tra gli altri, Sisyrinchium, Androsace, Lysimachia, Freesia, Iris, Bellis), scrisse la sezione Iridaceae di Flora Brasiliens di von Martius (1871), di Conspectus floræ Africæ di Durand e Schintz (1895) e di Symbolae ad floram Brasiliae centralis cognoscendam di Warming (1872-73), quella delle Iridaceae e delle Compositae di Botanik von Ostafrika aus von der Decken's Reisen (1879). Tra i suoi principali contributi sulle Iridaceae, vanno ricordate anche le aggiunte e le correzioni al sistema di Baker (Ergänzungen und Berichtigungen zu Baker's Systema Iridacearum, 1882) e Determination and description of Cape Irideae (1885), dedicato alle Iridaceae raccolte in Sudafrica da Templeton e conservate nell'erbario MacOwan. Anche se non divenne mai esclusivo, a partire dagli anni '80 il suo interesse si spostò sempre più verso le Asteraceae, cui complessivamente dedicò una quindicina di scritti, che, a partire dell'esame di numerosi erbari, spaziano dall'Africa orientale tedesca e al Madagascar all'Australia, ma soprattutto si concentrano sul centro e sud America (Brasile, Messico, Guatemala, Colombia, Costa Rica); proprio alle composite americane dedicò il suo ultimo scritto (Amerikanische Kompositen aus dem Herbarium der Universität Zürich, 1896). Klatt scambiava esemplari e corrispondeva con molti botanici tedeschi, con Kew (che visitò in uno dei suoi rari viaggi all'estero) e con Asa Gray. Estremamente preciso e scrupoloso, quando gli veniva inviato un esemplare da determinare, gli tornava utile l'antico talento del disegno; soprattutto se si trattava di esemplari tipo, li disegnava in dettaglio, eventualmente inviando copia del disegno e delle proprie osservazioni ai colleghi che consultava per giungere a un'identificazione corretta. Illustrò di propria mano la sua monografia del genere Lysimachia, In quarant'anni di instancabile attività, Klatt pubblicò 21 generi, 6 dei quali tuttora validi, e quasi 1300 specie, circa 300 delle quali attualmente accettate. Membro di moltissime società scientifiche, egli rimase fino alla fine un professore di liceo. E proprio mentre si accingeva a fare lezione in una delle sue classi fu colpito dall'infarto che in breve lo portò alla morte, nel marzo 1897. Il suo notevole erbario venne posto in vendita e successivamente donato, parte all'Erbario Gray di Harvard, parte all'Istituto botanico dell'Università di Amburgo.  Rare Iridaceae sudafricane In Revisio Iridearum, Klatt si era anche occupato delle singolari Iridaceae arbustive del Capo all'epoca note; ne descrisse cinque specie, e le assegnò tutte al genere Witsenia; tra di esse una specie raccolta da Ecklon e Zeyher e conservata nell'erbario di Berlino, che egli presentò come propria, ma che in realtà era già stata pubblicata in modo illegittimo all'inizio del secolo da Ker Gawler come Witsenia partita. Nel 1877 Baker, nell'ambito del suo Systema Iridacearum, come avviene ancora oggi, le distribuì invece nei tre generi Witsenia, Nivenia e Klattia, creato appunto in onore del professore tedesco, con K. partita come unico rappresentante. Anche se il dedicatario e la motivazione della dedica sono evidenti, purtroppo Baker non li esplicitò. Oggi al genere Klattia sono assegnate tre specie; a K. partita si sono infatti aggiunte K. stokoei e K. flava, in precedenza considerata una varietà di K. partita. Tutte sono endemiche della Provincia del Capo occidentale, dove crescono in siti umidi sui pendii rocciosi delle montagne di arenaria. Tutte sono estremamente rare. K. partita è limitata ai pendii più freschi esposti a sud, ai margini delle paludi, intorno a 600 metri di altitudine della penisola del Capo, delle Hottentot Holland Mountains e delle Lagenberg mountains; vive per lo più in habitat protetti, ma le sue popolazioni sono in diminuzione. Molto rara K. flava, ristretta a piccole popolazione con forse meno di 1000 individui, dalle Hottentots Holland Mountains a Bain's Kloof, in gole e lungo corso d'acqua dove le nubi e le precipitazioni estive sono frequenti; rarissima K. stokoei, un endemismo del Kogelberg, di cui si conoscono appena una decina di popolazioni con un totale di circa 250 individui. Poiché la loro sopravvivenza dipende dalla disponibilità di acque sotterranee, sono a rischio a causa dell'estrazione di queste ultime. Piuttosto simili tra di loro, tutte sono arbusti sempreverdi con caudice legnoso sotterraneo, fusti semplici o irregolarmente ramificati, lunghe foglie lanceolate raccolte a ventaglio. I fiori, riuniti in dense infiorescenze e protetti da grandi brattee, sono tubolari e ricordano un po' un pennello; quelli di K. partita sono blu, quello di K. lutea gialli e quelli di K. stokoei rosso aranciato. Producono nettare con una bassa concentrazione di zucchero, appetito dai loro tipici impollinatori, gli uccelli nettarinidi come la nettarinia ventrearancio Anthobaphes violacea. Come Wistenia, hanno fama di essere di difficile coltivazione. Nel quindicennio tra il 1798 e il 1812, lo scozzese James Niven fu un prolifico ed efficiente cacciatore di piante in Sudafrica. Prima al servizio di George Hibbert, poi di un consorzio che includeva il vivaio Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina, raccolse migliaia di semi e esemplari di erbario, introducendo nei giardini europei molte nuove specie, in particolare Ericaceae e Proteaceae. Nella realtà fu un giardiniere, poi un raccoglitore, infine forse un commerciante morto troppo presto; nel mito, chissà perché, la sua scarna biografia si colora di particolari da fantasiosi a melodrammatici. A ricordarlo il reale e bellissimo genere Nivenia, endemico della provincia del Capo occidentale, uno dei tre arbustivi della famiglia Iridaceae. 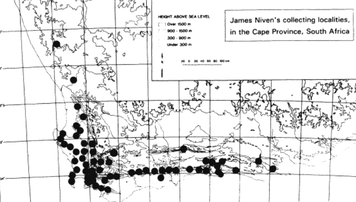 Un raccoglitore prolifico e coscienzioso Nel fascicolo del 1827 della rivista di orticultura edita da Longman e curata da Loudon The Gardener's Magazine i lettori poterono leggere il necrologio di Mr. James Niven, morto il 9 gennaio di quell'anno, corredato da una breve biografia. Ancora oggi è il resoconto più ampio della vita di questo giardiniere e cacciatore di piante; a firmarlo è J. M., ovvero James Main, che doveva aver conosciuto Niven di persona, visto che entrambi per qualche tempo avevano lavorato per il ricco collezionista di piante George Hibbert. Eppure, come vedremo meglio più avanti, le notizie fornite da Main sono da prendere con beneficio d'inventario. Figlio di un tessitore di Penicuik, non lontano da Edimburgo, James Niven (1776-1827) dovette ricevere la relativamente accurata educazione garantita dalle scuole pubbliche scozzesi; poi probabilmente lavorò come ragazzo giardiniere presso vari giardini, finché diciannovenne completò il suo apprendistato presso l'orto botanico di Edimburgo, dove rimase per circa un anno. Nel 1796 si trasferì a Londra dove fu assunto come giardiniere a Syon House, la splendida proprietà del duca di Northumberland, sotto il capo giardiniere Thomas Hoy. In qualche modo dovette attirare l'attenzione di George Hibbert che decise di inviarlo in Sudafrica a caccia di piante. Secondo Nelson e Rourle che, in assenza di un diario di campo, hanno cercato di ricostruire i suoi movimenti sulla base delle sue note d'erbario, Niven dovette arrivare al Capo alla fine del 1798 o all'inizio del 1799, dato che il suo primo esemplare datato risale all'agosto 1799. Secondo Main, presto si impadronì tanto dell'olandese quanto del khoi, tanto da poter servire come interprete e guida alle truppe del generale Craig. E' il primo mito che troviamo in questa storia: almeno un anno prima che Niven vi arrivasse, Craig, dopo aver brillantemente diretto l'occupazione inglese della Colonia del Capo, sottratta alla Repubblica batava, ed esserne stato per due anni governatore, era stato destinato al Bengala e aveva lasciato il Sudafrica per Madras. E' molto probabile (anzi certo secondo Nelson e Rourle) che al Capo Niven abbia invece incontrato un altro botanico scozzese, William Roxburgh, che vi era arrivato da Calcutta nel 1798 insieme a suo figlio John; mentre il padre lasciò il paese alla fine del 1799, il figlio vi rimase fino al 1804 a raccogliere esemplari per l'orto botanico di Calcutta. Nelson e Rourle ipotizzano che, essendo conterranei e avendo interessi comuni, Niven e i Roxburgh abbiano botanizzato insieme, anche se è difficile da dimostrare, perché, al contrario di quelli di Niven, per gli esemplari dei due Roxburgh la località di raccolta è spesso indicata in modo molto generico; una prova indiretta è il fatto è che nel suo erbario Niven usò alcuni binomiali inediti di Roxburgh, Nel 1803, in seguito al trattato di Amiens, la colonia del Capo fu restituita alla Repubblica batava; Niven, che ora non poteva più muoversi liberamente nel paese, rientrò in Inghilterra, ma, sempre stando a Main, dopo solo tre mesi tornò in Sudafrica, al servizio di un consorzio che comprendeva il vivaio Lee & Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Anche questa notizia è imprecisa; secondo Nelson e Rourle, egli invece dovette tornare in Sudafrica nel 1805. Infatti per poter raccogliere nel paese tornato sotto controllo olandese era necessario un permesso; quest'ultimo venne rilasciato a Niven in data 3 aprile 1805, limitatamente alle piccole aree di Riebeek-Kaastel e Roodezand. Tuttavia già nel gennaio 1806 i britannici rioccuparono la colonia, e dal quel momento Niven potè muoversi liberamente; vi sarebbe rimasto per altri sei anni, fino al 1812. Durante i due soggiorni sudafricani, Niven esplorò gran parte della colonia del Capo; a nord si spinse fino al Kamiesberg, il massiccio più elevato del Namaqualand, dove raccolse Vexatorella alpina (pubblicata da Knight come Protea alpina); a est percorse le catene che corrono lungo la costa (monti di Riviersonderend, Langeberg e Outeniqua) e ancora più a est, attraverso la valle Langekloof, dove raccolse Protea tenax, raggiunse Kromme River e Gamtoos River, il punto più orientale dei suoi viaggi, Tuttavia raccolse la maggior parte degli esemplari in un raggio di 150 km da Città del Capo; i suoi luoghi di raccolta preferiti risultano i distretti di Tulbagh, le catene Drakenstein e Hottentots Holland e il monte di Worcester. I suoi committenti desideravano soprattutto semi e bulbi, Ciò significava esplorare ciascuna area almeno due volte: la prima durante la stagione di fioritura per identificare le specie e raccogliere esemplari d'erbario, la seconda qualche mese più tardi per raccogliere i semi. Per ritrovare con facilità le piante e identificarle con sicurezza, Niven creò per se stesso un erbario di campo: su ogni foglio di pesante carta grigiastra incollava più esemplari (mediamente tre) corredati da precise note sul luogo di raccolta, la stagione di fioritura, l'habitat, le caratteristiche ecologiche, talvolta il tipo di suolo. Le raccolte di Niven sono particolarmente importanti per due famiglie largamente presenti in Sudafrica, le Proteaceae e le Ericaceae. Grazie alle sue raccolte delle prime, George Hibbert ne poté vantare la più ampia collezione europea, Knight specializzarsi nella loro coltivazione, Salisbury e Brown pubblicare decine di nuove specie. Una delle più rare è Leucospermum grandiflorum, che nel 1799 fu raccolta sia da Roxburgh sia da Niven. Secondo Salisbury, che la descrisse in Paradisus Londinensis nel 1808, i semi raccolti da Niven furono seminati nella serra di Hibbert dove prosperarono. Anche per le Ericaceae (molte furono pubblicate da Henry Cranke Andrews nei sei volumi di The Heathery, le raccolte di Niven hanno grande importanza storica. Secondo Aiton, le specie di Erica introdotte da Niven in Gran Bretagna sono 31, un risultato notevole se si pensa che Masson nel corso dei suoi tre viaggi ne aveva già introdotte 86. E se i numeri sono inferiori, in compenso i dati relativi ai luoghi di raccolta e agli habitat sono di gran lunga più accurati rispetto a quelli del suo predecessore. Secondo la testimonianza del curatore dell'orto botanico di Edimburgo William McNab, che ebbe con lui molte conversazioni sull'argomento dopo il suo ritorno in Scozia, "il mio molto compianto amico James Niven certamente sapeva sulla natura e sulla coltivazione di questo genere più di ogni altro uomo che io abbia mai incontrato". 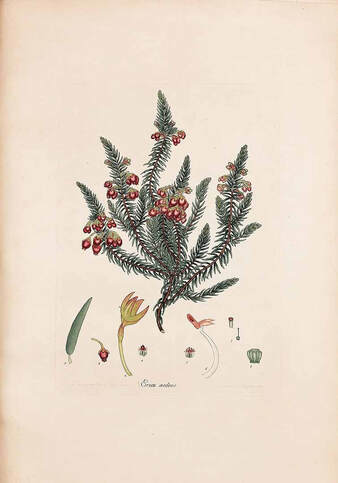 Miti e affabulazioni Dopo il suo ritorno in patria, sempre stando a Main, Niven "abbandonò le sue attività botaniche e orticole" e ritornò a Penicuik, dove aprì un'attività (non sappiamo di che genere) insieme a un fratello. Nel 1817 sposò Alison Abernethy (lo sposo aveva 40 anni, la sposa 26), da cui ebbe 5 figli; nel 1827, ad appena 50 anni morì. Main non manca di aggiungere un particolare melodrammatico: non appena la sua bara lasciò la casa, la vedova morì all'istante, lasciando cinque piccoli orfani. Documenti alla mano, è un altro mito: forse davvero per il dolore la donna ebbe un infarto o un ictus, ma morì e fu sepolta quattro settimane dopo il marito. La situazione dei bambini era comunque difficile, e i loro tutori furono costretti a vendere l'erbario; l'acquirente fu il già citato William McNab; passato al figlio John, capo giardiniere dell'orto botanico di Edimburgo, poi al nipote William Ramsay McNab, l'erbario finì a Dublino quando il suo ultimo possessore ottenne la cattedra di botanica al Collegio reale d'Irlanda. Alla sua morte precoce nel 1889, la vedova fu costretta a mettere in vendita la biblioteca, gli strumenti scientifici e l'erbario del marito, che comprendeva anche quello di Niven. In parte fu acquistato dal Museo nazionale irlandese (oggi è custodito all'erbario di Glasnevin), in parte dai Kew Gardens. Una serie di duplicati, forse in qualche modo acquisiti da Harvey, si trovano invece al Trinity College. L'erbario, già diviso, fu ulteriormente smembrato, e in parte rimase sconosciuto fino agli anni '70 del Novecento, quando venne in un certo senso "riscoperto" e studiato da un altro specialista di Proteaceae ed Ericacae, Ernest Charles Nelson dell'erbario dell'orto botanico di Glasnevin a Dublino, che si è anche incaricato di sfatare alcuni dei miti che hanno offuscato la vera storia di James Niven, Ne rimane uno, forse il più diffuso e tenace. Tra i personaggi più noti dell'orticultura irlandese troviamo Ninian Niven (1799-1879), che ridisegnò Phoenix Park, diresse per qualche anno l'orto botanico di Glasnevin, per poi diventare un affermato vivaista e un famoso architetto di giardini, nonché per diversi anni segretario della Royal Horticultural Society. Non è chiaro per quali ragioni, contro ogni evidenza, nel loro Biographical Index of British and Irish Botanists (1889) Boulger e Britten asserirono che Ninian Niven era figlio del nostro James Niven. Eppure Ninian Niven era nato a Kelvin Growe, presso Glasgow e suo padre, che si chiamava anche lui Ninian, era uno dei giardinieri di Keir House vicino a Stirling e non fu mai un cacciatore di piante. Senza contare che nel 1799 il nostro Niven aveva appena 22 anni ed era giusto arrivato in Sudafrica. I registri parrocchiali di Penicuik non lasciano dubbi: James Niven, come già sappiamo, si sposò quasi vent'anni dopo e nessuno dei suoi cinque figli era ovviamente Ninian Niven. Stranamente questa leggenda orticola è dura a morire: nel Dictonary of British Biography si legge: "suo padre, anche lui Ninian Niven, era un giardiniere di Keir House presso Stirling, e visitò due volte il Capo di Buona speranza raccogliendo piante per George Hibbert e l'imperatrice Giuseppina". Per concludere, un altro mito cinematografico. Nel notevole film Proteus, del regista canadese John Greyson, che racconta in modo romanzato la storia di due prigionieri giustiziati per sodomia in Sudafrica, compare un botanico scozzese chiamato Virgil Niven, ispirato a James Niven. A dispetto del fatto che la tragica vicenda sia avvenuta nel 1735, quarant'anni prima della sua nascita.  Iridaceae arbustive con fiori color cielo Il contributo di James Niven alla botanica e ai giardini britannici, da lui arricchiti di tante specie notevoli, è riconosciuto tanto da William Aiton, quando da Salisbury e Robert Brown, per una volta concordi. Lo ricordano gli eponimi di non molte specie sudafricane (Acmadenia nivenii, Erica niveniana, Serruria nivenii) e un genere ugualmente sudafricano, Nivenia. Glielo dedicò Ventenat sulla base di una delle molte specie da lui raccolte in Sudafrica e approdate alla Malmaison; in Decas Generum Novorum (1808) il botanico francese scrive: “questa specie è stata fornita dall’egregio Kennedy; perciò l’ho nominata dallo scopritore J. Niven, giardiniere inglese” (d'accordo, era scozzese, ma errore più errore meno...). Rispetto a questa laconica dedica, è ben più eloquente quella di Robert Brown per un secondo genere Nivenia (ovviamente non valido per la regola della priorità); dopo aver spiegato in che cosa il nuovo genere differisce da Paranomus di Salisbury, egli infatti scrive: "L’ho dunque nominato in onore di Mr. James Niven, un osservatore intelligente e un raccoglitore instancabile, con il quale i botanici sono indebitati di molte nuove specie delle due estese famiglie sudafricane delle Ericaceae e delle Proteaceae”. Nivenia Vent. è un piccolo genere della famiglia Iriaceae; insieme a Klattia e Witsenia, è uno dei soli tre generi della famiglia (tutti endemici del Sudafrica) a essere veri e propri arbusti sempreverdi, con fusti legnosi che producono vegetazione secondaria. Raggruppati nella sottofamiglia Niveoinioideae, tutti insieme comprendono appena quindici specie, contro le 1600 dell'intera famiglia (900 nel solo Sudafrica). Il genere più vasto del gruppo è proprio Nivenia, con undici specie accettate. Hanno tutte fiori azzurri e sono arbusti di medie dimensioni, con l'eccezione di tre specie a cuscino che crescono in habitat rocciosi aridi di montagna: N. levynsiae nelle Betty Bay-Kleimond Mountains, N. concinna al Viljoen Pass e N. fruticosa nel Lagenberg. Quest'ultima, di habitus quasi erbaceo e con un'infiorescenza poco vistosa di appena due fiori, fu la prima specie ad essere raccolta e descritta, da Peter Thunberg che la assegnò al genere Ixia. All'estremo opposto troviamo la specie più nota, l'unica coltivata al di fuori del Sudafrica, N. corymbosa, che cresce a Bain's Kloof e nelle montagne circostanti: gli esemplari più vecchi possono avere rami con un diametro di 4-5 cm lunghi anche tre metri. L'infiorescenza è un grande corimbo di circa 120 fiori in diverse tonalità di blu, che attirano folle di impollinatori, in particolare l'ape Amegilla fallax, dotata di una lunga ligula che le permette di raggiungere il nettare posto alla base del lungo tubo florale. A metà tra questi due specie estreme, si colloca la bella N. stokoei, un arbusto dal portamento arrotondato, che in aree protette può raggiungere il metro e mezzo, ma in aree aperte rimane molto più basso. Ha strette foglie lanceolate disposte a ventaglio che tradiscono immediatamente l'appartenenza alla famiglia, e fiori blu purissimo. E' un endemismo della Riserva della Biosfera Kogelberg. Tutte endemiche del Capo occidentale, spesso di aree estremamente limitate, purtroppo diverse specie di Nivenia sono in pericolo per la restrizione del loro habitat e anche per le conseguenze del cambiamento climatico. Tutte le sue undici specie sono incluse nella lista rossa delle piante sudafricane, due sono classificate come vulnerabili e cinque come rare. Nelle riviste inglesi a cavallo tra Settecento e Ottocento, ci si imbatte continuamente nel nome del ricchissimo mercante George Hibbert che nel suo giardino di Clapham possedeva una collezione di piante rare seconda solo a quella dei Kew Gardens; anzi la prima al mondo per le Proteaceae, le sue piante preferite. Nulla di strano che l'editore di una di quelle riviste, che era anche un pittore ed approfittò largamente di quelle raccolte per i suoi libri, lo abbia ringraziato con la dedica di una delle piante che fioriva nel suo giardino. Il problema è che il grazioso genere Hibbertia onora una persona che, dal punto di vista attuale, non merita di essere onorata: come collezionista e promotore dell'introduzione di nuove piante Hibbert fece molto per la botanica, è innegabile; tuttavia egli non solo doveva la sua ingentissima ricchezza allo schiavismo (in questo sarebbe in larga compagnia, a cominciare dai presidenti americani Washington e Jefferson) ma fu probabilmente il nome più in vista della lobby di mercanti, trafficanti e piantatori che cercò di bloccare l'approvazione della legge che mise fine alla tratta degli schiavi in Inghilterra; e alla fine fu anche profumatamente pagato per averlo fatto. Secondo alcuni botanici, la botanica non può lavarsene le mani; secondo altri, mettere in discussione un nome per ragioni che prescindono le regole botaniche apre un vaso di Pandora che fa crollare i principi cardini del Codice internazionale di nomenclatura. Il dibattito è aperto. 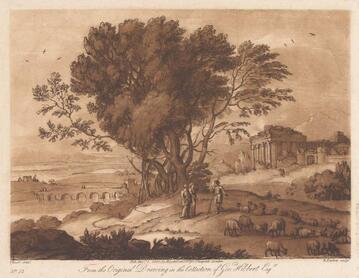 Il volto oscuro: lo schiavista Uno dei nomi che ricorrono con maggiore frequenza nelle pagine di The botanist's repository e del Curtis's botanical magazine nel ventebnnio tra il 1795 e il 1815 è quello di George Hibbert (1757-1837), nel cui giardino di Clapham fiorirono per la prima volta e furono disegnate molte delle novità presentate in quelle riviste. La sua collezione di piante rare provenienti da tutto il mondo rivaleggiava con quella dei Kew Gardens, ed era particolarmente ricca di specie del Capo, dove, come vedremo più avanti, operò per vari anni come cacciatore di piante uno dei suoi giardinieri, James Niven. Hibbert non era un mero collezionista di piante: era considerato un botanico più che dilettante, parlava fluentemente cinque lingue e ne capiva altre due, era un bibliofilo compulsivo e un po' megalomane che non badava a spese per acquisire libri rari, inclusa una copia della Bibbia di Gutenberg. Era membro di molti club e di società scientifiche, inclusa la Royal Society. Nel necrologio pubblicato sulla rivista della Linnean Society, James Main l'ha descritto come una persona che "ispirava fiducia e rispetto per il buon senso, la capacità di giudizio e la sagacia". Eppure questo stimato collezionista e botanofilo non solo doveva tutta la sua ricchezza al lavoro degli schiavi, ma fu anche il leader e il portavoce della lobby di mercanti e piantatori delle Antille britanniche che si oppose con tutte le forze all'abolizione della schiavitù. La famiglia Hibbert era coinvolta da lunga data nel commercio triangolare: il cotonificio del nonno e del padre, due agiati drappieri di Manchester, forniva cotonine e altre forniture ai trafficanti di schiavi; ma il vero salto di qualità si ebbe con lo zio Thomas, che si trasferì in Giamaica per recuperare le obbligazioni di alcuni trafficanti e in vent'anni divenne uno dei più ricchi piantatori dell'isola (possedeva tre estese piantagioni con oltre 900 schiavi); si fece costruire la più bella casa di Kingston, Hibbert House, oggi sede del National Trust della Giamaica. Grazie al successo e ai contatti di Thomas, gli Hibbert rimasti in Inghilterra, da drappieri e fornitori, si trasformarono in mercanti e armatori, specializzati nel commercio con la Giamaica. Nel 1770, un altro Thomas Hibbert, il fratello maggiore di George, si trasferì a Londra e insieme a due altri mercanti, John Purrier e Thomas Horton, fondò la ditta di import-export e trasporti navali Hibbert, Purrier & Horton che importava prodotti coloniali e forniva merci (e prestiti) a piantatori e trafficanti. George si unì alla ditta di famiglia come socio giovane nel 1780 (all'epoca aveva ventitré anni) con un capitale di 1500 £, cui se ne aggiunsero altre 1000 alla morte del padre nel 1784. Meno di dieci anni dopo, era diventato il capo della ditta (ora, con l'ingresso di altri soci si chiamava Hibbert, Fuhr & Hibbert) e un membro eminente della lobby che difendeva gli interessi dei piantatori e dei mercanti delle Indie occidentali, la London Society of West India Planters and Merchants. Nel 1790, nella sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta sulla tratta degli schiavi, dichiarò di aver importato annualmente merci per un valore compreso tra 200.000 e 250.000 £ e di aver investito molti capitali in Giamaica sotto forma di prestiti ai piantatori. Almeno dal 1793, George Hibbert fu coinvolto in un progetto che stava molto a cuore ai lui e agli altri West Indiamen: la costruzione di una darsena riservata alle loro navi; infine autorizzata nel 1799 dal West India Dock Act, la darsena, collocata sull'Isola dei cani, fu inaugurata nel 1802; l'ingresso principale, posto all'estremità occidentale, presto noto come Hibbert Gate, era largo abbastanza da consentire l'ingresso di carri e vagoni, chiuso da una duplice cancellata di ferro e sormontato da una scultura che riproduceva una delle navi di George e soci, chiamata Hibberts. George Hibbert fu il primo presidente della West India Docks Company e negli anni successivi rivesti ripetutamente questo ruolo. Purtroppo, egli non doveva il suo largo seguito tra i West Indiamen solo alle abilità commerciali (la Hibbert, Fuhr & Hibbert era la prima per giro d'affari con la Giamaica) e alla grinta con cui difendeva i loro interessi: era anche il portavoce degli antiabolizionisti, e seppe muoversi con grande abilità manipolatoria e notevoli capacità dialettiche. Già nel 1790, quando era stato ascoltato dalla commissione parlamentare, aveva evidenziato che l'intera economia delle Antille britanniche - ma anche gran parte dell'industria manifatturiera della stessa Inghilterra - dipendeva dalla schiavitù; se questa fosse stata abolita, si andava incontro alla rovina, e migliaia di famiglie sarebbero state ridotte sul lastrico. Nel maggio 1789, una settimana dopo che Wilberforce ebbe pronunciato in Parlamento il suo celebre discorso abolizionista, i mercanti convocarono una riunione alla London City Tavern; Hibbert vi intervenne con un discorso di 40 minuti intitolato "L'indispensabilità della tratta degli schiavi" in cui cercò di demolire tutti gli argomenti di Wilberforce. L'anno dopo fu di nuovo ascoltato in Parlamento: per lui non era una questione morale, ma economica; la posizione degli abolizionisti era astratta (oggi si direbbe buonista o radical chic), andava contro i diritti e i privilegi acquisiti fin dai tempi di Elisabetta I, quindi la Common Law e il diritto consuetudinario; la schiavitù per altro non era neppure condannata dalla Bibbia, dove gli uomini erano considerati merci come tutte le altre. Proprio per difendere gli interessi dei West Indiamen (ovvero i suoi e dei suoi compari) si gettò anche in politica; già consigliere (alderman) della città di Londra dal 1798, nel 1802 si presentò come deputato per la City, ma non fu eletto; ebbe successo invece nel 1806, quando fu eletto senza opposizione nel collegio di Seaford (uno dei "borghi putridi" controllato dalla lobby dei mercanti delle Indie occidentali); nel suo primo discorso, nel febbraio 1807, dichiarò la sua assoluta ostilità all'abolizione della tratta e durante la discussione che avrebbe portato all'approvazione dello Slave Trade Act, intervenne in ogni passaggio cercando di bloccare la legge. Non ci riuscì, ma ottenne probabilmente ciò a cui mirava fin dall'inizio: l'approvazione di una mozione che garantiva il risarcimento ai piantatori e ai mercanti che traevano le loro ricchezze dalla schiavitù. La compensazione costò alla stato 20 milioni di sterline; Nick Hibbert Steel nel suo saggio sulla famiglia Hibbert l'ha chiamato il "prezzo dello zucchero". E' stato calcolato che agli Hibbert ne andarono 103.000 e allo stesso George Hibbert 16.000. Nel 1812 Hibbert fu nominato agente generale per la Giamaica, una posizione che mantenne fino al 1831, anche se già nel 1829 si ritirò a vita privata; nel 1824, aveva anche avuto modo di illustrarsi e come filantropo, in quanto membro fondatore e finanziatore di una società di soccorso navale, National Institution for the Preservation of Life from Shipwreck, precorritrice della Royal National Lifeboat Institution che ancora oggi nel proprio sito lo ricorda come benemerito fondatore.  Il volto luminoso: il collezionista Negli stessi anni in cui si metteva in luce in questo modo ai nostri occhi abominevole (ma non a quello di molti suoi contemporanei: nel 1812, quando si ritirò dal Parlamento, il leader dei whigs George Tierney lo nominò tra coloro "i cui servizi sarebbero stati rimpianti dalla nazione"), George Hibbert acquisiva grande rinomanza come collezionista di libri e proprietario di uno dei giardini più raffinati del paese. Come sostiene Katie Donington nel suo importante saggio dedicato alla famiglia Hibbert, The Bonds of Family, tra le due cose non c'è alcuna contraddizione: nel momento in cui una parte crescente dell'opinione pubblica incominciava a prendere le distanze dallo schiavismo, su cui si basava la sua ricchezza, il collezionismo era un modo per rendersi socialmente accettabile. Infatti Hibbert divenne un membro riconosciuto della comunità scientifica: nel 1805 lo troviamo tra i fondatori della London Institution, che anticipò l'Università di Londra nel rendere disponibile l'educazione scientifica ai dissidenti religiosi, esclusi dai college di Oxford e Cambridge; già membro della Linnean Society e della Antiquarian Society, nel 1811 fu ammesso alla Royal Society; nel 1816 entrò a far parte del Roxburghe Club, la più antica società di bibliofili del mondo. Non conosciamo con esattezza quando Hibbert abbia cominciato a collezionare libri e piante; nel 1829, quando si ritirò a vita privata e si trasferì a Munden House, una proprietà che la moglie aveva ereditato da uno zio, fu costretto a vendere la biblioteca; secondo il catalogo d'asta, di ben 8711 pezzi, non pochi dei quali rarissimi, la collezione era stata riunita dal proprietario in più di quarant'anni (dunque a partire dalla fine degli anni '80). Per quanto riguarda le piante, la prima data certa è il 1794: quell'anno Hibbert, che già possedeva una residenza a Portland Place, nel distretto di Marylebone, acquistò una casa e una proprietà chiamata The Hollies sul lato nord di Clapham (curiosamente, il distretto noto per essere stato la sede del movimento abolizionista noto come Clapham Sect o Clapham Saints). Allo stesso anno ci riporta il suo primo acquisto datato: alla fine del 1792 un altro ricco mercante e armatore, Gilbert Slater, legato alla Compagnia delle Indie, proprietario di un notevole giardino in Essex, inviò in Cina a caccia di piante il giardiniere scozzese James Main che fece buona caccia, riportando tra l'altro la famosa rosa Slaters' Crimson China; al suo ritorno nel 1794 però Slaters era deceduto da quasi un anno; le raccolte cinesi furono vendute e acquistate in parte dai Kew Gardens, in parte da Hibbert, che assunse Main come giardiniere (è dunque inesatta la notizia che si legge in Wikipedia inglese che già lavorasse per Hibbert in precedenza e che avesse viaggiato in Cina per conto sia di Hibbert sia di Slaters). Hibbert acquistò piante e semi, ma anche disegni cinesi: è dunque possibile che la passione per le piante sia nata indirettamente da quella per i libri e le opere d'arte. In ogni caso la vera passione di Hibbert divennero le Protee, forse perché erano rare, difficili da coltivare, dunque molto prestigiose. I semi delle prime erano state portate in Inghilterra da Masson tra il 1774 e il 1787; nel 1789 d verse specie furono descritte da Aiton in Hortus kewensis, il catalogo dei giardini reali di Kew che ne possedevano un'esclusiva collezione di 24 specie, diverse delle quali oggi assegnate ad altri generi della famiglia. Hibbert non voleva essere da meno e alla fine del 1798 o all'inizio del 1799 inviò in Sudafrica il giardiniere James Niven a fare raccolte di semi ed esemplari d'erbario; Niven rimase al Capo fino al 1803, quindi vi ritornò nel 1805, questa volta per un consorzio che oltre a Hibbert comprendeva il vivaio Lee e Kennedy (di cui secondo N. H. Steel Hibbert era "socio silente") e l'imperatrice Giuseppina, e vi rimase fino al 1812. Grazie alle sue raccolte, cui sia aggiunsero anche molte australiane, la collezione di Proteaceae di Hibbert divenne la più importante del mondo. Secondo le testimonianze del tempo, ne comprendeva circa 200 diverse specie che erano coltivate in vaso in una grande serra, dove trascorrevano i mesi invernali, per essere portate all'esterno nei mesi più caldi. Hibbert le affidò a un abilissimo giardiniere, Joseph Knight (1778-1855), che in precedenza aveva lavorato per il duca di Bedford; egli fu il primo in Europa a moltiplicarle tanto da talea quanto da seme. Hibbert (al contrario generoso con altre piante) era gelosissimo delle sue protee che scambiava solo con re Giorgio III e l'imperatrice Giuseppina. Nel 1809 Knight svelò i segreti della coltivazione delle preziose piante in On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae che, a dispetto del titolo, riserva solo una dozzina di pagine all'argomento, mentre più di 100 sono dedicate a una revisione tassonomica della famiglia; benché non firmata, fu subito noto che l'autore di quest'ultima era Richard Salisbury. Ne seguì una polemica con Robert Brown e l'accusa di plagio rivolta a Salisbury, come ha raccontato in questo post. Qui ci interessa la prima parte, che documenta le tecniche di coltivazione applicate nel giardino e nella serra di Hibbert; inoltre ci rivela un altro aspetto del contraddittorio personaggio: la generosità. Dopo aver accennato alle raccolte di Thunberg e Masson, Knight infatti scrive "Un numero ancora più grande di specie sia note sia ignote sono poi state raccolte da Mr. James Niven, molte delle quali hanno fiorito a lungo in questo paese, ma da nessuna parte in modo così lussureggiante come nella collezione del mio precedente padrone, l'egregio George Hibbert di Clapham, grazie alla cui liberalità molte di esse sono ora in mio possesso". Dunque Hibbert cedette almeno alcune delle sue esclusivissime Proteaceae al suo capo giardiniere e probabilmente lo aiutò a mettersi in proprio; infatti nel 1808 Knight acquistò un terreno a Chelsea e lo trasformò in vivaio; poiché era affacciato sulla trafficata King Road, presto vi aggiunse un negozio (un antenato di un fornito garden center); inoltre nel 1829, quando si ritirò per andare a vivere in campagna, Hibbert passò a Knight tutte le sue piante vive. Con questa formidabile iniezione di rarità, il vivaio di Knight (più tardi Knight & Perry, quando venne gestito dal marito di una nipote del fondatore) divenne uno dei più importanti del paese, nonché il primo a commercializzare le Proteaceae. Ma nel giardino e nella serra di Clapham si coltivava anche molto altro; per scoprirlo basta sfogliare i fascioli di The Gardener's Repository o del Curtis's Botanical Magazine, dove il nome di Hibbert ricorre con grande frequenza; molte delle novità presentate in queste riviste fiorirono e furono ritratte per la prima volta a Clapham. A dominare sono ovviamente le sudafricane, grazie alle raccolte di Niven; ci sono molte bulbose e una ricca selezione di eriche, diverse delle quali sono presentate in Coloured Engravings of Heaths, l'opera più significativa di Henry Cranke Andrews, il genero di John Kennedy, nonché illustratore e editore di The Botanist's Repository; significativamente "G. Hibbert, Esq., Clapham Common, Surrey" è citato per primo nella lista delle sette persone ringraziate per aver permesso all'artista di ritrarre dal vivo le loro collezioni.  Questa pianta profumerebbe di più con un altro nome? Se le sudafricane dominavano, a Clapham c'erano però anche molte australiane; in effetti, anche se commerciava soprattutto con la Giamaica, Hibbert aveva qualche interesse anche nelle nuove rotte del Pacifico aperte dai viaggi di Cook; come armatore fu sicuramente coinvolto in alcuni dei trasporti interoceanici di piante organizzati da Banks (incluso quello degli alberi del pane, fortemente voluto dei piantatori delle Antille) e nel trasporto dei forzati a Botany Bay. Australiano è anche il genere Hibbertia, che gli fu dedicato da Andrews nel secondo numero di The botanist's repository. La motivazione ci dà un quadro illuminante (e magari un po' adulatorio) della reputazione botanica di Hibbert: "In precedenza è stato erroneamente assegnato al genere Dillenia, ma poiché differisce da ogni genere descritto in precedenza, gli ho dato il nome dell'egregio sig. G. Hibbert di Clapham, Surrey, la cui conoscenza e fervore per le ricerche botaniche, così come la sua liberalità nell'arricchire le nostre collezioni da tutti gli angoli del mondo, ma soprattutto dal Capo di Buona Speranza, non sono superate da nessuno; ne sono certo, nessun nome merita un posto nella memoria della botanica più di quello di Hibbert". E lo stesso Andrews (la cosa non stupisce) dedicò a Hibbert anche un'Erica, appunta E. hibbertia. Hibbertia è un grande genere della famiglia Dilleniaceae, anche se il numero di specie è altamente dibattutoi: si va dalle 150 generalmente assegnatogli nei data base australiani alle 350 riconosciute da Plants of the World on line; il centro di diversità è proprio l'Australia, con oltre 100 specie; altre vivono in Nuova Guinea e nelle isole del Pacifico, una in Madagascar. In inglese sono note sotto il nome comune guinea flower, non per la provenienza ma perché il colore e la forma dei loro fiori ricorderebbero quelli di una ghinea d'oro. La cifra del genere è la varietà. Sono per lo più arbusti eretti, ma c'è anche qualche rampicante, come la specie più nota, H. scandens, o arbusti prostrati che formano tappeti, come H. procumbens. Molto variabili le dimensioni: se molti sono piccoli arbusti non più alti di una decina di centimetri, la già citata H. scandens può superare i 5 metri. Le foglie sono intere, alternate, spesso raggruppate lungo brevi rami laterali, e nelle specie che vivono in zone aride sono ridotte; molto variabili le forme. Ancora più variabile la morfologia dei fiori; possono essere o meno protetti da brattee, hanno cinque sepali, quelli esterni leggermente sovrapposti a quelli interni, e cinque petali che possono essere disposti a simmetria radiale o a simmetria bilaterale; variabile pure il numero degli stami, da sei a oltre trenta, in genere raggruppati in gruppi di due o tre, in modo simmetrico o anche da un solo lato dei carpelli. La grande maggioranza delle specie ha fiori giallo vivo, ma in alcune specie i petali come H. stellaris o H. minita sono arancione. Sono indubbiamente piante graziosissime, di grande valore ornamentali, spesso anche profumate. E' giusto che portino il nome di un personaggio le cui idee "erano considerate abominevoli da molti critici già al suo tempo"? Il botanico australiano Kevin Thiele - che per inciso è un esperto di questo genere, una componente importante di molte comunità vegetali del suo paese - pensa di no, tanto più che questo grande genere continua ad essere arricchito da nuove scoperte e nuove denominazioni; e continua: "Proprio come si eliminano statue, nomi di edifici, strade e sobborghi, pensiamo che sia necessario fare i conti con i nomi di specie scientifiche che onorano persone che professavano idee o hanno agito in modi profondamente disonorevoli, altamente problematici o ripugnanti per gli standard moderni". La sua denuncia è stata ripresa da altri autori ed è sfociata nella proposta di modificare l'articolo 51 del Codice internazionale di nomenclatura, in modo che divenga possibile rigettare i nomi formalmente validi che riflettono "il potere coloniale e imperialista" o sono da ritenersi "culturalmente offensivi o inappropriati", compresi quelli che onorano "una persona che la comunità tassonomica ritiene concordemente non debba essere onorata". La proposta è sconvolgente perché mette in discussione i principi stessi su cui si fonda il Codice internazionale di nomenclatura: la stabilità della nomenclatura, la libertà scientifica e la neutralità politica della scienza. Più ancora dell'articolo 51, che recita "un nome legittimo non può essere rigettato solo perché esso, o il suo epiteto, è inappropriato o sgradevole", a traballare è lo stesso primo preambolo, dove si legge: "Lo scopo di questo Codice è fornire un metodo stabile per nominare i gruppi tassonomici, evitando o respingendo l'uso di nomi che possono causare errore o ambiguità o mettere la scienza in confusione. Ogni altra considerazione, come la correttezza grammaticale, la regolarità e l'eufonia dei nomi, le consuetudini più o meno prevalenti, il riguardo per le persone, nonostante la loro innegabile importanza, è relativamente accessoria". Alle considerazioni di Thiele e altri (potete leggere una delle più recenti versioni qui) ha risposto il botanico ucraino Sergei L. Mosyakin (il suo punto di vista qui), che le ha respinte con un'articolata argomentazione. Il dibattito è aperto, e forse avrà nuovi sviluppi in occasione del XX congresso botanico internazionale, che si terrà a Madrid tra il 21 e il 29 luglio 2024. Da parte mia considero queste piante deliziose non dedicate al discutibile Mr. Hibbert, ma a tutte le persone le cui sofferenze furono prolungate per causa sua. Se nella generazione dei fondatori del vivaio the Vineyard di Lee e Kennedy la figura di maggior spicco fu James Lee, nella seconda generazione a mettersi in luce fu John Kennedy. Mentre il suo socio si occupava abilmente della conduzione del vivaio, Kennedy badava a far conoscere le ultime novità con i testi di The botanist repository, illustrati da suo genero Henry C. Andrews. A partire dal 1803, il vivaio incominciò a rifornire di piante esotiche il giardino della Malmaison e Kennedy divenne consulente dell'imperatrice Giuseppina, che stava ridisegnando il parco secondo i canoni del giardino all'inglese. Tra le tante esotiche che, a dispetto della guerra e del blocco continentale, the Vineyard continuò a spedire all'imperatrice dei francesi c'erano indubbiamente anche rose, sebbene forse meno di quanto comunemente si crede. Alla collaborazione con Mme Bonaparte Kennedy deve anche la dedica del genere Kennedia, istituito da Ventenat nel bellissimo Le jardin de la Malmaison, illustrato da Redouté.  Piante nuove e rare da tutto il mondo Il momento di massimo fulgore di the Vineyard coincise con la gestione del secondo dei Kennedy, John (1759–1842), figlio del fondatore Lewis. Dovette iniziare a lavorare nel vivaio fin da ragazzino, e nel 1782, alla morte del padre, gli succedette alla testa dell'azienda a fianco di James Lee e poi, alla morte di questi nel 1795, del figlio James junior. Certo, anche quest'ultimo dovette essere un validissimo uomo d'affari, come lo era stato il padre, se lasciò ai figli un notevole patrimonio che permise loro di rilevare l'intero vivaio, quando John Kennedy si ritirò; ma certamente dopo la morte di James Lee senior il volto ufficiale della ditta, il nome più riconosciuto anche a livello internazionale, fu quello di Kennedy. La seconda generazione di the Vineyard rimase fedele alla strategia già adottata dai fondatori: cercare, moltiplicare e commercializzare piante "nuove e interessanti" e "novità di valore", come si legge in una lettera di James Lee junior a William Aiton. Un documento di grande interesse per conoscere le introduzioni del vivaio a cavallo dei due secoli sono i primi cinque fascicoli di The botanist repository, i cui testi furono redatti in gran parte dallo stesso John Kennedy. La rivista, che uscì tra il 1797 e il 1814, come ben specifica il sottotitolo for new and rare plants, era specificamente dedicata alle piante di recentissima introduzione e fu il più serio concorrente del Curtis's Botanical Magazine, rispetto al quale aveva meno pretese di scientificità: le illustrazioni, disegnate da Henry Cranke Andrews, che era anche l'editore, erano di grande impatto visivo, ma spesso imprecise e mancanti di particolari utili all'identificazione, così come i testi erano diseguali e privi di sinonimi e rimandi bibliografici. La rivista infatti non si rivolgeva tanto ai botanici quanto agli amatori e ai proprietari di giardini. Le illustrazioni di Andrews sono accompagnate da una breve descrizione bilingue (in latino e in inglese) e da un testo inglese con informazioni sulle peculiarità più desiderabili della pianta, la sua provenienza, le date di introduzione e di prima fioritura, le esigenze di coltivazione. Come ho anticipato, i testi dei primi cinque fascicoli, anche se non sono firmati, furono con grande probabilità scritti da John Kennedy; quelli del vol. 6 si devono a Adrian Haworth e quelli dei voll. 7-10 a George Jackson (voll. 7-10). Andrews forse fu incoraggiato a intraprendere l'impresa proprio da John Kennedy, che nel 1801 divenne suo suocero. Nei volumi curati da Kennedy, usciti tra il 1797 e il 1811, 40 specie risultano direttamente introdotte o almeno coltivate nel vivaio di Hammersmith (citato invece una sola volta nei volumi successivi). Ci sono parecchie bulbose, piante da fiore, arbusti, qualche succulenta, alcune orchidee, ma non sembra prevalere un indirizzo preciso nella scelta delle specie. La data di introduzione più bassa è il 1772, la più alta il 1800 (l'unica specie citata nei volumi successivi risale invece al 1813). Diciassette specie (42.5%) provengono dal Capo di Buona speranza; dodici (30%) dall'Australia o dalla Nuova Zelanda, il resto dal Nord America, dalle Barbados, dalla Giamaica, dal Brasile, dalla Crimea e da Madera. Spesso il testo si limita a indicare che la pianta è stata introdotta da Lee e Kennedy o che è fiorita per la prima volta nel loro vivaio, ma talvolta ci sono indicazioni più specifiche, illuminanti per ricostruire le vie di introduzione. I due vivaisti potevano all'occorrenza rifornirsi da altri vivai: è il caso di Gladiolus praecox (oggi G. watsonius), acquistato nel 1791 presso Voorhelm & Co. di Haarlem, un vivaio olandese specializzato in bulbi da fiore; o di Rhododendron punctatum (oggi R. minus var. minus), reperito presso il vivaio dell'introduttore, il celebre vivaista e cacciatore di piante James Fraser. Più spesso però ricorrevano agli invii di viaggiatori o residenti all'estero a vario titolo: l'orchidea Prosthechea cochleata fu inviata dalla Giamaica dal botanico dell'isola Thomas Dancer, tramite una certa Mrs. Barrington; un'altra orchidea, Orchis ciliaris (oggi Platanthera ciliaris) fu spedita da Filadelfia da John Lyon, che all'epoca lavorava ancora come giardiniere; diverse piante sudafricane furono procurate da John Pringle, funzionario della Compagnia delle Indie al Capo; la brasiliana Amaryllis reticulata (oggi Hippeastrum reticulatum) fu spedita dal Portogallo da Edward Whitaker Gray. futuro curatore delle collezioni naturali del British museum, all'epoca residente ad Oporto dove aveva sposato l'erede di un importante esportatore di vini. Lee e Kennedy però avevano anche relazioni con orti botanici e studiosi: Pallas inviò i semi di due specie dalla Crimea e i semi di due piante del Capo furono forniti dal curatore dei giardini imperiali di Vienna, ovvero da von Jacquin. Non mancavano gli apporti di collezionisti, probabilmente al tempo stesso fornitori e clienti: è il caso di lady Sophia de Clifford, celebre per la sua collezione di piante esotiche, che condivise con Lee e Kennedy i bulbi di Ixia crispifolia flore coeruleo (oggi Codonorhiza corymbosa) appena ricevuti dal Capo e procurò altre piante sudafricane; oppure di Thomas Jones, creatore del giardino di Hafod in Galles che procurò Geranium punctatum (oggi Pelargonium punctatum). Tra questi contributori illustri, spicca il colonnello William Paterson, dal 1791 al 1793 governatore dell'isola di Norfolk, da cui inviò semi sia a Kew sia ai vivai Lee e Kennedy e Colvill; è citato per più piante tra cui Bignonia pandorana (oggi Pandorea pandorana). Quello di Paterson è l'unico nome menzionato per l'Australia (all'epoca Nuova Olanda); gli altri invii potrebbero essere dovuti a cacciatori di piante, quelli antecedenti il 1792 (l'anno della sua morte) forse a David Burton, che sappiamo lavorò sia per Kew sia per Lee e Kennedy. Potrebbe essere un cacciatore di piante l'altrimenti ignoto Mr. J. Elcock cui si deve l'invio di due specie dalle Barbados tra il 1789 e il 1791. Alcuni degli invii dal Sudafrica e forse anche uno da Madera potrebbero risalire a Francis Masson, che però è citato esplicitamente solo per Protea formosa (oggi Leucospermum formosum). Anche se non è citato in The botanist repository, diverse piante sudafricane furono presumibilmente procurate da James Niven, che nel 1798 o 1799 fu inviato al Capo dal ricco appassionato George Hibbert,per poi tornarvi nel 1805 finanziato da un consorzio di appassionati, giardinieri e vivaisti che, oltre a Hibbert, includeva Lee e Kennedy e l'imperatrice Giuseppina. Fornitore della Malmaison Siamo così arrivati alla più celebre dei clienti di the Vineyard: Joséphine de Beauharnais, la prima moglie di Napoleone. Nel 1799, mentre il marito si trovava in Egitto, ricorrendo a un prestito, essa acquistò il castello e il parco della Malmaison, a una quindicina di km da Parigi. Durante il consolato, divenne la residenza dei Bonaparte e tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuileries, fu sede del governo francese, prima di essere sostituita dal più istituzionale Saint Cloud. Per Joséphine era il luogo del cuore, e dopo il divorzio nel 1809 divenne la sua casa. I grandi lavori di trasformazione erano iniziati fin da subito. A partire dal 1800, venne costruita un'aranciera in stile neoclassico, così grande da poter ospitare 500 vasi di ananas; il parco venne ridisegnato secondo lo stile paesaggistico inglese; l'imperatrice si affidò dunque a specialisti britannici come il capo giardiniere Alexander Howatson eil giardiniere paesaggista scozzese Thomas Blaikie, che viveva in Francia da tempo e prima della rivoluzione aveva creato il giardino di Bagatelle per il conte di Artois e il parco Monceau per il duca d' Orlèans. Fu forse proprio Blakie a mettere in contatto Joséphine con Lee e Kennedy. La Malmaison era un giardino sperimentale ricco di piante provenienti da tutto il mondo. Molte piante australiane (ma anche animali) giunsero in seguito alla spedizione Baudin: l'allora prima console aveva ordinato che gli esemplari più belli, anziché al Museo di storia naturale, fossero portati alla Malmaison, il cui parco cominciò a popolarsi di eucalipti e mimose, tra cui scorrazzavano emù e canguri mentre sul laghetto si dondolavano cigni neri. Per avere un angolo da riservare alla sua passione per la botanica, tra il 1803 e il 1805 l'imperatrice fece costruire la Petite Malmaison, che comprendeva una grande serra calda per le esotiche, il primo edificio in Francia a fare ampio uso di vetrate. Contemporaneamente assunse come intendente il botanico Étienne Pierre Ventenat, il curatore del giardino-vivaio di Jacques Cels a Montrouge. Proprio come Lee e Kennedy in Inghilterra (con i quali corrispondeva) Cels era specializzato nella coltivazione e nella propagazione delle piante esotiche riportate dai naturalisti viaggiatori come Michaux o dai grandi viaggi di esplorazione. Egli si riforniva anche dai vivai inglesi ed era in ottime relazioni, nonostante lo stato quasi permanente di guerra, con Joseph Banks. Di questi contatti inglesi poterono approfittare anche il giardino della Malmaison e la sua proprietaria quando la pace di Amiens portò un breve periodo di tregua (marzo 1802-maggio 1804). Attraverso Ventenat, Joséphine si mise in contatto con Banks, che promise il suo aiuto nonché piante di Kew. In una lettera dell'aprile 1803, che accompagna il primo volume dello splendido catalogo Le Jardin de la Malmaison, con i suoi testi e le illustrazioni di Redouté, il botanico ringrazia Banks per le piante finora fornite e esprime l'augurio che la collaborazione posso continuare. Lo stesso anno, Lee e Kennedy ricevettero il primo ordine di piante per il giardino, per l'ammontare di 2600 sterline. Nel 1804, l'imperatrice lamentò accorata che un invio di semi era stato catturato e trattenuto, ma è uno dei rari incidenti di percorso: anche più tardi, quando il blocco continentale in teoria chiuse i porti di Francia ai vascelli inglesi, si continuò a fare eccezione per le navi che trasportavano le piante per i giardini dell'imperatrice. Un altro contatto inglese era George Hibbert, che, consultato per la progettazione del giardino all'inglese, dovette consigliare all'imperatrice di rivolgersi a Kennedy non solo come fornitore, ma anche come giardiniere paesaggista. Da quel momento, come consulente di Joséphine James Kennedy iniziò a fare la spola tra i due paesi, magari per accompagnare di persona qualche pianta particolarmente delicata, e suo figlio Lewis Kennedy (1789-1877) lavorò addirittura per qualche tempo sia alla Malmaison sia a Navarre, la tenuta normanna donata all'ex imperatrice dopo il divorzio (un po' come compensazione, un po' per tenerla lontana da Parigi in occasione delle seconde nozze dell'imperatore). Tra i più importanti risultati della collaborazione tra Mme Bonaparte e il vivaio inglese ci fu l'invio in Sudafrica del raccoglitore James Niven, che probabilmente ritornò al Capo nel 1805 e vi rimase fino al 1812, arricchendo il vivaio di Hammersmith e il giardino parigino soprattutto di eriche (il suo viaggio sudafricano però merita un post a parte). Tutti sanno che la piante preferite di Joséphine erano le rose; lo sanno tutti, ma non è detto che sia vero. Mentre conosciamo bene le piante esotiche coltivate alla Malmaison grazie al già citato catalogo curato di Ventenat e Redouté, proprio la collezione di rose è mal documentata, tanto da essere ritenuta da alcuni più un mito che una realtà. Coloro che visitarono il giardino subito dopo la morte non ne parlano; il celebre Les roses di Redouté, che di solito è ritenuto una sorta di catalogo del roseto dell'imperatrice, in realtà fu creato dal pittore dopo la sua morte (i tre volumi uscirono tra il 1817 e il 1824), ritraendo le rose coltivate in vari giardini e vivai parigini; in precedenza ne aveva dipinte alla Malmaison solo due - R. berberifolia e R. gallica purpurea veluntina. Anche se in molti testi si parla di una collezione di 250 diverse varietà di rose (e alcuni si spingono a specificare quali), le accurate ricerche del collezionista di rose antiche François Jouyaux hanno potuto identificarne solo una minima parte. Lee & Kennedy, insieme a molte esotiche, procurarono certamente all'imperatrice anche rose, in particolare le cinesi rifiorenti che in Francia erano ancora una novità, mentre avevano già incominciato a raggiungere l'Inghilterra da qualche anno - la prima fu introdotta proprio da loro nel 1787; dagli archivi nazionali risultano come introdotte tramite il vivaio di Hammersmith Rosa chinensis, R. multiflora ‘Cornea’, R. semperflorens (generalmente nota come Slaters Crimson China) e la rosa muschiata R. centifolia ‘muscosa alba’ (nota come Shailers White Moss). Dai documenti d'archivio, risulta inoltre che Joséphine importò tramite fornitori non identificati R. pendulina, R. virginiana, tre rose muschiate, una centifolia nota come ‘Unique’. Un altro esperto, Auguste de Pronville, ha aggiunto alla lista R. damascena carnea, una varietà della scozzese R. spinosissima e R. berberifolia. Presumibilmente, l'imperatrice si rifornì anche da vivai parigini, come Cels, Boursault e Vilmorin, ma negli archivi sono testimoniati acquisti solo dal coltivatore di rose amatoriale André du Pont che tra il 1808 e il 1809 procurò molte rose; purtroppo le fatture non ne riportano il nome. Un genere australiano per un grande introduttore di australiane
Anche se l'idea che la malinconica ex-imperatrice abbia acceso la scintilla della coltivazione delle rose in Francia è probabilmente sopravvalutata (a diffonderla, dopo la sua morte, sarebbero stati gli ibridatori di rose come Vibert, alla ricerca di un precedente romantico e nobilitante), resta il fatto che Lee & Kennedy lasciarono il segno nella storia della coltivazione delle rose diffondendo anche nel continente le cinesi: gli ibridatori francesi, incrociandole tra loro e con altre rose, avrebbero prodotto il primo ceppo di rose rifiorenti, le ibride perpetue. Non è alle rose, ma forse più giustamente a un'esotica australiana che John Kennedy deve il suo ingresso nel pantheon dei dedicatari di generi di piante. Il genere Kennedia è un tributo di Ventenat che in Le jardin de la Malmaison così scrive: "Devo i frutti di questa pianta e delle due successive allo zelo e alla benevolenza di M. Kennedy", definito in un altro passo "abile botanico e celebre vivaista inglese" e ripetutamente citato nel libro come fornitore di piante e semi. Kennedia (Fabaceae) è un genere endemico dell'Australia che comprende circa 14 specie di arbusti prostrati, ricadenti o rampicanti con sottili fusti legnosi, foglie composte per lo più tomentoso, solitamente trifoliate, e vistosi fiori papilionacei in technicolor: K. lateritia li ha rosso vivo, K. coccinea rosso aranciato con ali rosa e centro giallo, K. procurrens da viola a blu, K. prorepens da viola ad azzurro chiaro, K. nigricans quasi neri con macchie gialle e arancio; a diminare è comunque il rosso in infinite sfumature. Molte Kennedia sono vigorosi rampicanti che in Australia vengono anche utilizzati in interventi di rivegetazione: K. rubicunda può raggiungere un'altezza di cinque metri in una sola stagione. Relativamente rustica, è talvolta proposta anche dai nostri viavai, così come K. coccinea, di portamento prostrato e utilizzabile come tappezzante. Una selezione di specie e qualche informazione in più nella scheda. Rispetto alla conterranea, e quasi coetanea, Mary Barber, la figura di Caroline Hutton nata Atherstone è molto più convenzionale, anche se non mancano i tratti comuni: entrambe erano figlie di coloni del 1820, vissero nella Provincia orientale del Capo e divennero addirittura parenti; entrambe raccolsero esemplari per Harvey e Hooker, venendo ricordate dal primo con la dedica di un genere. Diversi furono invece i loro ambienti sociali e soprattutto la dedizione alla scienza. Caroline Atherstone era figlia e sorella di medici dai notevoli interessi scientifici e si trovò fin da bambina immersa in un ambiente colto e aperto; molto giovane sposò Henry Hutton, un funzionario dell'amministrazione civile, da cui ebbe moltissimi figli. Insieme a lui è ricordata da Harvey per le sue raccolte botaniche che non dovettero essere il centro della sua vita come per Barber, ma un hobby o una passione secondaria, sebbene abbastanza forte da persistere e forse intensificarsi anche quando era un'anziana vedova. Harvey le dedicò il genere di orchidee Huttonaea, la cui prima specie fu da lei scoperta sul Katberg. 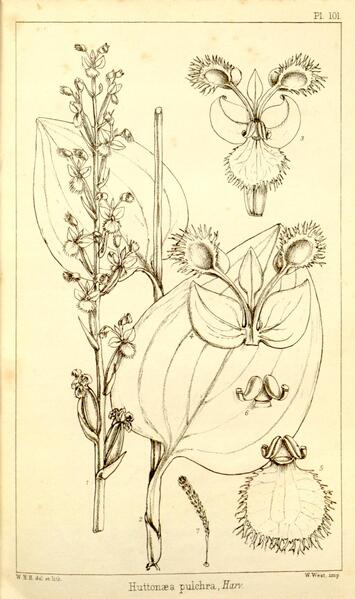 Raccolte in famiglia Come la famiglia Bowker, anche il dottor John Atherstone arrivò in Sudafrica con i coloni del 1820, ma, anziché diventare un fattore e un allevatore di bestiame, per qualche anno lavorò come chirurgo a Città del Capo, quindi nel 1828 venne nominato chirurgo del distretto di Albany sulla frontiera orientale, stabilendosi a Grahamstown. Quasi immediatamente fondò un gabinetto di lettura; fu qui, o dalla sua fornita biblioteca privata, che miss Bowker, ovvero la futura Mary Elizabeth Barber, prese in prestito la copia di Genera of South African Plants grazie alla quale scoprì la botanica. Del resto, era destinata a intrecciare strettamente la sua vita con quella della famiglia del medico: alla fine del 1839, il figlio maggiore di John Atherstone William Guybon tornò dall'Europa, dove era andato a laurearsi in medicina, accompagnato da uno dei suoi cugini inglesi: Frederick William Barber, ovvero il futuro marito di Mary. Oltre a diventare il più eminente medico della regione (tra l'altro, fu il primo a utilizzare l'anestesia durante un intervento chirurgico), William Atherstone aveva forti interessi scientifici. In Europa aveva studiato successivamente a Dublino, Londra e Parigi, ed era in contatto con molti scienziati tra cui Harvey e Hooker. Fu uno dei pionieri delle ricerche geologiche e paleontologiche in Sudafrica e nel 1855 fu tra i soci fondatori della Literary, Scientific and Medical Society di Grahamstown, le cui collezioni presto si trasformarono nell'Albany Museum, di cui per molti anni fu presidente e il maggior donatore, con esemplari che spaziavano in tutti i campi delle scienze naturali. Ma protagonista di questa storia non è il versatile dottore (cui pure il botanico della colonia Pappe dedicò il genere Athestonea, oggi ridotto a sinonimo), ma la più giovane delle sue sorelle, Caroline (1826-1908). Di lei non sapremmo nulla se non avesse lasciato traccia delle sue raccolte nei libri di Harvey e nei cataloghi dell'Albany Museum. Ignoriamo se abbia ricevuto una formazione formale, ma certo, nata in una famiglia colta, avrà condiviso l'interesse per le scienze naturali del brillante fratello maggiore, così come una delle sue sorelle, Bliss Ann (nota con il cognome da sposata White) che dopo il matrimonio fece importanti raccolte di rettili, insetti e altri animali nei dintorni di Brak Kloof, la fattoria che gestiva con il marito, donandole al museo di Albany. Nel 1848, la ventunenne Caroline sposò Henry Hutton che era arrivato in Sudafrica quattro anni prima; figlio di un pastore protestante, diciassettenne al momento del suo arrivo, forse per qualche tempo aveva lavorato per il futuro suocero, facendosi notare per l'intelligenza e gli interessi scientifici. Poi, forse con un spintarella di suocero e cognato, cui dovette essere legato da una forte amicizia, fece carriera; anche se durante le diverse guerre contro gli Xhosa egli ebbe anche qualche ruolo militare, servì soprattutto come impiegato pubblico, con compiti come sovrintendente dei forzati, giudice di pace, ispettore del dipartimento dei forzati, nonché tesoriere e segretario del Consiglio di divisione di Bedford, che lo portarono in varie località del distretto di Albany. Di tanto in tanto gestì anche una fattoria, anche per mantenere una famiglia sempre più numerosa (gli Hutton ebbero cinque figli e sette figlie, anche se solo sei raggiunsero l'età adulta). Probabilmente incoraggiati dal fratello e cognato, che era già in contatto con Harvey, forse già intorno al 1850 Caroline e Henry iniziarono a raccogliere esemplari e a inviarli a Dublino, come risulta dalla prefazione del primo volume di Flora capensis (1859), in cui il botanico ringrazia "l'egregio sig. Henry Hutton per le considerevoli raccolte fatte ad Albany". La collaborazione continuò per molti anni, anche oltre la morte di Harvey, quando il compito di completare l'opera fu assunto da Sonder e Tylseton-Dyer; i coniugi Hutter contribuirono con non meno di 120 diverse specie; come raccoglitore è in genere citato Henry, ma in una trentina di casi Caroline. Probabilmente spesso raccoglievano insieme e le raccolte dell'uno e dell'altra sono indistinguibili, ma a mantenere i contatti con Dublino e Londra provvedeva soprattutto il marito. Oltre che con Harvey, la coppia collaborò anche con il botanico coloniale Pieter MacOwan che nel 1867 cita Henry come uno dei cinque raccoglitori che avevano esplorato a fondo il distretto di Grahamstown. I coniugi Hutton spedirono esemplari anche a Hooker e ai Kew Gardens, ma il grosso delle loro raccolte fu donato al Museo di Albany, soprattutto dopo il 1891, quando si trasferirono nella fattoria Beaumont sul Fish River. Dopo la morte del marito nel 1896, Caroline, che ormai aveva settant'anni, continuò a raccogliere da sola. Nel 1900 viveva a Howick nel KwaZulu-Natal, da dove spedì 186 specie all'Albany Museum; altre spedizioni seguirono negli anni successivi, fino alla sua morte nel 1908.  Orchidee belle e rare Oltre che nel museo di Albany e nell'erbario del Natural History Museum, i coniugi Hutton hanno lasciato una traccia visibile nella nomenclatura botanica. Henry è ricordato da Lysimachia huttonii, che gli fu dedicata da Harvey già nel 1859; Moraea huttonii; Cyrtanthus huttonii, da lui raccolto nella distretto di Albany prima del 1864, data in cui fiorì per la prima volta a Kew; Ceropegia huttonii raccolta sul Botha Hill presso Grahamstown; Eulophia huttonii, Harveya huttonii, Printzia huttonii, Hesperantha huttonii e Wahlenbergia huttonii, tutte raccolte sul Katberg. Mancò invece la dedica di un genere, anche se forse ci contava. Sempre sul Katberg, una montagna a nord di Fort Beaufort, evidentemente il suo luogo di raccolta preferito, scoprì una pianta appartenente a un nuovo genere; ma Harvey la chiamò Bowiea volubilis, dedicandola, anziché a lui, al raccoglitore di Kew James Bowie. Caroline è ricordata da un numero molto minore di specie: Euphorbia huttoniae, Nerine huttoniae (oggi N. laticoma subsp. huttoniae), Sisyranthus huttoniae, Lachnagrostis huttoniae, le ultime tre risalenti agli anni della vedovanza, quando poteva "firmare" le sue raccolte senza lo schermo del marito. Se Harvey non le dedicò neppure una specie, al contrario di quanto fece con Henry, la compensò con un genere oltre tutto di notevole bellezza. Il secondo volume di Taesaurus capensis ( dedicato a suo fratello William che, ci informa Harvey, insieme a Henry Hutton, fu anche suo agente per la diffusione in Sudafrica di quest'opera e di Flora capensis), si apre con Huttonaea pulchra, una splendida e curiosa orchidea scoperta "nel marzo 1862 in angoli umidi, sotto gli alberi, sul Katberg, a 4000 piedi d'altezza, da Mrs. Henry Hutton". Ovvero dalla nostra Caroline. Il genere Huttonaea comprende cinque specie di orchidee terrestri endemiche di un'area ristretta alle montagne di Capo Orientale, KwaZulu-Natal, Stato Libero e Mpumulanga, con piogge estive. Tre specie (Huttonaea grandiflora, H. oreophila e H. woodii) vivono in spazi aperti erbosi, mentre le altre due (H. fimbriata e H. pulchra) nell'ombra delle foreste. La specie più diffusa, nonché quella che si spinge più in alto, è H. grandiflora (tra 2190 e 2800 m, dal Capo Orientale allo Stato Libero meridionale attraverso le montagne del KwaZulu-Natal), mentre la più rara è H. woodii che è stata raccolta solo tre volte in località diverse del KwaZulu-Natal. A seconda della specie, i fiori, raccolti in tozzi racemi, possono essere più piccoli e numerosi (fino a 25), oppure più grandi e pochi (2-4), ma tutti sono caratterizzati da una morfologia singolare: i sepali sono piatti, spesso verdastri, quelli superiori più o meno divergenti; i petali e il labello, da bianchi a crema, con macchie porpora, hanno margini fortemente sfrangiati; i petali hanno un'unghia più o meno lunga e sono più o meno fortemente saccati; formano così due sacchi gemelli (merianthium), una caratteristica rara tra le angiosperme e unica tra le orchidee, provvisti alla base di verruche ghiandolari che secernono olio: un "premio" ambitissimo dagli insetti impollinatori, le api del genere Rediviva. Mentre nelle altre specie l'angolo tra i petali permette a un insetto posato al centro del fiore di visitare contemporaneamente i due sacchi, in Huttonea pulchra essi formano un'angolo di 90 gradi, facendo divergere i sacchi e costringendo l'ape a visitarli separatamente. Anche se non è del tutto chiaro quali vantaggi comporti in termini di successo dell'impollinazione, è una caratteristica singolare che rende ancora più affascinante questa piccola orchidea scoperta nei boschi del Katberg da Caroline Hutton nel lontano 1862. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|
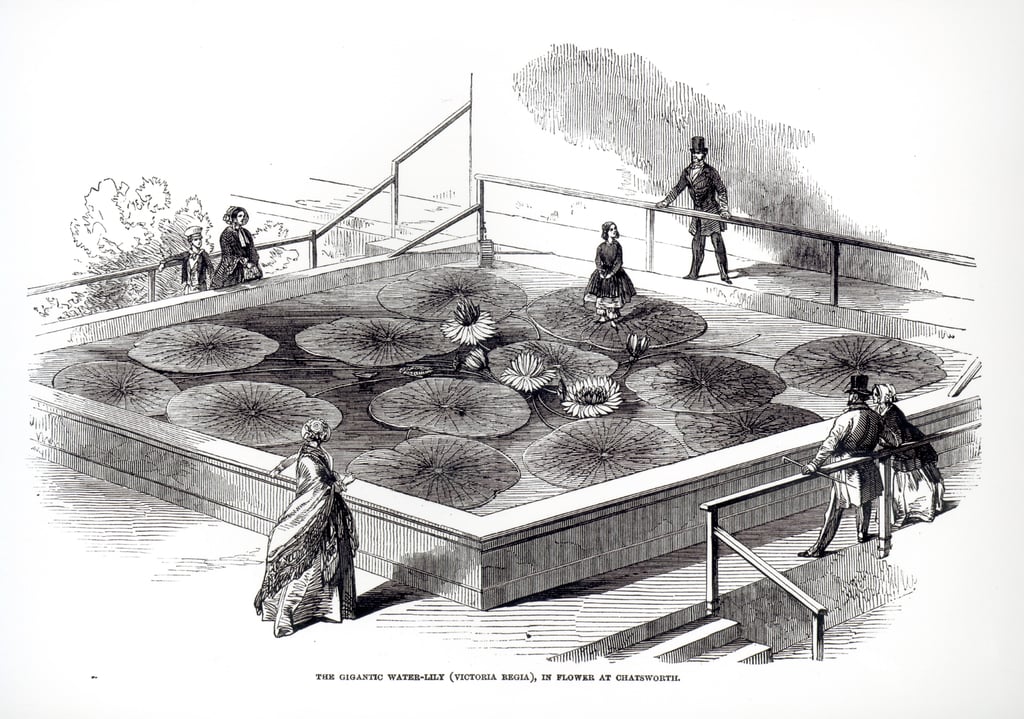
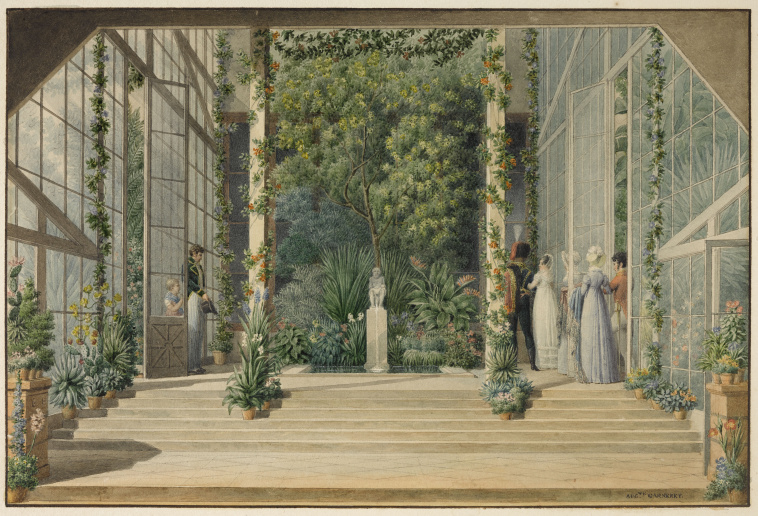

 RSS Feed
RSS Feed