Von Garten Bau di Johann Sigismund Elsholtz ovvero come coltivare un giardino nel freddo Brandeburgo13/4/2024 Il medico Johann Sigismund Elsholtz fu una delle figure più versatili della scienza tedesca del secondo Seicento; scrisse infatti di chimica (a lui si deve la creazione del termine "fosforo"), di medicina, di dietetica - di cui fu un precursore -, di botanica... e di giardinaggio. Come direttore dei giardini di corte del grande elettore di Brandeburgo, dovette affrontare la sfida del difficile clima della regione di Berlino, caratterizzato da lunghi inverni dalle temperature molto basse (senza dimenticare i suoli poco fertili e la ventosità); fece tesoro di questa esperienza per scrivere Von Garten-Bau, probabilmente il più importando libro di giardinaggio dell'epoca, insuperato fino al dizionario di Miller. Nel trattato, così come nei giardini del tempo, che possono essere esemplificati dal Lustgarten ("giardino di piacere") di Berlino, si affiancano quattro tipi di piante, secondo il duplice criterio dell'utile e del diletto: le piante officinali, coltivate nell'hortus medicus, insieme a una selezione di specie del territorio; le piante orticole, coltivate nell'hortus culinarius, ovvero nell'orto vero e proprio; gli alberi, coltivati nell'arboreto e nel pomarius, il frutteto; le piante da fiore dell'hortus floridus, coltivate in piena terra nei parterre a ramages del giardino di piacere se rustiche o in vaso e protette dai rigori invernali nell'orangerie se delicate. Tra i diversi giardini di corte diretti da Elsholtz come praefectus hortorum c'era anche il primo nucleo del futuro orto botanico di Berlino; in ricordo del suo ruolo di padre fondatore, Carl Ludwig Willdenow, che avrebbe rifondato quel giardino, gli dedicò l'interessante genere Elsholtzia. 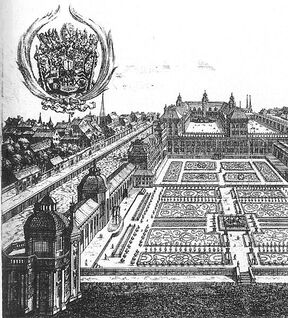 Il Lustgarten di Berlino Nel 1646, mentre volge al termine la terribile Guerra dei trent'anni, che ha devastato la Germania ma ha anche segnato l'ascesa della Prussia come potenza regionale, il Grande elettore Federico Guglielmo ordina di trasformare l'orto adiacente al Palazzo di città di Berlino (Berliner Stadtschloss) in un giardino di piacere (Lustgarten). E' in un certo senso il suo regalo di nozze alla moglie Louise Henriette di Nassau che ha sposato proprio quell'anno; figlia di Guglielmo il Taciturno, intelligente e colta, è lei, con l'aiuto dell'ingegnere militare Johann Mauritz e del giardiniere di corte Michael Hanff, a presiedere alla trasformazione, inspirandosi ai giardini della sua patria, l'Olanda. Collocato a nord del palazzo residenziale, su terrazze in lieve pendenza e fiancheggiato da un porticato monumentale, il Lustgarten comprendeva eleganti parterre con siepi a ramages e piante da fiore (hortus floridus), voliere, statue e sculture affidate a artisti di fama, un pergolato, un arboreto e un frutteto (pomarius); a nord c'era un hortus medicus dove si coltivavano piante medicinali e un hortus culinarius sive olitorius per la coltivazione degli ortaggi destinati alla tavola del principe. Vi si coltivavano anche piante esotiche, tra cui la patata, che fu coltivata qui per la prima volta in Prussia nel 1649, grazie ad alcuni tuberi importati dall'Olanda; all'epoca era considerata una curiosità ed era coltivata per la bellezza dei suoi fiori, così come i pomodori. Nel 1650 l'architetto Johann Gregor Memhardt costruì un padiglione in stile olandese, che comprendeva anche una grotta artificiale seminterrata, e disegnò un giardino d'acqua con fontane, giochi d'acqua e peschiere. Per proteggere dai rigori invernali gli agrumi, i melograni e le altre piante esotiche che, coltivate in vaso, nella bella stagione, erano esposte all'esterno, nel 1652 fu costruita una limonaia che tuttavia nel 1655 andò distrutta in un incendio causato da un difetto dell'impianto di riscaldamento. Ricostruita l'anno dopo, fu demolita nel 1658, per fare posto a un bastione difensivo e a un fossato che collegava i due bracci della Sprea, tagliando in due il giardino. Di conseguenza, il Lustgraten dovette in parte essere ridisegnato. Come si presentasse nel breve intervallo tra la sua creazione e la trasformazione successiva al 1658, lo sappiamo grazie a Hortus berolinensis, opera scritta dal medico e naturalista Johann Sigmund Elsholtz (1623-1688) tra il 1656 e il 1657. Trasferitosi a Berlino nel 1653, nel 1656 egli ottenne il libero accesso al Lustgarten per le sue ricerche scientifiche e scrisse quest'opera a mo' di ringraziamento; divisa in due parti, comprende un'accurata descrizione del giardino e un catalogo delle piante che vi erano coltivate. Forse proprio perchè resa obsoleta dalla ristrutturazione del Lustgarten, non fu mai pubblicata, ma valse a Elsholtz la nomina a medico di corte, botanico di corte e prefectus hortorum, ovvero direttore del Lustgarten e dei giardini di corte. Studioso versatile e di vasti interessi, Elsholtz ha lasciato opere significative nei campi della botanica, della chimica, della medicina e dell'igiene, di cui è consideraro un precursore. Nato a Francoforte sull'Oder, inizò gli studi presso l'università della città natale, quindi li proseguì a Wittenberg e a Königsberg. Viaggiò poi nei Paesi Bassi, in Francia e in Italia. Nel 1653 conseguì il dottorato in medicina a Padova con una tesi in cui riassunse la letteratura contemporanea sulle proporzioni del corpo umano in termini di peso, massa e dimensioni; pubblicata nel 1654 sotto il titolo Anthropometria, l'opera contiene tra l'altro la più antica illustrazione nota di un dispositivo per misurare l'altezza degli esseri umani, detto anthropometron. Subito dopo la laurea, Elsholtz ritornò in Germania e si stabilì a Berlino dove aprì uno studio medico; dopo la nomina a medico di corte e botanico regio (1657), si fece un nome tra gli scienziati tedeschi per le sue ricerche di vario argomento; nel 1674 fu ammesso alla Leopoldina, sulla cui rivista Miscellanea curiosa pubblicò una quindicina di articoli di argomento medico. In tutti i campi di cui si occupò, fu caratterizzato dalla propensione a sperimentare e a percorerre nuove strade. Come chimico, si occupò della distillazione dei coloranti e delle proprietà luminose del fosforo (del cui nome, letteralmente "portatore di luce", gli si attribisce l'invenzione). Come medico, è noto per i suoi esperimenti sulle iniezioni endovenose e sulle trasfusioni di sangue, esposti in Clysmatica nova (1667). Ma soprattutto è consideraro un precursore della dietetica e dell'igiene, grazie a Diaeteticon, pubblicata nel 1682, in cui compare per la prima volta in Germania il termine Hygiene ("igiene"). Ricca di suggerimenti pratici, comprese alcune ricette culinarie, come esplicita il sottotitolo fornisce istruzioni per mantenersi in salute attraverso una corretta alimentazione; inoltre Elsholtz vi sottolinea l'importanza di acqua e aria pulite e dell'igiene personale. Il libro incrocia anche la botanica, visto che cibi e bevante erano largamente ricavati da piante, di cui si analizzano le proprietà, facendo riferimento sia alla tradizionale teoria degli umori, sia all'analisi chimica. Va infine ricordato che, come medico dell'elettore, insieme al collega Mentzel ebbe un ruolo centrale nella stesura dell'Editto medico di Brandeburgo (1685) che poneva il settore sanitario sotto il controllo di un Collegium medicum e regolava professioni sanitarie e tariffe. 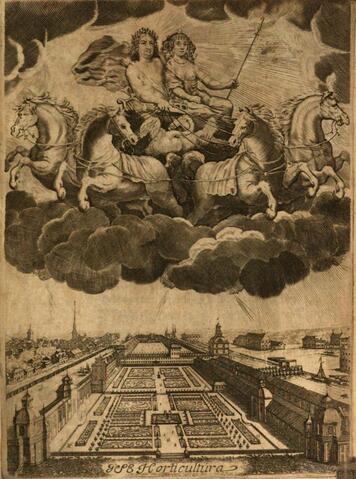 Dalla botanica al giardinaggio Nella variegata ed eclettica opera di Elsholtz, le piante e i giardini occupano uno spazio privilegiato. Per circa trent'anni (dal 1657 alla morte) come prafectus hortorum presiedette ai giardini di corte, acquisendo una notevole esperienza anche pratica. Durante la sua gestione, il Lustgarten di Berlino si arricchì di molte piante, raggiungendo le mille specie, e fu aperto alla fruizione dei berlinesi, divenendo un popolare luogo d'incontro. Era il primo giardino pubblico della città che fino ad allora, come luoghi all'aperto, aveva conosciuto solo i mercati e le piazze d'armi. Dal 1685, il giardino ebbe nuovamente una limonaia (Pomeranzen Haus); costruita dall'architetto Johann Arnold Nering, era un imponente edificio con pianta semi circolare. Probabilmente uno dei primi compiti di Elsholtz appena assunto l'incarico fu il trasferimento dell'hortus medicus e dell'hortus culinarius, che occupavano l'area smantellata per fare posto al bastione e al fossato. Nel 1679 il Grande elettore ordinò di trasferirli a Schöneberg, in un'area precedentemente nota come Hopfengarten ("giardino del luppolo") perché fino a quel momento era adibita a questa produzione; si trattava soprattuto di un vasto orto e frutteto, ma poiché ospitava anche le piante medicinali, questa data viene di solito considerata quella di nascita del primo orto botanico di Berlino. In realtà, cominciò ad essere chiamato così e ad assumere realmente questa funzione molto più tardi, nel 1718, quando Elsholtz era morto da un pezzo e anche il Lustgarten di Berlino non esisteva più, spianato e trasformato in una piazza d'armi per ordine del re sergente Federico Guglielmo I. Oltre ai due giardini berlinesi, Elsholtz curava anche i giardini della residenza di Potsdam (anch'esso era dotato di una Pomeranzen Haus, l'unica struttura ancora esistente di quel periodo, anche se il solito re sergente ordinò di trasformarla in una stalla per un reggimento di cavalleria) e il giardino di piacere di Oranienburg. La storia di quest'ultimo merita qualche riga. Nell'estate del 1650, durante una battuta di caccia l'elettrice Louisa Henriette soggiornò a Bötzow, a nord di Berlino, e si innamorò del suo paesaggio che le ricordava l'Olanda. Qualche mese dopo, il marito le fece dono dell'uffico (Amt) di Bötzow con la tenuta e i villaggi annessi; al posto del vecchio casino di caccia venne costruito un castello completamente circondato da un fossato e, accanto ad esso, un giardino di piacere, entrambi in stile prettamente olandese. Preceduto da un elegante portico e fiancheggiato su due lati da un ambulacrum, che doveva fungere anche da limonaia, il giardino vero e proprio era rettangolare e comprendeva otto parterre a ramages; al centro, su una collinetta, sorgeva una casa di delizie, detta anche grotto. Lo spazio tra il giardino e il fossato del castello era occupato da un arboreto. In onore di Louisa Henriette, appartenente al casato Nassau Orange, il castello venne battezzato Oranienberg, nome poi esteso al villaggio e all'intero Amt. Nel 1663, Elsholtz pubblicò Flora marchica che è contemporaneamente il catalogo collettivo dei giardini di corte di Berlino, Potsdam e Oranienburg e una flora della marca di Brandeburgo. Le piante sono elencate in ordine alfabetico con il nome latino per lo più tratto dal Pinax di Caspar Bauhin, seguito dal nome volgare tedesco e spesso da sinonimi di altri autori; i più frequenti sono Clusius, Dodoens e Lobel, ma i testi citati sono moltissimi, dal vecchio Dioscoride fino al recente Hortus Eystettensis, a dimostrare un'ottima conoscenza della letteratura botanica e della pubblicistica sui giardini, ampiamente analizzata nella prefazione. Salvo qualche breve notazione occasionale (ad esempio, a proposito di Alnus nigra polycarpos, "L'ho trovato la prima volta sulle rive del fiume Stepenitz presso la città di Perleberg nel distretto di Prignitz"), Elsholtz si limita a un mero elenco: fa eccezione la voce dedicata a Agave americana (chiamata Aloe aculeata e amerikanische Aloe), che occupa quasi due pagine. Elsholtz racconta di averla vista in fioritura nel 1658 in un giardino di Stoccarda, rimanendo stupefatto per l'infiorescenza alta 23 piedi con un totale di 12.000 fiori. Su questa pianta che lo aveva tanto colpito e sulla storia delle sue fioriture in Europa, Elsholtz sarebbe tornato in Von Garten Bau ("Sull'orticultura"), in cui profuse tutto ciò che aveva imparato gestendo i giardini dell'elettore. Pubblicato in prima edizione nel 1666, è un vero e proprio trattato teorico-pratico sull'arte di disegnare e gestire un giardino, che fonde una profonda conoscenza della letteratura sull'argomento con una altrettanto profonda e vasta conoscenza pratica acquisita attraverso l'esperienza diretta. Come chiarisce il sottotitolo, "Lezioni di giardinaggio adatte al clima della Marca elettorale-Brandeburgo e agli stati tedeschli limitrofi", l'intento principale di Elsholtz è fornire indicazioni per affrontare in modo vincente la sfida costituita dal difficile clima della Germania settentrionale, con i suoi lunghi inverni resi ancora più rigidi dal vento. A differenza di De hortis Germaniae di Gessner, che pure è un precedente largamente citato, il trattato è scritto in tedesco; non si rivolge infatti a botanici e dotti, ma a giardinieri e progettisti. Fanno eccezione solo gli schemi riassuntivi che percorrono qua e là il libro, rendendolo parzialmente fruibile anche al di fuori della Germania. Ad aprirlo è una duplice dedica al Grande elettore e alla sua sposa, che però non è più Louisa Henriette, morta quarantenne sfiancata da innumerevoli parti ed aborti, ma la seconda moglie Sofia Dorotea di Schleswig-Holstein; la coppia è raffigurato nel frotespizio in veste di Apollo e Diana, mentre assisi sul carro del sole sorvolano il Lustgarten. Il trattato si articola in sei libri. Il primo è a sua volta un vero e proprio trattato generale sul giardinaggio; è aperto da un'introduzione che, dopo aver definito brevemente il ruolo e i compiti del giardiniere, presenta una breve storia del giardinaggio. Il primo capitolo, sulla scelta del luogo e della forma, è articolato attorno alla duplice funzione del giardino, il diletto e l'utile; la prima è assolta dall'hortus floridus (Blumen Garten) "con la Natura educata in modo che anche d'inverno mostri i fiori più belli", la seconda dall'orto vero e proprio (Kuchen-Garten), dal frutteto e dalla vigna per l'"utilitas alimentaria" e dall'hortus medicus per l'"utilitas medicamentaria". Seguono capitoli sulle strutture, compresa la limonaia (Pomeranzen Haus), gli attrezzi, i vari tipi di coperture (dalle campane alle serrette ai lettorini), le tecniche di propagazione, i lavori e le tecniche colturali, gli accorgimenti per affrontare avversità meteoriche, parassiti e malattie. A partire dal secondo libro, Elsholtz analizza i cinque settori del giardino già individuati nell'introduzione, dedicando un singolo libro a ciascuno: l'hortus floridus (libro II); l'orto (libro III); l'arboreto e il pomario (libro IV); il vigneto (libro V); l'hortus medicus (libro VI). Ogni libro è solitamente diviso in due parti, la prima dedicata alla progettazione e alle attrezzature specifiche, la seconda a un'ampia scelta di piante consigliate, seguita talvolta da un calendario delle attività mese per mese. Ad esempio, relativamente al giardino dei fiori, vengono trattati argomenti come i pergolati, le piramidi, il disegno di aiuole, parterre, viali e sentieri, la disposizione delle piante nelle aiuole; segue poi il catalogo delle erbacee da fiore, distinte in "erbacee perenni che vanno protette d'inverno", "erbacee perenni con radici bulbose o rizomatose che sopportano l'inverno", "erbacee con radici fibrose che sopportano l'inverno", "erbacee annuali o da seme". Se in questo libro le piante sono di fatto organizzate sulla base della rusticità, le orticole, protagoniste del libro successivo, sono invece divise sulla base dell'utilità in "utili per le radici", "utili per le foglie", "utili per i frutti". Il criterio della rusticità ritorna nel libro su alberi e arbusti, divisi in "da proteggere in inverno", "che sopportano l'inverno", "spontanei". Il libro sulla vigna è forse il più dotto, con un excursus sulla sua coltivazione in Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Ungheria; ma poi nella scelta delle varietà si privilegiano quelle rustiche "nostrali" e non mancano capitoli sulla vinificazione. Il libro sull'hortus medicus, a parte una breve introduzione, è quasi integralmente costituito da un catalogo di piante non necessariamente officinali; dopo le piante medicinali dei giardini e le specie officinali spontanee, troviamo infatti un capitolo sulle piante spontanee senza proprietà medicinali e un'appendice sui cereali; questa presenza apparentemente incongrua è probabilmente spiegata dalla grande attenzione riservata alla flora locale dagli orti botanici tedeschi, che all'epoca erano ancora chiamati horti medici. Questo libro è dunque quello che assomiglia di più a Flora marchica; anche qui troviamo voci, solitamente brevissime, costituite dal nome latino, per lo più tratto dal Pinax, seguito dal nome tedesco, dai sinonimi in altri autori e, almeno per le specie officinali, da sintetiche indicazioni sugli usi, che solitamente non superano due o tre righe. Tra le poche eccezioni la voce Nicotiana major latifolia, ovvero il tabacco, che occupa circa due pagine. Come Agave americana, era ancora una novità e destava molta curiosità, senza dimenticare che all'epoca era ritenuta quasi una panacea. Il volume, di oltre 400 pagine, si conclude con un calendario riassuntivo dei lavori mese per mese e con gli indici latino e tedesco delle piante trattate. Scritto da un botanico che amava profondamente le piante e aveva una larga esperienza diretta di progettazione e gestione di giardini, Von Garten-Bau segna l'incontro tra la botanica e il giardinaggio; per la prima volta le piante da giardino sono determinate con precisione con il loro nome botanico. Anche se Elsholtz fa ampio riferimento alla letteratura specialistica contemporeanea, come il trattato di Ferrari sugli agrumi o quello di Lauremberg sulle bulbose, il suo trattato supera tutto ciò che è stato scritto in precedenza, con una profondità e una ricchezza di informazioni ineguagliata fino al The Gardeners Dictionary di Miller; Teichert lo ha definito "il miglior libro sui giardini del XVI secolo". Il libro colmava una lacuna e ottenne un notevole successo; già nel 1672 uscì una seconda edizione, sostanzialmente identica a parte l'aggiunta di alcune tabelle riassuntive in latino, seguita da una terza nel 1684. Una quarta edizione ampliata, intitolata Neu Angelegter Garten Bau, benché predisposta dall'autore, uscì postuma nel 1690. Elsholtz era infatti morto all'inizio del 1688, senza poterne curare di persona la pubblicazione.  Piante utili e dilettevoli Anche se, come abbiamo visto, il giardino di Schöneberg ospitava anche piante medicinali, all'epoca di Elsholtz non era propriamente un orto botanico. Solitamente però il botanico prussiano è considerato il fondatore dell'orto botanico di Berlino e come tale nel 1790 è stato onorato da Willdenow, che di quel giardino sarebbe stato il rifondatore, con la dedica del genere Elsholtzia (Lamiaceae). Lo stesso anno, ma in data successiva, un secondo genere Elsholtzia (Lecythidaceae) venne creato da Necker; non valido, è oggi sinonimo di Couroupita. Elsholtzia Willd. è un genere di una quarantina di specie, distribuite prevalentemente nell'Asia orientale temperata o subtropicale, con centro di diversità nello Yunnan in Cina; sono per lo più erbacee annuali o perenni, ma non mancano suffrutici. Se il dedicatario l'avesse conosciuto, certamente l'avrebbe apprezzato dal punto di vista tanto dell'utilità quanto del diletto. Come altri generi della famiglia Lamiaceae, le Elsholtziae hanno foglie aromatiche, ricche di oli essenziali e diverse specie hanno usi officinali nella medicina tradizionale, come antibatterici, antivirali, antinfiammatori. Ad esempio, E. pendulifolia in Vietnam è utilizzata per curare febbri e raffreddori; E. rugulosa in Cina ha una lunga storia come pianta mellifera e come pianta officinale da cui si ricava un reputato tè di erbe usato per curare molteplici affezioni. Ma, per usare i termini di Elsholtz, oltre all'utilitas medicamentaria, a varie specie si aggiunge l'utilitas alimentaria: molte trovano impiego in cucina come erbe aromatiche; i semi di E. fruticosa sono utilizzati per aromatizzare il cibo e se ne ricava anche un olio alimentare. E non mancano altri usi: varie specie sono impiegate in profumeria e E. splendens, per la sua alta tolleranza al rame, in Cina viene piantata come pianta pioniera per bonificare i terreni contaminati delle miniere dismesse. Venendo poi al diletto, alcune specie sono coltivate per la bellezza della loro fioritura. La più notevole è indubbiamente E. stauntonii, un'alta erbacea perenne o un piccolo arbusto con belle foglie dentate e infiorescenze a spiga da rosa a viola pallido che si aprono dalla tarda estate all'autunno; come le sue consorelle, ha foglie aromatiche che ricordano la menta, ma con sentori agrumati e di cannella che possono essere usate per preparare una piacevole tisana o per aromatizzare piatti della cucina asiatica. Dopo tante lodi, una nota dolente. E. ciliata, un'erbacea annuale originaria della Cina e del Sud est asiatico (le sue foglie profumate di limone sono un ingrediente della cucina vietnamita), è stata introdotta come officinale e pianta da giardino in vari paesi europei e negli Stati Uniti; poiché produce molti semi e ha un alto tasso di germinazione, può formare rapidamente estese popolazioni a danno delle specie autoctone, soprattutto in aree disturbate. Per questo è stata inclusa in liste di piante potenzialmente invasive e il Connecticut ne ha proibito la coltivazione, la vendita e la diffusione. In Italia, dove potrebbe essere stata introdotta come specie officinale usata in erboristera, è stata segnalata la prima volta in Friuli Venezia Giulia nel 1991; in Lombardia è stata osservata a partire dal 2002 ed è considerata naturalizzata in incolti ruderali; non è inclusa in nessuna lista e il suo impatto sulla flora autoctona è considerato irrilevante.
0 Comments
Joséphine de Beauharnais, ovvero l'imperatrice Giuseppina, la prima moglie di Napoleone, è nota per la passione per la botanica, che profuse nella creazione dello splendido parco del castello di Malmaison, successivamente residenza dei Bonaparte negli anni del consolato, poi casa di campagna e rifugio in quelli dell'impero, infine, dopo il divorzio, la sua casa, la sua consolazione, il luogo dove morì. Dotato di una serra calda all'avanguardia, fu funzionale all'introduzione in Francia di quasi duecento specie esotiche, soprattutto australiane. Per tutti, Joséphine è anche l'imperatrice delle rose, che certamente amava, ma probabilmente non di quell'amore esclusivo che le attribuisce il mito. A ricordarla contribuisce anche la splendida e capricciosa Lapageria (dal suo nome da ragazza, Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie). Un parco all'inglese Il noto motto latino nomen omen, "nel nome c'è il destino", almeno a Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (1763-1814) parrebbe calzare. Fino a quando Napoleone Bonaparte la ribattezzò con il nome con cui è passata alla storia, per tutti fu Rose, un nome che preannunciava l'importanza che nella sua vita ebbero le piante, comprese le rose. Quando si incontarono per la prima volta in un salotto parigino, lei era Mme Rose de Beauharnais. Lui aveva 26 anni, lei 32, e aveva già alle spalle una vita tumultuosa e molto chiacchierata. Era nata in Martinica nella piantagione di una famiglia nobile ma impoverita; poi, ad appena 16 anni, erano arrivati il matrimonio con un nobile dissipatore e femminiere, prima dei vent'anni un figlio e una figlia, quindi la separazione, il carcere durante il terrore, la vedovanza in seguito all'esecuzione del marito Alexandre de Beauharnais. E debiti, tanti debiti, e amanti veri o presunti. L'ultimo, quello in carica al momento, si diceva fosse Paul Barras, uno dei cinque direttori. Che, secondo una delle varie versioni, sarebbe anche colui che presentò ufficialmente la bella vedova a Napoleone, che aveva appena nominato generale per essersi distinto nella repressione di un'insurrezione monarchica. Fu l'inizio di un amore appassionato da parte di lui - un po' meno da parte di lei - che sfociò nel matrimonio il 9 marzo 1796, due giorni prima che Bonaparte partisse per la Campagna d'Italia. Rose non era più Rose, ma Joséphine, come Napoleone l'aveva ribattezzata a partire dal suo secondo nome, forse per rifarla propria e cancellare quel passato tanto chiacchierato. E mentre Napoleone diventava Napoleone, Joséphine aveva finalmente un giardino. Nell'aprile 1799, mentre il marito era impegnato nella Campagna d'Egitto, ricorrendo a un prestito - era abituata a fare debiti - acquistò per 325.00 franchi il castello e la tenuta di Malmaison, a una dozzina di km da Parigi. Al suo ritorno Bonaparte andò su tutte le furie per quella spesa folle, ma, dopo il colpo di stato del 18 brumaio che lo rese padrone della Francia, si addossò il debito, forse attingendo al denaro predato in Italia ed estese addirittura il parco dagli iniziali 60 a 260 ettari. Anche per lui, Malmaison divenne la casa del cuore e per tutto il consolato ne fece la propria residenza; tra il 1800 e il 1802, insieme alle Tuilerie, fu addirittura la sede del governo. Joséphine era decisa a trasformare la tenuta "nel giardino più bello e curioso d'Europa, un modello di buona coltivazione". Inizialmente i lavori vennero affidati agli architetti Percier e Fontaine, che, oltre a restaurare il castello (loro avrebbero voluto abbatterlo e ricostruirlo, ma Napoleone optò per una più economica ristrutturazione), nel 1801 incominciano a recintare il parco, costruirono strutture di servizio come stalle per i cavalli e padiglioni di guardia, eressero il cancello principale e, per le piante di Joséphine, una orangerie riscaldata in grado di produrre 300 piante di ananas. Tuttavia presto emersero contrasti con Mme Bonaparte, che considerava il loro gusto in fatto di giardini troppo classico; desiderava un giardino all'inglese di gusto romantico e paesaggistico. Si rivolse così ai due guru del giardino all'inglese in Francia, lo scozzese Thomas Blaikie, che aveva disegnato il giardino di Bagatelle per il conte d'Artois, e Jean-Marie Morel, autore dell'influente Théorie des Jardin (1777). Morel costruì uno chalet svizzero, una stalla per le mucche, una latteria e una casa per i vaccari fatti venire dalla Svizzera e iniziò la costruzione della serra riscaldata (Grande serre chaude), completata nel 1805 da Thibault e Vignon. Costruita secondo i criteri più avanzati dell'epoca, era la prima in Francia a prevedere una così ampia superficie in vetro; lunga circa 50 metri e larga 19, era riscaldata da 12 stufe e poteva ospitare piante alte fino a 5 metri. La serra era addossata a un elegantissimo padiglione con una serie di salotti e una rotonda centrale raffinatamente arredati in cui era possibile riposarsi, intrattenersi ed ammirare piante rare e una collezione di vasi greci. Neppure Morel soddisfaceva del tutto il gusto romantico della ormai imperatrice (fu incoronata dallo stesso marito e congiuntamente a lui il 2 dicembre 1804); alla fine del 1805 gli subentrò Louis-Martin Berthault, in cui Joséphine trovò quasi un'anima gemella che l'avrebbe servita fino alla morte. Egli costruì una nuova galleria per ospitare le collezioni d'arte e a partire dal 1807 ridisegnò completamente il parco, creando un parco chiuso di 70 ettari perfettamente integrato nel paesaggio, con gli alberi disposti in modo da permettere allo sguardo di spaziare su monumenti già esistenti come l'acquedotto di Marly o il castello di Saint Germain. Berthault disegnò sentieri serpeggianti, fece scavare un corso d'acqua sinuoso che si allargava a formare un laghetto e disseminò il parco di edifici di gusto romantico: il Tempio dell'amore, il tumulo funerario della Malinconia, una grotta con rocce fatte venire da Fontainbleau. Tutte cose che facevano impazzire l'imperatrice, ma non l'imperatore, che le definiva sprezzantemente niaiseries "stupidaggini", e volle per sè un angolo di gusto più classico. Per ospitare gli animali giunti dall'Australia - li ritroveremo tra poco - c'erano una voliera e uno zoo; alla fattoria si aggiuns un allevamento modello di pecore merino. 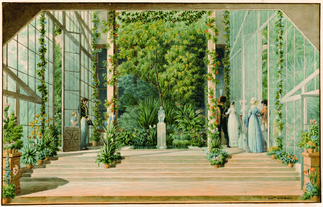 Le piante e gli uomini di Malmaison Fin dall'acquisto di Malmaison, Joshéphine era intenzionata a popolarne il parco e le serre con una collezione unica di piante esotiche. In primo luogo, forse già dalla primavera del 1800, si rivolse a André Thouin, il capo giardiniere del Jardins des Plantes che, oltre ad essere il massimo esperto di acclimatazione di esotiche in terra di Francia, negli anni aveva costruito un'immensa rete di corrispondenti che includeva botanici, giardinieri, vivaisti e collezionisti sia nel paese sia all'estero. In una lettera dell'agosto 1800, firmata Lapagerie Bonaparte, la futura imperatrice lo ringrazia per l'invio di frutti di fico-banana (Ficus pleurocarpa) che "mi hanno ricordato il paese natale e mi hanno dimostrato che siete capace di trionfare di ogni clima e di portare ogni cosa a perfezione". Scrisse anche alla madre, che continuava a vivere in Martinica; in una lettera del 1802 leggiamo: "Mandatemi tutti i semi d'America e tutti i frutti: batate, babane, aranci, manghi, infine tutto ciò che potrete". Thouin la mise in contatto con Jacques Martin Cels (1740-1806), un collezionista che, rovinato dalla rivoluzione, aveva trasformato la sua passione in professione, aprendo a Montrouge, nella periferia sud di Parigi, un vivaio in cui coltivava soprattutto piante americane introdotte da André Michaux. Il suo lavoro fu continuato dal figlio François (1771-1832) che allargò il vivaio e si specializzò nella coltivazione di esotiche ornamentali; nel suo catalogo del 1817 troviamo, accanto alle americane, anche molte sudafricane, dalie, e una notevole collezione di rose, circa 200 varietà, principalmente Gallica. Sicuramente il vivaio Cels fu uno dei principali fornitori di Malmaison, anche per le rose (ma su questo tornerò più avanti), insieme a quello di un altro contatto di Thouin, Louis Claude Noisette (1772-1849). Figlio di un giardiniere del conte di Provenza, intorno al 1798 aveva aperto un vivaio dove coltivava soprattutto piante americane, ottenute attraverso uno dei suoi fratelli, Philippe Stanislas, che viveva a Charleston. Uno dei suoi invii è Old Blush Noisette, la prima delle rose Noisette; ma giunse in Francia nel 1814, troppo tardi per essere coltivata a Malmaison. Joséphine ottenne molte piante dal Jardin des Plantes, e molto lo acquistò dai vivai, spendendo somme folli; è del marzo 1804 una consegna di 2014 tra erbacee, alberi e arbusti. Seppe inoltre approfittare del potere del marito; piante le giunsero dai botanici che accompagnarono Napoleone in Egitto e durante le campagne napoleoniche; in Italia come a Vienna, piante furono requisite dai giardini degli sconfitti per essere inviate a Malmaison. L'imperatore sollecitava diplomatici, ufficiali di marina e funzionari ad approfittare di ogni occasione per soddisfare la passione botanica della moglie e Joséphine stessa faceva pressione su ministri, dignitari, agenti francesi all'estero. Ad arricchirne il parco e le serre di piante in precedenza mai viste in Europa fu però soprattutto la sventurata spedizione Baudin, sponsorizzata da Napoleone primo console, ed in particolare il ricco carico del Géographe, che raggiunse Lorient nel marzo 1804. Napoleone aveva ordinato che il giardino di Malmaison avesse la precedenza sul Jardin des Plantes e quando Thouin ispezionò il carico, scoprì di essere già stato preceduto da Mirbel, il sovrintendente di Malmaison; così, delle 230 piante sopravvissute al tumultuoso viaggio, le 98 più sane presero direttamente la strada delle serre di Joséphine. Insieme a loro viaggiavano anche canguri, emù e una coppia di cigni neri, che divennero quasi un simbolo del giardino dell'imperatrice. Da quel momento, d'un colpo le serre di Malmaison ospitarono la più importante collezione europea di piante australiane, più ricca di quella degli stessi Kew Gardens. Per altro, le piante inglesi o importate dai britannici non mancavano. Come ho già raccontato parlando del vivaio Lee & Kennedy, a partire dal 1803 The Vineyard divenne il maggiore fornitore dei giardini dell'imperatrice; grazie alla compiacenza di Banks, con il quale Joséphine era in contatto attraverso il botanico Etienne Ventenat, ottenne anche alcune piante di Kew e soprattutto un passaporto che permise a Kennedy di continuare a fare la spola tra Francia e Inghilterra con i suoi carichi di piante nonostante lo stato di guerra e il blocco continentale. Con Kennedy, Joséphine creò addirittura un consorzio per inviare in Sudafrica il cacciatore di piante James Niven. Joséphine seppe anche circondarsi di personale molto qualificato. Nel 1801 ingaggiò un giardiniere scozzese, Alexander Howatson; in tempo di guerra, avere un dipendente britannico spiaceva assai a Napoleone, che nel 1805 approfittò del conto troppo salato di un trasporto di piante per licenziarlo. Egli fu così sostituito da Felix Delahaye, che era stato il giadiniere della spedizione Entrecasteaux, durante la quale aveva fatto estese raccolte; aveva poi lavorato per un certo periodo nel giardino di Pamplemousses a Mauritius e dopo il ritorno in Francia aveva restaurato i giardini del Trainon e il vecchio giardino di Maria Antonietta a Versailles. Era dunque un esperto di coltivazione di esotiche e, soprattutto, era forse l'unico giardiniere europeo ad avere visto le piante australiane in natura e molte le aveva raccolte lui stesso. Abbiamo già incontrato di passaggio due dei botanici che lavorarono per Joséphine a Malmaison, Mirbel e Ventenat. Charles-François Brisseau de Mirbel (1776-1854) ad appena vent'anni era diventato assistente naturalista al Muséum ed era un promettente scienziato, destinato a diventare il padre fondatore della citologia; nel 1803 Mme Bonaparte lo assunse come sovrintendente di Malmaison, dove poté continuare i suoi studi sui tessuti vegetali, l'evoluzione degli organi delle piante e le epatiche del genere Marchantia. Nel 1806 però egli lasciò Malmaison per entrare al servizio del re d'Olanda Luigi Bonaparte, che oltre ad essere fratello di Napoleone, era anche genero di Joséphine in quanto marito di sua figlia Hortense Beauharnais. A sostituirlo fu Etienne Pierre Ventenat (1757-1808). Fratello di Louis Ventenat, cappellano e naturalista morto durante la spedizione Entrecasteaux, era entrato nell'orbita dell'imperatrice grazie a Cels. Allievo e collaboratore di L'Héritier de Brutelle, in gioventù si era segnalato per la traduzione in francese di Genera plantarum di Antoine Laurent de Jussieu, poi, come il suo maestro, aveva focalizzato la sua attenzione sulla pubblicazione di piante nuove per la scienza. Nel 1799 pubblicò Descriptions des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. Cels, illustrato da 100 tavole in gran parte dovute ai fratelli Pierre-Joseph e Henri-Joseph Redouté. La raffinatezza di quest'opera attirò l'attenzione di Joséphine che volle qualcosa di simile per far conoscere al mondo le proprie collezioni di cui era estremamente fiera. Commissionò così a Ventenat i testi e Pierre-Joseph le illustrazioni del magnifico Jardin de Malmaison; in due tomi, usciti in 20 fascicoli tra l'aprile 1803 e il novembre 1805, comprendo 120 calcografie a colori incise da Allain a partire da acquarelli di Redouté e la descrizione di 161 specie, molte delle quali nuove per la scienza, scritta da Ventenat. Come ho anticipato, nel 1806 Ventenat fu nominato intendente e prese così sul serio l'incarico da morire, esausto di fatica, appena due anni dopo. A succedergli fu Aimé Bonpland, che era stato compagno di Humboldt nel suo viaggio sudamericano. Egli curò tra l'altro i testi di Descriptions des Plantes Rares Cultivées à la Malmaison (1812-1817), anch'esso illustrato da Redouté. Anche questo grande artista, soprannominato il "Raffaello dei fiori", può essere annoverato tra gli uomini di Joséphine. Oltre alle due opere già citate, i fiori di Malmaison ispirarono il suo capolavoro, Les Liliacées; pubblicato in 8 volumi di grande formato, usciti tra il 1802 e il 1816, comprende 486 incisioni a colori di altrettante specie di bulbose e monocotiledoni (non solo Liliaceae in senso stretto). Joséphine riuscì a convincere il ministro dell'interno Chaptal ad acquistarne 80 copie che furono distribuite tra dignitari e biblioteche in tutto il paese e all'estero. L'altro libro più noto di Redouté, Les Roses (1817-1824) fu creato dopo la morte dell'Imperatrice e ritrae rose coltivate in vari giardini francesi, non solo a Malmaison. Furono invece commissionate da Joséphine intorno al 1812 al pittore Auguste Garneray le 12 vedute del parco e della serra, oggi un documento inestimabile per ricostruirne l'aspetto. Essi infatti non sopravvissero a lungo alla loro creatrice, Nel 1809, essendo chiaro che, per la sua età, Joséphine non gli avrebbe mai dato un erede, Napoleone si decise a chiedere l'annullamento del matrimonio, sancito nel gennaio 1810. Fu però generoso con la ex moglie, con cui mantenne rapporti cordiali: essa conservò il titolo di imperatrice, cui si aggiunse quello di duchessa di Navarre (dal castello in Normandia che le donò dopo il divorzio, un po' per compensarla, un po' per tenerla lontana da Parigi mentre si celebrava il suo matrimonio con Maria Luigia d'Asbrugo), ottenne la piena proprietà di Malmaison e una pensione di 5 milioni di franchi. Mentre si completavano i lavori di adattamento per ospitare la sua piccola corte di quasi 200 persone, Joséphine visse a Navarre, poi tornò a Malmaison, che continuò ad accrescere ed abbellire fino alla morte. Il 29 maggio 1814 vi morì di polmonite. Si dice l'avesse contratta passeggiando nel parco con lo zar Alessandro, che avrebbe implorato di permetterle di unirsi al marito nell'esilio all'Elba. Quando Napoleone seppe della sua morte, si chiuse per due giorni nella sua camera; dopo la disfatta di Waterloo, prima di consegnarsi agli inglesi, risiedette a Malmaison che, però, senza la sua Joséphine, non era più la stessa. Poi iniziò la decadenza. L'imperatrice aveva lasciato debiti imponenti, riscaldare la serra era troppo costoso e le piante esotiche, abbandonate a se stesse, morirono; la casa e il giardino furono saccheggiati e vandalizzati; la proprietà fu parcellizzata e messa in vendita. Dopo diverse vicissitudini, nel 1903 il castello e il parco, ridotto a 6 ettari, passarono allo stato e divennero un museo. 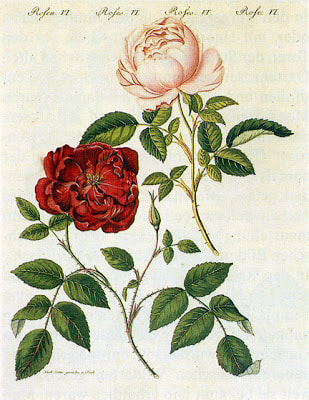 E finalmente... le rose Il parco di Malmaison non era un orto botanico, con le piante disposte in modo sistematico, ma un giardino di piacere. Era anche un giardino sperimentale dove vennero acclimatate piante che poi avrebbero profondamentro modificato i giardini e il paesaggio francese. Secondo L'impératrice Joséphine et les sciences naturelles (catalogo della mostra tenutasi a Malmaison nel 1997), le piante che vi furono coltivate per la prima volta in Francia tra il 1804 e il 1814 ammontano a 184. La corrispondenza tra l'intendente Mirbel e il prefetto delle Alpi Marittime Marc Joseph Dubouchage attesta l'invio in Costa azzurra di numerose piante soprattutto australiane acclimatate a Malmaison; tra di esse, Casuarina equisetifolia, Phormium tenax, varie specie dei generi Eucalyptus, Melaleuca, Metrosideros, Leptospermum, cui forse va aggiunta Acacia dealbata, la mimosa oggi onnipresente, che fiorì per la prima volta a Malmaison nel 1811. A fare da tramite all'introduzione di queste e altre specie esotiche nella Francia meridionale, il cui clima mite era considerato il più propizio all'acclimatazione di piante tropicali e subtropicali, fu il giardino di acclimatazione creato nel settembre 1801 nel recinto della Scuola centrale del dipartimento delle Alpi marittime a Nizza. E poi, naturalmente, c'è il capitolo rose. Ne ho già parlato in questo post, e qui mi limito a riassumere le informazioni principali. Secondo la vulgata erano le piante preferite di Joséphine che ne avrebbe fatte coltivare ben 250 varietà; molti si spingono anche a dire che, insoddisfatta delle rose europee non rifiorenti, avrebbe incoraggiato l'introduzione di rose cinesi e le ibridazioni che avrebbero portato alla nascita delle rose moderne. Altri parlano di migliaia di rose (peccato che nessuno delle persone che visitò quel giardino poco dopo la morte della imperatrice ne faccia parola e proprio le rose manchino le vedute di Garneray). In realtà, Joséphine era interessata in generale alle piante, specialmente esotiche, e non aveva una speciale predilezione per le rose; certamente a Malmaison non mancavano, ma non è neppure certo che ci fosse un roseto; molte delle piante più preziose erano infatti coltivate in vaso, ed esposte all'esterno al momento della fioritura. Purtroppo, mentre i cataloghi di Ventenat e Bompland documentano bene le esotiche coltivate nella serra e in giardino, non possediamo niente di simile per le rose. Come ho anticipato, Les roses di Redouté, che molti considerano un catalogo delle rose di Malmaison, fu scritto solo dopo la morte dell'imperatrice e ritrae le rose coltivate in vari giardini e vivai francesi che Redouté e Thory, l'autore dei testi, visitarono e citarono scrupolosamente; i giardini dp Malmaison sono ricordati solo per due rose, R. berberifolia e R. gallica. Questo equivoco è probabilmente all'origine della leggenda del roseto di Malmaison, nonchè dei vari pretesi elenchi delle rose che vi erano coltivate. Rimandando al post già citato per le specie sicuramente identificate, molte delle quali importate dall'Inghilterra attraverso Kennedy e altri vivai, vorrei qui aggiungere solo qualche informazione sui fornitori parigini. Presumibilmente il principale era André Dupont, che non fu mai un giardiniere di Malmaison come spesso si legge, anzi neppure un vivaista, ma un collezionista privato; prima della rivoluzione era il custode (e non il giardinere) del palazzo di Lussemburgo. Secondo il suo biografo V. Darkenne, incominciò a interessarsi di rose intorno al 1785, quando affittò un piccolo terreno dai monaci cerctosini nel pressi del Lussemburgo. Durante il Terrore fu imprigionato due volte e per quattro volte, per salvarla, dovette spostare la sua collezione di rose. Nel 1796, la sistemò nell'amgolo orientale del giardino del Lussemburgo, con le rose classificate per specie; nel 1801, la sua collezione (la chimava "éecole de roses"), di specie tanto native quanto esotiche, era la più completa d'Europa. Secondo la testimonianza di Antoine Laurent de Jussieu, Joséphine si rivolse a Dupont per chiedergli di rifornire di rose Malmaison ed egli accettò, come attestano le fatture (che purtroppo non indicano di quali vareità si trattasse). Darkenne stima che nel 1806 gliene abbia fornite da 200 a 500, presumibilmente più di un esemplare per varietà, visto che nel catalogo delle rose coltivate da Dupont nel 1813 (pubblicato da Thory nel 1819, Catalogo inedito Rosarum quas Andreas Du Pont in horto suo studiose colebat anno 1813) ne sono elencate 218. La collezione di Dupont comprendeva numerose rose botaniche europee, un'ampia selezione di alba, centifolia, damascena e soprattutto gallica (una sessatina, pochissime esotiche e qualche cinese, l'unica delle quali identificabile con certezza è la rosa di Macartney (R. bracteata, introdotta in Europa intorno al 1795). Dupont è considerato un pioniere dell'ibridazione artificiale delle rose e a volte gli viene attribuita la creazione di un numero impressionante di ibridi. In realtà nel catalogo compaiono solo 19 ibridi di gallica, non necessariamente tutti creati da lui. Come collezionista, riceveva rose da tutta Europa; come abbiamo visto in questo post, fu lui a introdurre la rosa Portland dall'Inghilterra; potremmo aggiungere 'Belle Sultane', che invece importò dall'Olanda. Gli ibridi di Gallica erano all'epoca le rose più alla moda ed è probabile che ce ne fossero parecchi tra quelle fornite all'imperatrice; lo stesso varrà anche per un altro probabile fornitore, Cels; il catalogo pubblicato da Cels figlio nel 1817 (Catalogue des arbres, arbustes, et autre plantes de serre chaude, d'orangerie et de pleine terre) offre circa 170 varietà di rose; una buona percentuale sono ibridi recenti dai nomi evocativi ('Belle sans flatterie', 'Panachée admirable'. 'Roi des pourpres') di cui si è per lo più persa ogni traccia. Ovviamente non ne conosciamo il pedigree; è invece giunta fino a noi R. celsiana (nel catalogo figura come grande Cels), un vigoroso ibrido di damascena. Abbiamo già visto che a Malmaison non potevano esserci rose Noisette, essendo la prima giunta in Francia dopo la morte dell'imperatrice. E lo stesso vale per le rose Boursault. Jean-François Boursault detto Malherbe era un ex attore che con la rivoluzione si era dato alla politica e agli affari, accumulando una grande ricchezza che investì tra l'altro in uno splendido giardino con tanto di serre calde. Forse potrebbe aver ceduto a Joséphine una talea della cinese Rosa multiflora carnea, che fu il primo a introdurre in Francia nel 1808, ma non Rosa banksiae 'Alba plena', giuntagli nel 1817, nè il primo ibrido Boursault, ottenuto nel 1818 incrociando R. pendulina non con una cinese, come si è creduto a lungo, ma con la nordamericana R. blanda. Quali e quante fossero le rose coltivate a Malmaison, in assenza di documenti, non lo sapremo mai. Ma anche se il roseto di Joséphine fosse un mito, da più di un secolo è diventato realtà. Nel 1911, dopo che quanto rimaneva del parco era stato donato allo stato, il compito di ri-crearlo venne affidato a Jules Graveraux, il creatore della Roseraie de L'Haÿ; egli, consultando i cataloghi dell'epoca, individuò 197 specie e cultivar disponibili ai tempi dell'imperatrice e ne fece dono al giardino; il suo elenco comprendeva 107 galliche, 27 centifolia, 3 muscose, 9 damascene, 22 bengalesi (ovvero cultivar di R. chinensis), 4 spinosissime, 8 alba, 3 lutee, 1 moscata e le specie alpina, arvensis, banksiae, carolina, cinnamomaea, clinophylla, glauca, laevigata, rugosa, sempervirens e setigera. Certamente è un falso storico, ma almeno su un punto anche oggi siamo d'accordo: Gravereux correttamente privilegiò le galliche, che erano ancora le rose più coltivate, come risulta anche dai cataloghi di Dupont e Cels. In occasione del bicentenario della scomparsa dell'imperatrice, il roseto è stato restaurato e ospita oggi 750 rose del Primo e del Secondo Impero.  Una bella capricciosa A Joséphine de Beauharnais, creatrice di un magnifico giardino, patrona delle arti e della scienza, ma soprattutto moglie di un uomo che per un quindicennio fu il più potente d'Europa, non mancarono gli omaggi botanici, di sapore innegabilmente cortigiano. Nel 1802, quando Mme Bonaparte era ancora la "consulesse", Ruiz e Pavon dedicarono congiuntamente a marito e moglie, rispettivamente, Bonapartea e Lapageria; mentre la dedica a Napoleone (ne parlo qui) è un capolavoro di adulazione, quella a Joséphine è relativamente sobria: "all'eccellente Joséphine de La Pagerie, degnissima sposa di Napoleone Bonaparte, egregia fautrice della botanica e delle scienze naturali". Ventenat volle anche lui omaggiare con la dedica di un genere colei che in definitiva era la sua datrice di lavoro; per farlo scelse una delle quattro piante australiane nate dai semi portati in patria dalla prima nave della spedizione Baudin a rientrare, il Naturaliste, che precedette il Géographe di circa un anno. Era una pianta modestissima, per nulla imperiale, ma aveva il fascino della primizia, e. dato che Joséphine era appena stata incoronata imperatrice, la battezzò Josephinia imperatricis. Certo era sinceramente legato a colei che lo chiamava il "suo botanico" e lo aveva scelto come intendente del suo amato giardino, ma la sua dedica è decisamente meno moderata rispetto a quella dei due spagnoli: "L'onore di dedicare un genere all'illustre Imperatrice di Francesi dovrebbe essere ambito dall'autore del Jardin de la Malmaison. Possa questo debole omaggio ricordare al posteri la protezione illuminata che essa accorda alla scienza e lo splendore con cui la abbellisce". Il genere Josephinia fu ridotto a sinonimo di Sesamum, e il suo nome attuale della piante è Sesamum imperatricis che, più che i fasti imperiali, evoca la cucina. Sopravvive invece il genere creato da Ruiz e Pavon, che per bellezza e fascino esotico calza perfettamente alla dedicataria. Lapageria (famiglia Philesiaceae) è un genere monospecifico endemico del Cile, di cui l'unico rappresentante, L. rosea, è il fiore nazionale. Originaria delle foreste sclerofile e caducifolie dell'area centrale e centro-meridionale, dalla regione di Valparaiso a quello di Los Lagos, questa splendida pianta è un rampicante sempreverde con fusti contorti e sottili, foglie semplici, lanceolate, coriacee, lucide e grandi fiori solitari penduli a campana formati da sei tepali cerosi. Il colore delle corolle (tra selvatiche e coltivate, se ne conoscono 25 varietà) varia dal bianco purissimo fino al rosso passando da varie sfumature di rosa. I fiori sono impollinati da insetti, altri animali, ma soprattutto colibrì, e sono seguiti da bacche allungate eduli. La coltivazione è considerata piuttosto difficile. Da noi viene solitamente coltivata in vaso; necessita di ombra luminosa, ottima areazione (ma senza correnti d'aria) e un ambiente umido. Non sopporta né il freddo né il caldo eccessivo. Ama essere frequentemente nebulizzata e, poiché non tollera il calcare, va annaffiata con acqua demineralizzata. Insomma, coltivarla è una vera sfida, ma se trova le condizioni giuste può arrivare a 4-5 metri d'altezza e regalare sontuose fioriture. Creato nel 1902, il Big Basin Redwoods State Park è il più antico della California. La sua nascita si deve alla battaglia di un gruppo di cittadini, con il sostegno dell'università di Stanford e del capo del suo dipartimento di botanica, William Russell Dudley, che ebbe un ruolo importante nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sorte di una delle meraviglie della natura, la sequoia della California (Sequoia sempervirens), che in meno di un secolo era stata portata alla soglia dell'estinzione dagli abbattimenti indiscriminati. Dudley era uno specialista di conifere e un appassionato raccoglitore; gli si deve la fondazione dell'erbario Dudley. A ricordarlo, il genere Dudleya, endemico dell'Oregon, della California e della Baja California. 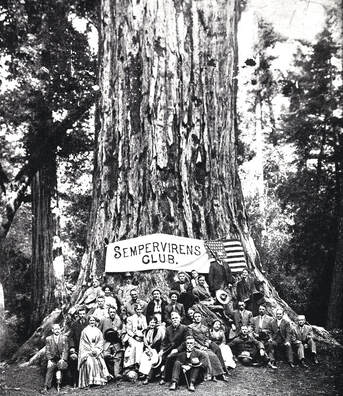 Salvare le sequoie Nell'ottobre 1899, un incendio scoppiò nei boschi delle Montagne di Santa Cruz presso Felton in California. Presto raggiunse le case di Wrights Station e l'azienda vinicola Mare Vista Winery; per scongiurare lo scoppio di un serbatoio di gas, il proprietario non esitò ad ordinare ai suoi dipendenti di estinguere le fiamme con 4000 galloni di vino rosé. Il fatto era abbastanza curioso da attirare l'attenzione della rivista inglese The Wide World Magazine che commissionò un articolo a C.F. Holder, presidente dell'accademia delle scienze della California, il quale chiese al noto fotografo e pittore californiano Andrew P. Hill di illustrarlo con le sue fotografie. Hill, oltre all'area devastata, per mostrare il contrasto, pensò di scattare qualche fotografia alle maestose sequoie (Sequoia sempervirens) secolari di un parco privato, il Welch’s Big Trees Grove (oggi parte dell'Henry Cowell State Park); aveva appena sistemato il suo cavalletto e scattato tre foto, quando arrivò l'infuriato proprietario che pretese i negativi, sostenendo che quelle foto avrebbero danneggiato la sua vendita di cartoline ai turisti. Hill ribatté che le fotografie erano per una rivista straniera e, anzi, sarebbero state un'ottima pubblicità. L'altro gli ripose piccato che la pubblicità non gli interessava, perché presto quegli alberi sarebbero diventati traversine ferroviarie e legna da ardere. La risposta sconvolse e indignò Hill: come, quella meraviglia della natura era destinata a perire? Da quel momento, salvare le sequoie della California divenne lo scopo della sua vita. Convinse due amici, l'avvocato e poeta di San Jose John E. Richard e la scrittrice Josephine Clifford McCrackin, che aveva perso la casa nell'incendio di Wrights Station, a denunciare la situazione sui giornali locali. Nel marzo 1900 McCrackin scrisse una lettera aperta al Sentinel di Santa Cruz intitolata "Salviamo gli alberi" che fu il primo atto pubblico della campagna. Il secondo fu una riunione convocata il 1 maggio 1900 da Hill e dal presidente dell'ateneo di Stanford David Starr Jordan nella biblioteca dell'Università, per discutere azioni concrete per salvare le sequoie. Durante la riunione emerse che i naturalisti dell'università avevano già individuato come area più adatta alla nascita di un parco naturale il Big Basin (molto più vasto e con alberi più grandi e antichi rispetto al bosco di Felton) e fu deciso di inviarvi in esplorazione un comitato, che includeva giornalisti, uomini d'affari e politici, presieduto da Hill e da Carrie Stevens Walter del San Jose Woman's Club. Due settimane dopo il gruppo visitò l'area e decise di costituirsi in associazione, denominata Sempervirens club dall'eponimo di Sequoia sempervirens, con un capitale iniziale di 32 dollari, raccolti facendo passare un cappello tra i presenti. Come presidente fu scelto l'avvocato di San Francisco Charles Wesley Reed, che contava diversi appoggi politici, affiancato da varie personalità più o meno eminenti come vicepresidenti onorari. A rappresentare la scienza, William Russell Dudley (1849-1911), capo del dipartimento di botanica sistematica di Stanford, che aveva partecipato al meeting del 1 maggio e da tempo denunciava i rischi di estinzione della sequoia della California. Dudley era cresciuto in una fattoria del Connecticut e fin da bambino si era innamorato della natura; ventunenne si iscrisse alla Cornell University, dove per qualche tempo si pagò gli studi mungendo le mucche della fattoria universitaria. Caso volle che suo compagno di stanza fosse David Starr Jordan che abbiamo già incontrato nelle vesti di presidente dell'università di Stanford; David divenne ittiologo, mentre Willie (come lo chiamavano in famiglia) scelse la botanica. Già prima di laurearsi fu lettore di botanica alla Cornell, che lo utilizzò anche come raccoglitore. Dopo essersi laureato nel 1876, si perfezionò per qualche tempo a Strasburgo e Berlino, dopo di che insegnò botanica alla Cornell fino al 1892, quando venne nominato a Stanford, dove prese servizio nell'autunno 1893, reclutato dall'amico Jordan che era appena stato scelto come presidente del neonato ateneo. Il dipartimento di botanica era tutto da inventare, non c'erano né strutture né laboratori, ma per Dudley, che fino ad allora si era occupato della flora degli Stati uniti orientali (i suoi principali lavori riguardavano le flore della contea di Cayuga, della contea di Lackawanna e del Wyoming) ogni fatica era ricompensata dalla ricchissima flora californiana. Il suo più grande amore divennero gli alberi, in particolare le conifere, di cui studiò le relazioni evolutive e la distribuzione geografica. Era facile incontrarlo con i suoi studenti in escursioni botaniche in varie parti dello stato, specialmente nella Sierra Nevada e nella Sierra Santa Lucia. Più conosceva la flora californiana, più crescevano le sue raccolte (oggi formano il nucleo principale del Dudley Herbarium dell'Università di Stanford) ma anche la consapevolezza della devastazione degli habitat naturali e la preoccupazione per gli alberi minacciati dalla speculazione. Nel 1892 fu uno dei primi membri del Sierra Club, una delle primissime associazioni ambientaliste, fondata da John Muir per proteggere la Sierra Nevada e i suoi boschi di sequoie giganti Sequoiodendron giganteum. Nel 1895, insieme allo stesso Muir e al geologo di Berkeley Joseph Le Conte, fu uno dei portavoce del club in un forum pubblico tenutosi a San Francisco sul tema "Parchi nazionali e riserve forestali", in cui sostenne che bisognava cessare di cedere a privati le terre demaniali, che andavano invece convertite in parchi nazionali. In un articolo pubblicato sul bollettino del Sierra club tra la fine del 1895 e l'inizio del 1896, riferì che le sue indagini sul campo dimostravano che i due milioni di acri di sequoie che un tempo si estendevano per cinquecento miglia lungo le colline costiere dell'Oregon e della California stavano scomparendo a un ritmo tale che l'antica specie rischiava l'estinzione. Insieme a un collega di Stanford, il docente di ingegneria civile Charles Wing, visitò e mappò l'area del Big Basin, scoprendo che i migliori boschi di sequoie erano stati venduti a compagnie di legname e decimati. L'unico modo per salvarli era acquistare i boschi e trasformarli in un parco statale, e l'area più adatta era proprio il Big Basin, che la distanza dalla ferrovia e le peculiarità topografiche avevano preservato pressoché intatto; tuttavia, i boscaioli avevano già iniziato il loro lavoro e, se non venivano fermati, scrisse in un articolo pubblicato nel marzo 1900, entro due anni "la regione, invece di un Eden, diventerà peggio del Sahara". Nella fatidica riunione del maggio 1900 nella biblioteca di Stanford, l'indignazione di Hill e la competenza di Dudley si incontrarono. Tra l'estate e l'autunno la campagna per salvare le sequoie del Big Basin prese il volo, con ogni membro del club impegnato a suo modo per smuovere l'opinione pubblica, coinvolgere altre associazioni, arruolare politici e convincere gli industriali che i turisti attirati dal parco avrebbero portato più soldi dello sfruttamento del legname. L'argomentazione fece breccia almeno su Henry L. Middleton che si dichiarò disposto a vendere i 14000 acri che la sua compagnia possedeva nel Big Basin offrendone al club l'opzione di acquisto per un anno. Dudley, che da tempo era membro dell'American Forestry Association, fece da tramite con il servizio forestale nazionale e ottenne l'appoggio del suo capo, Gifford Pinchot. Reed scrisse una proposta di legge per l'istituzione di un parco statale che nel gennaio 1901 fu presentata all'Assemblea dello Stato della California da un politico amico; respinta nella forma iniziale, che prevedeva lo stanziamento di 500.000 dollari per l'acquisto di 5000 acri, fu approvata quando venne ridotta a 250.000 dollari e a 2500 acri. Era una grandissima delusione per il Sempervirens club che puntava su un grande parco da 35.000 a 60.000 acri; anche Dudley riteneva che "per gli scopi scientifici, e anche per un buon parco pubblico" il minimo fossero 35.000 acri. L'istituzione del California Redwood Park (dal 1927 avrebbe mutato nome in Big Basin Redwoods State Park) venne approvata dal senato con voto quasi unanime nel marzo 1901. Per presiedere alla sua realizzazione, venne creata una commissione, formata dal governatore e da quattro membri di sua nomina, tra cui il professor Dudley, che ne fu il segretario fino allo scioglimento nel 1905. Finalmente, nel settembre 1902, con l'acquisto di 2500 acri di foresta, più 800 acri di chaparral e 500 acri di terreno da riforestare donati da Middleton, il parco divenne realtà. Molto più piccolo di quanto sperato, era comunque un inizio, nonché il primo dei circa 280 tra parchi statali e riserve naturali che oggi esistono in California. Il Sempervirens Club non si sciolse, ma continuò la sua battaglia per estenderne i limiti. Negli anni successivi arrivarono piccole donazioni di altri terreni e nel 1916 il parco incorporò quasi 4000 acri convertiti da terre federali, estendendosi così fino alla costa. Oggi la sua estensione è di 10,800 acri (44 Km2). Oltre ad ospitare il più grande gruppo di Sequoia sempervirens a sud di San Francisco, include una varietà di ambienti che vanno dalle foreste miste di sequoie, altre conifere e querce al chaparral, ai canyon umidi, alla vegetazione costiera, estendendosi dal livello del mare a circa 600 metri di altitudine. Purtroppo nell'agosto 2020 è stato catastroficamente investito dagli incendi che hanno devastato la California settentrionale; sono andate distrutte tutte le strutture del parco e almeno 15.000 alberi, principalmente abeti di Douglas. Anche alcune sequoie sono cadute, ma la maggior parte di quelle più antiche sono rimaste in piedi. Dopo essere rimasto chiuso per due anni, oggi il parco è di nuovo aperto, sebbene in modo limitato. Il paesaggio ha mutato volto ma, secondo gli esperti sta lentamente recuperando. La maggior parte delle sequoie è sopravvissuta, e dai tronchi anneriti dall'incendio stanno rispuntando ciuffi di fogliame. Non è certo la prima volta che questi antichi giganti affrontano il fuoco: si sono evoluti con gli incendi e si riprendono molto più facilmente di altre specie, grazie alla corteccia spessa più di 30 cm che protegge gli strati più interni dal fuoco, ai tannini che proteggono le eventuali ferite dagli attacchi di funghi e insetti, alle gemme dormienti sia alla base sia lungo il tronco e i rami che permettono loro sia di emettere germogli basali sia di rigermogliare dai rami e dallo stesso tronco.  Perché i botanici cambiano i nomi: il caso di Dudleya Ma è ora di ritornare al prof. Dudley che tanto fece per far nascere il parco. Anche negli anni successivi continuò ad impegnarsi nelle battaglie ambientaliste. Nel 1904, insieme all'amico Jordan e alla botanica Alice Eastwood, partecipò a una manifestazione indetta a San Francisco dal California Club per bloccare la vendita di 1000 acri di foresta contenenti antiche sequoie ai piedi del Monte Tamalpais. Era un insegnante innamorato della sua materia e amato dagli studenti e nei suoi 18 anni di insegnamento a Stanford formò intere generazioni di eccellenti botanici; era uno studioso coscienzioso, ma forse fin troppo autocritico e forse per questo le sue pubblicazioni californiane si limitano ai numerosi articoli, dedicati soprattutto alle foreste e agli alberi della California, che egli pubblicò tra il 1889 e il 1910 sul Bollettino del Sierra Club e su The Forester, la rivista dell'American Forestry Association. Progettò a lungo un lavoro complessivo sulle conifere degli Stati Uniti occidentali, ma il progetto non andò mai oltre lo stadio di manoscritto incompleto. Nel 1908 andò Persia per esplorarne le foreste; in Egitto contrasse una grave bronchite che degenerò in tubercolosi, che nel 1910 lo costrinse a lasciare l'insegnamento e nel 1911 lo portò alla morte. Grande esploratore della flora californiana, è ricordato dall'eponimo di vari funghi (fu anche micologo) e di piante come gli endemismi Triteleya dudleyi, Pedicularis dudleyi e Polystichum dudleyi. Nel 1903 Britton e Rose gli dedicarono il genere Dudleya, endemico di ambienti rocciosi lungo la costa pacifica, dall'Oregon meridionale alla Baja California settentrionale, con una laconica nota: "Nominato in onore del prof. William R. Dudley della Stanford University". Questo genere di una cinquantina di piante succulente della famiglia Crassulaceae è caratterizzato da una grande varietà morfologica (dalle piccole geofite decidue alte pochi cm alle grandi sempreverdi con rosette di 50 cm di diametro), con fiori a stella simili a quelli di Sedum, oppure tubolari o amcora pendenti e campanuliformi come quelli di Echeveria. Solo recentemente tanta varietà è stata ricondotta a un unico genere, mentre i primi botanici che si occuparono di queste piante le attribuirono variamente ai generi Echeveria, Cotyledon e Sedum. Queste incertezze sono perfettamente testimoniate da Dudleya cespitosa, una geofita tuberosa endemica della California meridionale, la prima ad essere descritta. Nel 1803 Haworth la pubblicò come Cotyledon cespitosum, mentre nel 1811 von Jacquin la classificò come Sedum cotyledon e Aiton come Cotyledon linguiformis. Altre due specie, Dudleya pulverulenta e D. lanceolata, furono invece pubblicate nel 1840 da Nuttall come Echeveria pulverulenta e E. lanceolata. All'inizio del Novecento una vera rivoluzione fu attuata da Nelson e Rose che sistemarono questo gruppo di piante in ben tre nuovi generi: Dudleya, cui attribuirono una sessantina di specie, 40 delle quali descritte da loro per la prima volta, Stylophyllum con 12 specie, e Hasseanthus con 4 specie. Negli anni '30, Alwin Berger li ritenne tutti e tre superflui, spostando Dudleya e Stylophyllum in Echeveria e Hasseanthus in Sedum, i due generi da cui riteneva si fossero rispettivamente evoluti. Le sue conclusioni furono largamente accettate dai botanici fino alla metà del Novecento, quando incominciarono ad apparire le prime analisi filogenetiche molecolari. Nel 1942, Reid Moran separò nuovamente Dudleya e Stylophyllum da Echeveria, riunendoli in Dudleya come sottogeneri; mantenne Hasseanthus come genere distinto, ma strettamente imparentato. Fu il punto di partenza delle ricerche successive che hanno dimostrato che Dudleya si è evoluto in epoca relativamente recente (5 milioni di anni fa) da Sedum, non da Echeveria, come si riteneva in precedenza, e va assegnato alla tribù Sedoideae. Anche se rimangono molti punti da chiarire, oggi al variabile genere Dudleya sono assegnate circa 50 specie, divise in tre sottogeneri: Dudleya (Eududleya secondo la terminologia di Moran), caratterizzato da rosette di foglie appiattite e fiori con petali saldati in un tubo; Stylophyllum, caratterizzato da foglie strette che assomigliano a dita o più raramente da foglie piatte, e petali non fusi che si allargano al centro; Hasseanthus, caratterizzato da cormi sotterranei, piccole foglie che cadono dopo la fioritura, fiori ampiamenti diffusi. Le Dudleya in genere si presentano come succulente da piccole a grandi con foglie carnose, in alcune specie appiattite, in altre tubolari, in altre ancora orbicolari, riunite a rosetta; in diverse specie sono ricoperte da un rivestimento ceroso, detto farina, generalmente bianco, gessoso o farinoso; in poche specie a proteggere le piante dal sole è un sottile strato oleoso e appiccicoso. Il colore del fogliame varia dal verde al grigio. Le rosette possono essere solitarie o cespitose, con diverse rosette che partono da un caudex centrale. Mentre, ad eccezione delle specie più grandi, nel resto dell'anno rimangono piuttosto nascoste nelle fessure delle rocce che sono il loro habitat tipico, al momento della fioritura al centro delle rosette emergono uno o più robusti gambi carnosi che in genere si dividono all'apice in divesri rami, ciascuno dei quali portano 10-15 piccoli fiori (o più) comunemente bianchi o gialli, ma anche rosa, arancio o rossi. Nelle specie di maggiori dimensioni, come D. brittonii (non ha caso nota come "giant Dudleya"), la rosetta raggiunge i 50 cm di diametro e l'infiorescenza può arrivare anche a un'ottantina di cm, mentre nelle minuscole specie del sottogenere Hasseanthus come D. brevifolia le foglie rimangono quasi sepolte nella terra e il peduncolo florale non supera i 4 cm. A differenza di Echeveria, con il quale è ancora spesso confuso, Dudleya non è ancora largamente coltivato, ma purtroppo ha attirato fin troppo l'attenzione dei collezionisti: uno dei pericoli maggiori per la sopravvivenza di molte specie, endemiche di aree piuttosto ristrette, è la raccolta indiscriminata in natura di quelle più rare, che vendono vendute a carissimo prezzo soprattutto sul mercato asiatico. Una recente legge ha introdotto una multa di 5000 dollari per ogni esemplare di Dudleya raccolto su suolo pubblico, che salgono a 40.000 alla seconda infrazione. A minacciare le Dudleya sono anche l'espansione degli ambienti urbani e sempre più i cambiamenti climatici, ed in particolare la siccità invernale: ad differenza di altre succulente, sono per lo più originarie di aree con piogge invernali, che è anche la stagione del loro massimo rigoglio, mentre l'estate, quando la temperatura supera i 30°, è la stagione del riposo. Tra i dedicatari di generi vegetali ci sono molti sovrani, ma un solo papa: è Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli. Uomo coltissimo, fu il primo papa umanista; protettore delle scienze e delle arti, creò il primo nucleo della Biblioteca apostolica vaticana. Alcuni lo ritengono anche il fondatore dell'orto botanico di Roma; certamente arricchì i giardini del Vaticano, ma probabilmente l'affermazione è esagerata. Merito sicuro è invece aver fatto tradurre dal greco l'Almagesto di Tolomeo e le opere botaniche di Teofrasto, auree fonti di sapienza da cui sarebbero risorte le scienze naturali, come sottolinea Domenico Viviani nel dedicare al dottissimo pontefice il genere Parentucellia (Orobanchaceae).  Un pontefice umanista L'unico papa a cui è stato dedicato un genere vegetale sicuramente amava le piante, e forse ne aveva una buona conoscenza. Si tratta di Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli (1397-1455). Sia il padre (che perse piccolissimo), sia il patrigno erano medici, e potrebbe aver imparato in famiglia ad apprezzare le piante, soprattutto quelle medicinali, in un'epoca in cui la maggior parte dei farmaci era di origine vegetale. Del resto, oltre ad essere un ottimo oratore e un fine teologo, era tanto erudito in ogni campo dello scibile che il suo amico-rivale Enea Silvio Piccolomini, papa a sua volta come Pio II, diceva di lui "ciò che non sa è al di fuori del campo della conoscenza umana". Aveva incominciato a farsi notare negli ambienti intellettuali di Firenze, dove si era trasferito adolescente (era nato presumibilmente a Sarzana) e, giovane orfano senza mezzi, si guadagnava la vita come precettore nella casa del colto banchiere Palla Strozzi. Le sue qualità intellettuali attirarono l'attenzione del vescovo di Bologna Niccolò Albergati, che lo volle con sé, ne finanziò gli studi e ne propiziò la carriera ecclesiastica. Quando Albergati divenne cardinale, Parentucelli ebbe modo di accompagnarlo in un viaggio diplomatico in vari paesi europei, che gli permise anche di raccogliere numerosi manoscritti. Quindi si mise in luce nel Concilio di Firenze per le sue posizioni anti conciliariste. Alla morte di Albergati nel 1444, divenne a sua volta vescovo di Bologna; fu poi inviato in Germania come diplomatico e si mosse con tanta abilità che per ricompensa nel 1446 fu nominato cardinale. Un anno dopo, un conclave lampo di appena due giorni lo elesse papa e, in ricordo del suo protettore, volle assumere il nome di Niccolò. Ad aprirgli la strada fu l'opposizione della famiglia Orsini, all'elezione del candidato più forte, il cardinale Prospero Colonna, ma contarono certamente la sua fama di erudito, la vicinanza al papa precedente Eugenio IV (di cui pronunciò l'orazione funebre(, e la sua grande abilità di diplomatico. Il suo pontificato durò appena otto anni, ma fu assai incisivo. Sul piano politico, conobbe successi, come il concordato stipulato con l'imperatore Federico III che avrebbe regolato i rapporti tra Asburgo e Santa Sede fino all'inizio dell'Ottocento, ma anche l'amarezza della caduta di Costantinopoli nel 1453, per evitare la quale aveva inutilmente cercato di organizzare una guerra santa. Niccolò V è però ricordato soprattutto come il primo papa umanista. Fin dall'avvento al pontificato, si impegnò nella creazione di una biblioteca papale, nella quale investì gran parte delle entrate del giubileo da lui indetto per l'anno 1450. I suoi agenti setacciavano le biblioteche di tutta Europa e non badavano a spese per acquistare (o ottenere in prestito per essere copiati, se l'acquisto era impossibile) i manoscritti più rari. Essi operavano in Francia, in Inghilterra, nell'Europa centrale e non trascurarono la Grecia e Costantinopoli; in tal modo, nell'arco dei pochi anni del suo pontificato furono raccolti 1200 manoscritti (400 dei quali greci) che andarono a costituire il primo nucleo della Biblioteca apostolica vaticana. Si circondò di umanisti e protesse studiosi anche controversi come Lorenzo Valla, incoraggiò il lavoro dei filologi per giungere a testi criticamente fondati, promosse una vasta serie di versioni latine integrali di caposaldi della letteratura e della scienza greca; su sua richiesta, Filelfo tradusse I detti degli Spartani di Plutarco, Valla Le storie di Tucidide, Guarino Veronese la Geografia di Strabone, Teodoro Gaza De Natura Plantarum di Teofrasto e i Problemata attribuiti ad Aristotele, tradotti anche dal Trapezunzio, autore pure di una versione latina dell'Almagesto di Tolomeo. Significativamente, gli ultimi due erano greci in fuga dall'avanzata turca; come umanista, papa Parentucelli sentì la caduta di Costantinopoli come un colpo non solo alla cristianità, ma anche alla cultura, tanto da scrivere ad Enea Silvio Piccolomini che essa era "una seconda morte per Omero e per Platone". Il recupero di manoscritti, il programma di traduzioni, l'accoglienza riservata ai sapienti greci ebbero un ruolo importantissimo nella riscoperta della cultura greca e nella sua piena integrazione nell'umanesimo. Notevole fu anche l'impegno urbanistico di Niccolò V, forse ispirato da Leon Battista Alberti, che aveva conosciuto in gioventù e nel 1452 gli dedicò il trattato De re aedificatoria. Il pontefice varò un ampio piano di riassetto della città (noto come "piano nicolino"), basato su cinque capisaldi: il rafforzamento delle mura, la costruzione di un nuovo acquedotto, la ricostruzione del palazzo del Vaticano, il restauro della Basilica di San Pietro e di altre chiese, la ristrutturazione del Palazzo apostolico dove fu realizzata la Cappella nicolina con dipinti del Beato Angelico e di Benozzo Gozzoli. Numerosi lavori vennero realizzati in previsione del giubileo del 1450 che richiamò a Roma moltissimi pellegrini. Nell'ambito di queste ristrutturazioni, Niccolò V si occupò anche dei giardini vaticani. La creazione degli Horti vaticani si deve a un altro Niccolò, terzo del nome, che intorno al 1280 trasferì la residenza del pontefice sul colle del Vaticano e la fece circondare da nuove mura, all'interno delle quali fece impiantare un orto-giardino (viridarium), un prato (pratellum) e un frutteto (pomerium). Secondo alcuni studiosi, nel viridarium, forse già all'epoca di Niccolò III o a partire dal 1288, per opera del medico personale di Niccolò IV, il frate simplicista Simone da Genova, si coltivavano anche piante medicinali. Nella sua biografia di Niccolò V, l'umanista fiorentino Giannozzo Manetti riferisce che, in seguito alla ristrutturazione ordinata da papa Parentucelli, l'area verde a ridosso del palazzo del Vaticano venne trasformata in "un grande e splendido giardino, ricco di ogni genere di erbe e di frutti e irrigato dall'acqua perenne, che il pontefice aveva portato fin lì con grandi spese e ancor maggiore abilità tecnica dalla cima del monte" (si tratta del già citati acquedotto). Sempre secondo Manetti, una seconda area verde fu creata a ovest del Palazzo, dove poi sarebbe sorto il Belvedere. Su questo secondo giardino si affacciava una loggia, oggi scomparsa, destinata alle celebrazioni liturgiche pontificie. Un'altra testimonianza si deve a Giovanni Ruccellai che nella sua relazione sul giubileo del 1450 scrive con ammirazione della residenza del pontefice e dei suoi giardini: "Il Palazzo del Papa... bellissima abitazione, con giardini grandi et piccoli et con una peschiera et fontane d'acqua et con una conigliera". L'aspetto generale del complesso del Vaticano è infine documentato da un affresco di Bonozzo Gozzoli, conservato nella chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano; nella parte alta del dipinto, all'interno della cinta muraria si vede un'ampia zona libera, genericamente sistemata a verde (potrebbe trattarsi di orti o frutteti) e una seconda area, prospicente al Palazzo con loggiato, nei pressi della Porta Viridaria, con un giardino formale, dove si osservano aiuole squadrate, con al centro un albero, che circondano una specie di padiglione piramidale, con una struttura fissa probabilmente in legno che fa da supporto a piante rampicanti. Insomma, certamente Niccolò V fece ristrutturare i giardini vaticani con una certa magnificenza, in accordo con il suo programma urbanistico di rilancio della città in generale e del Vaticano in particolare, ma si può davvero dire che sia anche il fondatore dell'Orto botanico di Roma, come si legge in vari siti, secondo i quali avrebbe fatto adibire una parte degli Horti vaticani a "orto medico per lo studio e l'insegnamento della botanica"? Escludiamo subito "lo studio e l'insegnamento": il decreto papale che istituisce l'insegnamento della botanica farmaceutica (declaratio simplicium medicinae) presso l'università di Roma è del 1513 (regnante Leone X) e l'istituzione di un orto botanico, come vedremo più avanti, addirittura del 1566. Che poi in una parte degli Horti vaticani si coltivassero piante medicinali, è possibilissimo, anzi probabile, ma non per questo possiamo parlare (senza documenti di sorta a provarlo) di hortus medicus e tanto meno di orto botanico. A riguardo sono ancora valide le considerazioni di Saccardo: "Già nel 1288 esisteva un orto farmaceutico (non didattico) nel Vaticano, piantatovi dal celebre Simone Genuense, allora medico di papa Niccolò IV. E di simile specie doveva essere l'orto che Niccolò V faceva coltivare pure nel Vaticano intorno al 1447 cunctis herbarum generibus refertus [pieno di ogni genere di erbe], come dice il Muratori. Un vero orto scientifico-didattico sorse nel Vaticano solo nel 1566 per opera di Michele Mercati, professore insigne e medico di Clemente VIII, già discepolo e amico di Cesalpino".  Modeste erbacee semiparassite Che Nicolò V avesse fondato non solo la Biblioteca vaticana ma anche l'orto botanico di Roma era convinto invece Domenico Viviani che, nel dedicare il genere Parentucellia al conterraneo (erano entrambi spezzini, Viviani di Levanto, Parentucelli di Sarzana) scrive così: "Ho nominato questo genere in onore di T. Parentucelli, nativo di Sarzana in Liguria, meritatamente ritenuto uno degli uomini più dotti del XV secolo, che assunto al pontificato con il nome di Niccolò V, fondò la Biblioteca vaticana e l'orto botanico di Roma; accolse con amabile ospitalità a Roma i sapienti cacciati dalla Grecia dai Turchi; e ad essi, affinché i loro frutti non andassero perduti per noi, affidò la traduzione in latino degli scritti dei filosofi greci; a Teodoro Gaza Historia plantarum di Teofrasto e De animalibus di Aristotele, al Trapezunzio i Problemata di Aristotele ed altro. Così, con i propizi auspici di tanto uomo, da queste fonti di aurea dottrina rifulse la prima luce delle scienze naturali". Possiamo convenire con Viviani che aver fatto risorgere Teofrasto sia un merito sufficiente a fare entrare papa Parentucelli nel canone dei dedicatari di generi botanici. Il genere Parentucellia (Orobanchaceae) non ha per altro nulla di pontificale o celebrativo. Raccoglie infatti da una a tre specie di modeste annuali erbacee semiparassite diffuse nel bacino del Mediterraneo; come altre specie di questa famiglia, benché siano provviste di clorofilla, traggono una parte dei nutrienti dalle radici di piante ospiti con cui si connettono mediante austori. Come tutti i generi di questo gruppo, affini a Bartsia, ha avuto una storia tassonomica travagliata. Separato appunto da Viviani da Euphrasia, è stato alternativamente riconosciuto o inserito in altri generi. POWO gli attribuisce tre specie: P. latifolia, P. viscosa e P. flaviflora, che potrebbero però essere ridotte a una sola se P. viscosa va inserito in Bellardia, come sostengono sulla base di dati molecolari Uribe-Convers e Tank, e se P. flaviflora va considerato una sottospecie di P. latifolia. Questa linea è stata seguita anche da Acta plantarum, che considera valida la denominazione Bellardia viscosa, come anch'io ho fatto qui. In tal caso, nella flora italiana troviamo una sola specie di Parentucellia, appunto P. latifolia. Ha un ampio areale che va dalle Canarie all'Afghanistan, e nel nostro paese è presente in quasi tutte le regioni (manca nel Nord est), tipicamente in pascoli aridi o incolti con terreno calcareo, in collina o in montagna fino a 1200 metri; ha fusti eretti, semplici o ramificati solo nella porzione superiore, foglie talvolta dentate ricoperte da peli ghiandolari; i piccoli fiori sono raggruppati in infiorescenze apicali compatte, da subsferiche a cilindriche, e hanno corolla zigomorfa a cinque lobi da rossastri a viola, da cui il nome comune perlina rossiccia. P. flaviflora, diffusa dal Mediterraneo Orientale all'Asia centrale, è molto simile, tanto che come ho anticipato alcuni la considerato una sottospecie della precedente; è di dimensioni minori e ha fiori da bianchi a giallastri. All'inizio della botanica inglese c'è - e non poteva essere diverso - un plantsman, un uomo di piante. Non un botanico accademico, ma un barbiere-chirurgo che era forse soprattutto un giardiniere. Era anche un collezionista che nel suo giardino di Holborn coltivava piante esotiche, che fu tra i primi a far conoscere: tra di esse, la patata e la bella di notte Mirabilis jalapa. Nella storia della botanica, è celebre soprattutto come autore di The Herball, or General Historie of Plants che rimase il testo di riferimento in Inghilterra per tutto il Seicento (e oltre), ma gli attirò anche accuse di plagio che ne hanno screditato la figura agli occhi dei posteri. Nonostante queste polemiche, Plumier e Linneo vollero ricordarlo con il genere Gerardia, oggi non più accettato, come non lo sono la maggior parte dei piccoli generi, che, modificando un poco il nome linneano, vennero creati da altri botanici; a ricordare in modo indiretto Gerard rimangono solo due piccoli generi di Orobanchaceae africane, Gerardiina e Graderia (anagramma di Gerardia). 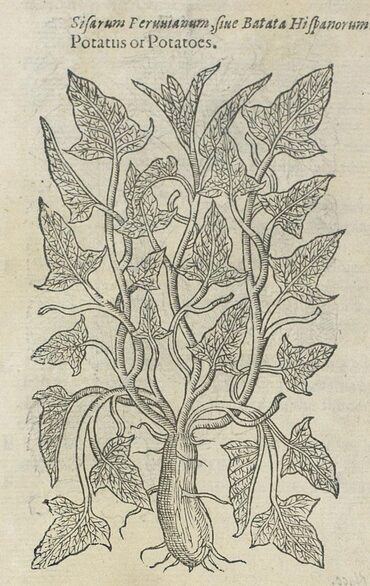 Il primo catalogo di un giardino John Gerard (1545-1612) divide con William Turner l'onore di essere uno dei padri fondatori della botanica inglese. Ma mentre Turner era un medico con una formazione accademica e aveva persino studiato in Italia, dove era stato allievo di Ghini, Gerard è un tipico plantsman, un uomo di piante, una persona che ha imparato a conoscere (e ad amare) le piante coltivandole con le sue mani. Era un barbiere-chirurgo, una formazione professionale che non si acquisiva frequentando un corso universitario, ma con l'apprendistato in bottega; ma poi per molti anni fu un giardiniere, e forse anche un vivaista e un progettista di giardini. In tal modo riunì in sé le due figure che, in un'Inghilterra dove ancora non esistevano né cattedre universitarie di botanica né orti botanici, si dividevano l'interesse per lo studio più o meno empirico delle piante: da una parte medici, chirurghi, farmacisti, dall'altra giardinieri, vivaisti, collezionisti e proprietari di giardini. La sua biografia è in molte parti oscura, come ben si conviene a un contemporaneo di Shakespeare. Ci è noto che nacque a Nantwich nel Cheshire, ma nulla sappiamo dei genitori; nell'antiporta dell'Herball, Gerard fece stampare lo stemma dei Gerard of Ince, rivendicando - a torto o ragione - origini nobili. Frequentò la scuola del vicino villaggio di Willaston e nel 1562, diciassettenne, si trasferì a Londra per iniziare l'apprendistato presso Alexander Mason, un barbiere-chirurgo di Londra che aveva un'ampia clientela e per due volte fu Maestro della Compagnia. Sette anni dopo, nel 1569, come d'uso, fu ammesso alla Compagnia e poté praticare la professione. Poi abbiamo un buco di otto anni, che forse riempì viaggiando come chirurgo di bordo sulle navi della Company of Merchant Adventurers di Londra che commerciavano sulle rotte del Baltico. Nei suoi scritti vanta infatti di aver viaggiato e fa riferimento a Scandinavia, Polonia, Estonia e Russia. Entro il 1577 fu assunto come sovrintendente dei giardini di William Cecil, primo lord Burghley; dunque nel frattempo in qualche modo si era qualificato come herbarist, ovvero esperto di piante e giardini (da non confondere con herbalist, erborista ed esperto di piante medicinali, anche se una cosa non esclude l'altra). Lord Burghley, custode del sigillo reale, due volte segretario di stato, gran tesoriere, era niente meno che l'uomo politico più vicino alla regina Elisabetta, quindi il più potente del regno; patrono delle arti, era interessato all'orticultura e i suoi giardini, che considerava la più grande delle sue felicità, erano ricchi di piante rare e dettavano la moda. Lavorare per lui - Gerard fu al suo servizio per un ventennio, fin quasi alla morte del ministro - oltre a dargli grande reputazione professionale, permise al nostro chirurgo-giardiniere di entrare in contatto con personaggi di primo piano come Lancelot Browne, il medico personale della regina, e George Baker, Maestro della compagnia dei barbieri chirurghi, che poi firmeranno due delle lettere prefatorie dell'Herball. Era a tutti gli effetti un membro riconosciuto del circolo di appassionati che ricercavano e scambiavano piante rare. Tra i suoi contatti troviamo "colleghi" come Master Huggens, curatore del giardino di Hampton Court, Master Fowles, curatore del giardino reale di Saint James e abile coltivatore di meloni zuccherini, il botanico fiammingo Mathias de L'Obel, curatore del giardino di lord Zouche, e i farmacisti James Garrett, Hugh Morgan e Richard Garth, proprietari di ben giardini nella City. Garth, che importava piante dal Sud America, era amico di Clusius, e forse lo presentò a Gerard (il botanico visitò Londra tre volte tra il 1571 e il 1581). Curare i giardini dell'uomo politico più influente d'Inghilterra, che fu anche segretario di stato, ovvero ministro degli esteri, garantì a Gerard un accesso privilegiato alle piante esotiche che giungevano nel paese grazie a mercanti, diplomatici ed avventurieri. Ad esempio, nell'Herball, a proposito di Lillie of Constantinople (variamente identificato come Lilium martagon o L. chalcedonicum) scrive "fu inviato al mio onorevole e buon signore il lord Tesoriere d'Inghilterra, insieme a molti altri bulbi e fiori rari e delicati da Master Harbran, ambasciatore a Costantinopoli". Anche se scritto in modo scorretto, identifichiamo nel personaggio William Harborne, mercante e diplomatico, che rappresentò Elisabetta presso la corte ottomana dal 1582 al 1588. Lord Burghley possedeva due giardini: quello della residenza ufficiale londinese, nello Strand, e quello della tenuta di campagna, a Theobalds nello Hertfordshire. Di quello londinese conosciamo la pianta: si trovava a nord della casa e delle sue dipendenze e comprendeva un labirinto a spirale, un parterre con quattro quadranti e un vasto frutteto. Di quello di Theobalds ci è giunta invece solo una descrizione molto più tarda, addirittura di fine Settecento, quando aveva già subito molte trasformazioni, soprattutto dopo che era diventato di proprietà reale e Giacomo I ne aveva fatto la sua residenza; sappiamo che era molto vasto, comprendeva un lago con isolotti, labirinti, canali e nove giardini a nodi, almeno qualcuno dei quali potrebbe risalire all'epoca di lord Burghley e Gerard. Il ministro teneva molto alla tenuta di campagna, che doveva rappresentare anche visivamente la potenza e la gloria d'Inghilterra ed essere degna di ospitare la regina, che in effetti la visitò otto volte tra il 1572 e il 1592. Per il palazzo e gli appartamenti egli si affidò ai migliori artigiani e per il giardino appunto a Gerard, che disegnò il giardino formale in stile francese, a quanto pare ispirandosi ai giardini di Fontainebleau (non come li vediamo oggi, ma quelli rinascimentali della corte di Francesco I e Caterina de' Medici); ci saranno stati dunque almeno una fontana, giochi d'acqua, uno stagno, parterre a nodi. Con un protettore così influente, la fortuna di Gerard era fatta. Grazie a un'ampia rete di contatti e alla generosità del suo signore, che non di rado gli donò le piante rare che egli coltivava per lui, John Gerard creò anche un proprio giardino, situato a Fetter Lane nel quartiere di Holborn, alla periferia occidentale di Londra (anche questo terreno e il cottage annesso dovevano essere di proprietà del generiso lord Burghley). Ricchissimo di piante rare, quello di Holborn era anche un giardino sperimentale, dove Gerard tentava - a volte con successo, a volte meno - la coltivazione di specie esotiche. Ed è come esperto di esotiche che nel 1586 il Collegio dei medici di Londra gli affidò la gestione del proprio giardino, all'epoca situato a Knightrider Street,a sud della cattedrale di St Paul. Negli annali della Compagnia si legge: "John Gerard, chirurgo, ha promesso che si prenderà cura del giardino della Compagnia, e consente di rifornirlo con tutte le piante più rare a un prezzo ragionevole". Quali fossero queste "piante più rare" non sappiamo, ma sicuramente egli avrà attinto al giardino-vivaio di Holborn, che invece ci è noto grazie al catalogo che Gerard pubblicò nel 1596. Si tratta niente meno del primo catalogo di un giardino giunto fino a noi: gli unici precedenti sono De hortis Germaniae di Conrad Gessner (1561) che, anche se contiene un elenco di piante consigliate, non è il catalogo di un giardino, ma una rassegna di giardini; e Hortus Lusatiae di Johannes Franke (1594), che però, insieme alle specie coltivate nei giardini della Lusazia, tratta anche piante selvatiche. Preceduto da una dedica "Agli eccellenti e diligenti indagatori delle piante", e intitolato semplicemente "Catalogus horti Johannis Gerardi londinensis", l'opuscolo di 24 pagine elenca in ordine alfabetico, da Abies e Zyziphus, circa ottocento specie, indicate con il nome latino; solo la voce Iucca è corredata da un breve testo sull'origine e le caratteristiche della piante. A concludere la lista, una dichiarazione di Mathieu de L'Obel: "Attesto che le erbe, le stirpi, gli arbusti, i suffrutici, gli alberetti recensiti in questo catalogo, in gran parte anzi quasi tutti li ho visti a Londra nel giardino di John Gerard, chirurgo e botanico più che ottimo (infatti non germogliano, spuntano e fioriscono tutti nello stessa stagione, ma in vari tempi dell'anno). 1 giugno 1596". Era un'opera alla buona, pensata per gli amici (che saranno stati anche clienti, se quello di Gerard era anche un vivaio), piena di refusi. Nel 1599, quando Gerard aveva già pubblicato l'Herball e la sua fama aveva travalicato i confini dei circoli di appassionati, ne pubblicò una seconda edizione ampliata e corretta, con il più pomposo titolo Catalogus arborum fruticum ac plantarum tam indigenarum quam exoticarum, in horto Ioannis Gerardi civis et Chirurgi Londinensis nascentium e la dedica a sir Walther Raleigh. In una copia, presumibilmente passata per le mani di L'Obel, la dichiarazione finale è cancellata da un rabbioso tratto di penna, ed è seguita dalla nota manoscritta "Questo è falsissimo. Mathias de l'Obel". Entrambe le edizioni, di cui ci sono giunte pochissime copie, sono state ripubblicate nel 1876 dal botanico Benjamin Daydon Jackson, precedute da una biografia di Gerard (basata su ricerche accurate e ancora largamente valida); i nomi latini di Gerard sono accompagnati da quelli volgari tratti dall'Herball e dai nomi botanici in uso a fine Ottocento e talvolta da brevi note e citazioni tratte sempre dall'Herball. In questo modo, incrociando il laconico elenco con quanto Gerard stesso dice nell'erbario, ci premette una visita guidata nel favoloso giardino di Holburn, dove egli coltivava letteralmente di tutto, comprese piante di alto fusto. Moltissime era specie native, raccolte da Gerard nelle sue frequenti erborizzazioni, o introdotte in Inghilterra da secoli; tra di esse c'erano ovviamente le piante officinali ricercate da medici e farmacisti, piante aromatiche (pescando qua e là, troviamo molte salvie, il basilico a foglia grande e a foglia piccola, il cerfoglio, Anthriscus cerefolium, che egli dice di aver seminato una sola volta, perché successivamente si seminava da sé, e così via), molte orticole, di cui Gerard ricercava le varietà più nuove e produttive, come una barbabietola molto grande e vivacemente rossa che gli fu portata "attraverso i mari" dal cortese mercante Master Lete, o ancora rare, come la melanzana che nel suo giardino riuscì a fiorire, ma non a fruttificare per il sopraggiungere dell'inverno. Moltissimi erano gli alberi da frutto: trenta varietà di pruni, dieci di peschi, albicocchi, meli, ma anche un corniolo a frutti bianchi, gelsi bianchi e gelsi neri, un fico nano molto produttivo, un arancio e un melograno. Grande era la varietà di piante ornamentali: spiccano le numerosissime bulbose (anemoni e ranuncoli, Allium, gigli, crochi, narcisi, scille, iris, giacinti, Muscari, ornitogali e asfodeli, Fritillaria meleagris e F. imperialis, nonché tulipani "in numero e varietà di colori infiniti", nonostante fossero arrivati in Inghilterra da pochissimi anni); e poi peonie, garofani (compresa una varietà gialla "mai vista né sentita in queste contrade", portatagli dalla Polonia ancora dal servizievole Lete), varie specie di primule, sedici varietà di rose semplici e doppie, campanule e violette, e via elencando. A suscitare il massimo orgoglio di Gerard erano le novità esotiche, che era riuscito a procurarsi grazie agli amici farmacisti o a mercanti inglesi che operavano all'estero, come il già citato Nicholas Lete (membro della Compagna della Turchia, importava piante dal Mediterraneo orientale ed è citato anche da Parkinson come "ricco mercante e amante di tutti i bei fiori") e John Franqueville (che, sempre secondo Parkinson, possedeva il negozio di fiori "più grande che ora fiorisce in questo paese"); come abbiamo già visto, diverse specie gli furono donate dal suo signore lord Burgley; altre gli arrivarono da un altro gentiluomo appassionato di piante, lord Zouche, che nella sua tenuta di Hackney possedeva un giardino che univa le funzioni di giardino di piacere e di physic garden e, come abbiamo già visto, era presieduto da da Mathias de L'Obel. Più volte è citato anche "il mio caro amico Robin", ovvero il giardiniere del re di Francia Jean Robin, che gli inviò tra l'altro semi di Periploca graeca, Epimedium alpinum, Fritillaria meleagris, Geranium lucidum. Corrispondeva anche con l'ormai anziano Camerarius, citato per l'invio di Poterium spinosum, che prosperò per due anni e poi morì "per qualche accidente". Per i giardini inglesi d'epoca elisabettiana, il Mediterraneo era ancora un giacimento di inesplorate ricchezze floricole. Per procurarsene il maggior numero possibile, Gerard spedì in Grecia il domestico William Marshall, che a Lepanto raccolse per lui un ramo di Platanus orientalis con tanto di frutti; a Zante invece trapiantò in grandi vasi diverse piante di fico d'India, che arrivarono sane, salve e verdeggianti a Londra, dove Gerard dispiegò grandi sforzi e grande denaro "per proteggerle dalle ingiurie del nostro freddo clima" e riuscì infine a fare fiorire. Introdotta in Europa dagli Spagnoli dal Messico nei primissimi tempi della conquista, evidentemente Opuntia ficus-indica in mezzo secolo aveva già fatto in tempo a naturalizzarsi sulle coste mediterranee. E lo stesso avevano fatto i Tagetes, che Gerard crede originari della Tunisia e portati in Europa all'epoca della presa di Tunisi da parte di Carlo V. Non sono le sole americane: a Holborn Gerard coltivava "pomi d'amore" (ovvero pomodori) a frutti rossi e gialli, e due tipi di patate: la patata comune o spagnola, ovvero la batata Ipomoea batatas, e la patata bastarda, ovvero quella che per noi è la vera patata, Solanum tuberosum, che sembra sia stato il primo a coltivare in Inghilterra. Erano novità anche il "grande fiore del sole" ovvero il girasole Helianthus annuus e la "meraviglia del Perù", ovvero Mirabilis jalapa, che all'epoca creava sensazione con i suoi fiori di diverso colore sulla stessa pianta; Gerard possedeva anche due pianticelle del nordamericano Liquidambar styraciflua, forse uno delle prime settembrine (Symphyotrichum novi-belgii), non si fece mancare i tabacchi Nicotiana rustica e Nicotiana tabacum, e tentò di coltivare il "cero del Perù" Cereus peruvianus che gli fu portato "dalle coste della Barbaria", ma soccombette ai primi freddi. Nel 1593 ricevette una pianta che gli fu indicata erroneamente come cassava e come tale l'avrebbe pubblicata nell'Herball; si trattava invece di Yucca gloriosa. 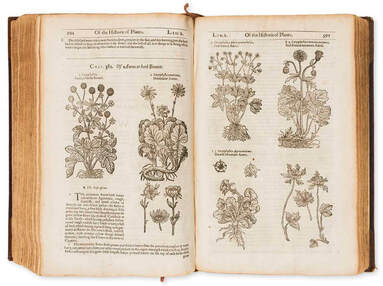 Un best seller che ha fatto discutere Negli ultimi anni del secolo, Gerard (per altro ignoriamo se, tra tanti impegni, praticasse ancora l'attività di chirurgo) fece carriera nella corporazione dei barbieri e chirurghi. Nel 1595 entrò a far parte della Court of Assistants, ovvero del comitato direttivo, nel 1597 fu nominato Custode minore (Junior Warden), nel 1598 entrò a far parte del collegio che esaminava i candidati all'ammissione alla professione ed infine nel 1607 completò l'ascesa come Maestro della Compagnia. Il suo contributo maggiore alla corporazione fu probabilmente la proposta di istituire un Physic Garden, ovvero un giardino dove gli apprendisti potessero studiare le erbe medicinali; nel 1596 gli fu anche commissionato di "cercare un posto migliore per un frutteto di quello di East Smithfields o Fetter Lane". Ignoriamo se però il giardino venne effettivamente creato. Sappiamo invece che nel 1604 la regina Anne (consorte di Giacomo I) concesse a Gerard, citato come chirurgo e erborista del re, l'affitto di un terreno a giardino adiacente Somerset House, a condizione che lo rifornisse di erbe, fiori e frutti. In quegli anni era ormai famoso come autore di The Herball, or Generall historie of plantes, che per oltre un secolo sarebbe stata l'opera di riferimento in Inghilterra. L'idea della pubblicazione non risaliva a lui, ma all'editore John Norton che nel 1596 commissionò al medico Robert Priest una nuova traduzione di Stirpium historiae pemptades sex di Dodoens, che a sua volta era la versione latina del suo Cruydeboeck che nel 1578 era già stato tradotto da Henry Lyte sotto il titolo A Niewe Herball. Vedendo il successo di quest'ultimo, Norton pensava ci fosse un mercato per una nuova traduzione accompagnata da illustrazioni di qualità, e si era accordato con l'editore Nicholaus Bassaeus per affittare le matrici xilografiche di Eicones plantantum di Tabernaemontanus, uscito a Francoforte nel 1590. Tuttavia, prima di completare il lavoro Priest morì e l'editore chiese a Gerard di completare l'opera. Egli dovette lavorare abbastanza in fretta; uno dei suoi biografi, R. H. Jeffers, suggerisce che egli lavorasse già a un proprio erbario, forse fin da quando era entrato al servizio di lord Burghley. La poderosa opera (un in foglio di 1392 pagine, più preliminari e indici, illustrato da 1292 xilografie) poté essere stampata entro il 1597, nonostante gli enormi problemi tecnici - e gli enormi costi. L'editore aveva visto giusto: benché non fosse certo per tutte le tasche, l'erbario di Gerard fu un immediato successo: fu ristampato due volte e nel 1633 ne fu predisposta una seconda edizione, affidata al farmacista Thomas Johnson. Diviso in tre sezioni o libri, ciascuno dedicato a un gruppo di piante (il primo a graminacee, giunchi, iris, bulbose; il secondo alle erbacee alimentari, medicinali e profumate; il terzo a alberi, arbusti, fruttiferi, rose, eriche, muschi, coralli e funghi), e in 167 capitoli, l'erbario tratta un migliaio di piante. Ogni capitolo ha un titolo, dato dal nome volgare della pianta (o del gruppo di piante affini) ed è suddiviso in paragrafi contraddistinti da un titoletto, secondo una struttura ricorrente: i tipi; la descrizione, eventualmente suddivisa in più paragrafi numerati, se i tipi sono più di uno; il luogo (l'habitat, l'origine, ma anche, per le piante da lui stesso coltivate, da chi l'ha ottenuta o i luoghi in cui l'ha vista), l'epoca di fioritura, i nomi (in latino, nei classici, nelle lingue volgari), la natura, secondo la teoria degli umori, le virtù (ovvero le proprietà medicinali e gli usi). Ogni capitolo è solitamente illustrato da almeno due xilografie, con il nome delle specie in latino e in inglese. Era una struttura familiare al pubblico inglese, perché era già stata adottata nel rifacimento di Lyte, ma l'opera si qualificava come del tutto nuova per i chiari caratteri di stampa, gli elaborati capilettera e l'apparato iconografico; non solo le xilografie sono molto più numerose, ma, come abbiamo visto, non derivano dall'opera di Dodoens, ma da quella di Tabernaemontanus, le cui immagini però a loro volta raramente erano originali; provenivano infatti dalle opere di Fuchs, Brunfels, Mattioli e dei botanici fiamminghi pubblicati da Plantin, ovvero lo stesso Dodoens, L'Obel e Clusius. Solo 16 sono nuove. Quanto ai testi, che attirarono a Gerard l'accusa di plagio, la questione è complicata, e per dirimerla non basta sentire una sola campana. Partiamo da quanto ne dice lo stesso Gerard. Nella prefazione egli scrive: "Il dottor Priest, uno del nostro Collegio di Londra, ha (come ho saputo) tradotto l'ultima edizione di Dodonaeus, con l'intenzione di pubblicarla; ma essendo stato preceduto dalla morte, la sua traduzione è parimenti andata perduta; infine, io stesso, uno dei minori fra tanti, ho ritenuto di portare all'attenzione del mondo il primo frutto dei miei propri lavori". Egli dunque, pur riconoscendo il precedente di Priest, non ammette di averne utilizzato la traduzione e presenta l'opera come propria e indipendente. La seconda campana è quella di Mathias de L'Obel, ed è anche quella che ha suonato più forte, imponendosi come vulgata. L'Obel era stato amicissimo di Gerard e, come abbiamo visto, testimoniò questa amicizia nella nota finale del Catalogo del giardino di Holborn, poi cassata nella seconda edizione, quando l'amicizia si trasformò in rancore. Il motivo è spiegato in un'opera postuma, Stirpium illustrationes, un'antologia di scritti basati su un manoscritto terminato da L'Obel poco prima della morte (1616) e pubblicato molti anni dopo (1655). Egli racconta che, mentre in tipografia sia stava componendo il testo di Gerard, vi capitò il farmacista Garrett che, data un'occhiata alle bozze, si accorse che erano piene di errori. Lo fece notare a Norton, che incaricò L'Obel di rivedere il testo. Il fiammingo non solo rilevò più di mille errori, ma soprattutto si accorse che molte parte erano copiate da opere sue o di Clusius. Quando Norton fece presente la cosa a Gerard, questi si giustificò dicendo che L'Obel, essendo fiammingo, non capiva bene l'inglese ed aveva equivocato. L'editore, avendo già investito molto denaro, decise di pubblicare il testo così com'era e Gerard si affrettò a completare la terza parte, che in effetti è la più breve e appare affrettata. La terza campana è quella di Thomas Johnson, il curatore dell'edizione del 1633, che aggiunse alla trattazione di Gerard altre 800 piante e 700 illustrazioni; per lo più si tratta di specie esotiche come il banano Musa × paradisiaca. Nella prefazione incluse una biografia di Gerard (non sempre esatta; ad esempio, riferisce che egli morì nel 1607 anziché nel 1612) e riassunse le vicende editoriali dell'erbario, precisando che l'iniziativa del volume venne dall'editore che affidò la traduzione delle Pemptades di Dodoens al dottor Priest, ma questi morì "subito prima o immediatamente dopo aver finito la traduzione"; a questo punto qualcuno "che conosceva sia il Dr. Priest sia Mr. Gerard" diede il manoscritto a questo ultimo. L'innominato sarà senza dubbio l'editore Norton. Si pose però un problema; dato che le xilografie erano tratte dal testo di Tabernaemontanus, e non da quello di Dodoens, furono necessari adattamenti per far collimare testo e immagini. Sempre secondo Johnson, fu questo il motivo che spinse Gerard ad abbandonare l'ordine e la classificazione di Dodoens, per adottare quella di L'Obel. Inoltre, in molti casi non riuscì ad identificare correttamente le immagini e diede loro una didascalia errata. Dunque, tanto L'Obel quanto Johnson accusano Gerard di essere un plagiario. La loro versione è senz'altro adottata da Anne Pavord che scrive "In effetti, Gerard piratò la sua [di Priest] traduzione, riordinò i materiali per adattarli alla pionieristica organizzazione di Lobelius, e poi presentò il libro come proprio" e lo definisce senza mezzi termini "un plagiario e un truffatore". Insiste poi sul fatto che non era né uno studioso né un botanico, ma un praticone, capace persino di prendere per vera la storia dell'albero delle oche o barnacle, che "spunta tra marzo e aprile; le oche si formano tra maggio e giugno e raggiungono la pienezza del piumaggio un mese dopo". Eppure riconosce che, oltre a far conoscere molte nuove piante che era riuscito a procurarsi per primo grazie ai suoi molti contatti, sapeva scrivere descrizioni vivide e, includendo indicazioni molto precise sui luoghi dove crescevamo le piante, "ha contribuito alla graduale costruzione di una mappa della flora britannica e alla comprensione della sua distribuzione". Completamente opposta la posizione di Sarah Neville, che ha intitolato un capitolo del suo Early Modern Herbals and the Book Trade "John Norton and the Redemption of John Gerard". Per Neville, bisogna fare la tara alle accuse tanto di L'Obel quanto di Johnson. Quando scrisse il suo atto d'accusa, il fiammingo era ormai un vecchio amareggiato che aveva mal digerito che, pur pieno d'errori e approssimativo, l'Herball di Gerard fosse diventato un best seller, mentre il suo dotto e innovativo Stirpia adversaria nova era riuscita a stento, in vent'anni, a vedere un migliaio di copie. Quanto a Johnson, sminuire il suo predecessore era il modo migliore per valorizzare e distinguere il proprio contributo, senza dimenticare la rivalità tra i barbieri-chirurghi e i più colti farmacisti. Ma soprattutto, al di là della credibilità di L'Obel e Johnson, accusare Gerard di plagio è anacronistico; tutti gli erbari del tempo erano largamente intertestuali. Non solo le xilografie transitavano disinvoltamente da un volume all'altro, ma capitava spesso che "le opere scritte da scrittori precedenti fossero il punto di partenza di quelle successive". Mentre le piante da descrivere aumentavano vertiginosamente ed era necessario riorganizzare continuamente le informazioni, per i primi botanici "copiare era più la norma che l'eccezione". La maggioranza dei botanici e degli editori del Cinquecento "riprendevano il materiale dei loro predecessori, mantenendo le informazioni che ritenevano rilevanti e scartavano o respingevano il resto". Ed era anche normale "denigrare il lavoro degli altri e citare i loro errori per giustificare i propri lavori che li aggiornavano e li correggevano". E così conclude: "John Gerard era dunque un ladro, un plagiario? Il passato e la botanica scolastica l'hanno spesso raccontato così; ma ora il tempo e studi più approfonditi sugli agenti che producevano e vendevano gli erbari nella Londra della prima età moderna sembrano raccontarla in modo diverso". Aggiungo solo un particolare: una delle lettere dedicatorie che precedono il testo dell'Herball è scritta da L'Obel, che si esprime in termini affettuosi ed lusinghieri nei confronti di Gerard. Se davvero avesse scoperto la soperchieria del barbiere-chirurgo, si può pensare che avrebbe impedito che la lettera fosse pubblicata. Che Gerard avesse attinto a piene mani alla sua opera è un fatto, ma sembra che la collera del fiammingo sia scoppiata con qualche ritardo.  Gerardia & friends, un rompicapo tassonomico Accettiamo dunque l'invito di Neville di non giudicare il passato con l'occhio e la morale di oggi. Del resto, non l'hanno fatto i tantissimi che ancora nel Settecento consideravano il libro di Gerard un testo di riferimento, lo lasciavano in eredità tra gli oggetti più preziosi, lo citavano a loro volta. Né lo fecero il padre Plumier e Linneo, che vollero onorarlo con il genere Gerardia. Le vicende di questo genere linneano, oggi non più accettato, sono complicate, e hanno lasciato una traccia nella storia della botanica, generando ben sei altri generi, due soli dei quali oggi validi. Tutto inizia con Plumier che, creando il genere Gerardia in Nova plantarum americanarum genera offre una sintetica biografia di Gerard, limitandosi ai fatti oggettivi, senza esprimere giudizi di merito: "L'inglese John Gerard (come riferisce Johnson nella prefazione dell'edizione emendata), nato a Nantwich nella contea del Cheshire, donde si trasferì a Londra, dove si dedicò alla chirurgia, nella quale progredì tanto da essere eletto maestro di quella corporazione. Pubblicò a Londra nel 1597 una storia delle piante inglesi con le stesse figure di Tabernaemontanus e parecchie di Lobelius, e solo 16 nuove". E' interessante notare che, benché non lo sia affatto, al francese Plumier l'Herball apparisse una flora inglese; del resto, l'attenzione alla flora nativa, almeno dell'area londinese, che Gerard ricercava e raccoglieva nelle sue erborizzazioni, è uno dei meriti dell'opera. Linneo cita già il genere Gerardia in Critica botanica (dove si limita a collegarlo a Gerardus Joh. aglus 1597) e lo ufficializza nella prima edizione di Species plantarum, ma all'unica specie di Plumier (Gerardia tuberosa, oggi Stenandrium tuberosum) fa seguire incongruamente altre specie che non corrispondono alla sua stressa diagnosi. Ciò indusse Bentham a ricreare un nuovo genere Gerardia (1846) limitato a questo secondo gruppo, creando in tal modo una confusione che di fatto è stata risolta invalidando entrambi i generi; quello di Linneo è sinonimo di Stenandrium (Acanthaceae), quello di Bentham di Agalinis (in passato Scrophulariaceae, oggi Orobanchaceae). Il genere Gerardia nel senso di Bentham però fu accettato per decenni e nel frattempo ne furono separati diversi piccoli generi affini, che, riprendendone e modificandone il nome, divennero di fatto omaggi indiretti a Gerard. Iniziamo dai tre oggi non più validi: Dargeria (1843), creato da Ducaisne ricorrendo a un anagramma, sinonimo di Leptorhabdos (Orobanchaceae); Gerardianella, creato da Klotzsch nel 1861, sinonimo di Micrargeria (Orobanchaceae); Gerardiopsis, creato da Endlicher nel 1895, sinonimo di Anticharis (Scrophulariaceae). Veniamo infine ai due generi validi, iniziano da Graderia, stabilito da Bentham nel 1846, contemporaneamente al suo Gerardia. Anche questo nome si basa su un anagramma. Come la maggior parte dei generi fin qui citati, appartiene alla famiglia Orobanchaceae e comprende quattro specie con distribuzione discontinua. G. fruticosa è infatti endemica dell'isola di Socotra, mentre le altre specie vivono nell'Africa meridionale. Sono erbacee perenni o suffrutici con i fusti che emergono da un rizoma legnoso, con foglie opposte o alternate e fiori solitari con calice campanulato e corolla tubolare con cinque ampi lobi arrotondati. Il frutto è una capsula appiattita. Sono considerate emiparassite perché, pur essendo in grado di effettuare la fotosintesi, ricavano nutrienti da altre piante. Le loro radici posseggono infatti piccoli austori con i quali si attaccano alle radici di altre piante, assorbendone acqua e sali minerali. Concludiamo con Gerardiina, stabilito da Endlicher nel 1897, ancora un piccolo genere della famiglia Orobanchaceae; gli sono assegnate due sole specie dell'Africa tropicale, G. angolensis, diffusa dal Burundi al Sudafrica nord-orientale, e G. kundelungensis, endemica dello Zaire. Sono erbacee annuali o perenni, con foglie opposte intere e fiori raggruppati in infiorescenze racemose, con calice pentalobato e corolla campanulata, stretta alla base, quindi dilatata e divisa in cinque lobi. Il frutto è un capsula ovoidale, talvolta più lunga del calice. Due belle piante alpine, Favratia zoysii (sin. Campanula zoysii) e Viola calcarata subsp. zoysii (sin. Viola zoysii), entrambe endemiche delle Alpi Giulie, e il genere orientale di graminacee Zoysia, molto popolare per creare tappeti erbosi resistenti al calpestio e alla siccità, celebrano il barone sloveno Karel Zois, che si fece conoscere nell'ambiente botanico austriaco e tedesco con i suoi invii di piante alpine. Vissuto all'ombra del molto più celebre fratello maggiore Žiga Zois, figura chiave dell'illuminismo sloveno, insieme a lui creò un parco ricco di piante esotiche che comprendeva anche un giardino alpino, il più antico della Slovenia (nonché uno dei primissimi al mondo).  Un fratello famoso e brillante Nei primi anni del Settecento, i fratelli Francesco e Michelangelo Zois, nati a Berbenno in Valle Imagna (Bergamo), andarono a cercare fortuna a Venezia. Mentre il primo rimaneva nella città lagunare, il secondo intorno al 1720 si trasferì a Lubiana per lavorare nella bottega di un conterraneo che aveva fatto fortuna, Peter Anton Codelli, un mercante che commerciava in telerie e materiali ferrosi. Nel 1727, ottenne la cittadinanza e insieme a un socio rilevò la ditta. Era l'inizio di una straordinaria ascesa economica e sociale: già nel 1730 era membro del consiglio municipale, nel 1735 acquistò l'intera ditta e ne espanse gli affari; vedeva in Italia il ferro e l'acciaio della Carniola, importava attraverso Venezia prodotti orientali (uvetta, mandorle, fichi, allume, mastice, candele, incenso) che esportava in Germania e in Austria. Negli anni '40 e '50, grazie all'acquisto di diverse miniere e fonderie, controllava quasi l'intero settore siderurgico della Carniola ed era ormai una delle persone più ricche del paese. Nel 1737 fu insignito della nobiltà ereditaria, nel 1747 sposò in seconde nozze una nobildonna slovena e dal 1760 si fregiò del titolo di barone (Freyherr zu Edelstein). Era anche un grosso proprietario terriero; tra le sue tante proprietà, spicca il castello rinascimentale di Brdo, acquistato intorno a 1755. Situato nei pressi Kranj, al centro di una tenuta di 500 ettari, oggi è la principale sede di rappresentanza della Repubblica di Slovenia; qui visse per gran parte della sua non lunga vita il botanico Karel Zois (Karel Filip Evgen, in tedesco Carl Filipp Eugen Zois Freiherr von Edelstein, 1756-1799). Era uno dei più giovani dei numerosi figli (almeno otto) nati dal secondo matrimonio di Michelangelo Zois; sulla sua vita personale non sappiamo molto, forse perché è stato oscurato dal ben più famoso fratello maggiore Žiga (Sigismondo o Sigmund, 1747-1819), il principale esponente dell'illuminismo sloveno. Oltre a far prosperare gli affari di famiglia con l'aiuto del cugino Bernardin (figlio di un fratello di Michelangelo), Žiga Zois fece del suo palazzo di Lubiana il punto d'incontro degli artisti e degli intellettuali della Carniola; incoraggiò la codificazione dello sloveno, fino ad allora considerato un semplice dialetto, promuovendo anche la pubblicazione del primo giornale in lingua slovena, Lublanske novice. Mecenate di artisti e scienziati, si interessò egli stesso di geologia, mineralogia, zoologia (inviando tra l'altro alcuni esemplari di proteo Proteus anguinus a Schreiber perché ne studiasse l'anatomia), nonché botanica, probabilmente per influsso del fratello. Da buon proprietario di miniere e ferriere, era soprattutto un geologo e come tale è ricordato dal minerale zoisite, che gli fu dedicato nel 1805 da Abraham Gottlob Werner cui ne aveva inviato un campione raccolto sulla Svinška planina. Tra i maggiori esponenti del suo circolo, per il suo ruolo pionieristico nello studio della geologia e della flora delle Alpi Giulie, va citato il chirurgo di origini francesi Belsazar Hacquet (1739-1815); dopo una vita avventurosa, egli lavorò dapprima a Idria come chirurgo minerario e ostetrico. Qui conobbe il lavoro di Scopoli, che attirò la sua attenzione sulla flora della Carniola; ne continuò le ricerche esplorando le Alpi Retiche, Noriche, Carniche e Giulie. Nel 1773 si trasferì a Lubiana come docente del Liceo medico e chirurgico e della scuola di ostetricia e divenne segretario dell'Associazione agricola della Carniola, di cui Žiga Zois era membro eminente; divenuto suo stretto amico e collaboratore, lo aiutò a creare un gabinetto di scienze naturali e una notevole biblioteca e lo assistette nelle sue ricerche mineralogiche e geologiche. Una passione condivisa (anche da Karel, come vedremo più avanti) era quella per le montagne: già nel 1777 Hacquet aveva tentato di raggiungere la vetta del Triglav, la maggiore della Slovenia (2864 m.), ma aveva dovuto accontentarsi del Mali Triglav (2725 m). Certamente su suo suggerimento, nel 1778 il barone Zois finanziò la prima scalata coronata da successo, cui parteciparono il chirurgo Lovrenc Willomitzer (che era stato allievo di Hacquet a Idria), un cacciatore di camosci e due minatori che lavoravano per Zois. Uno di loro, Matevž Kos, è anche il più noto dei raccoglitori di Karel. Proprio la natura del Triglav trascinò Zois nella grande disputa che nel Settecento divideva i geologi; secondo i nettunisti e il loro caposcuola Werner, tutte le rocce avevano un'origine marina; sulla scia dello scozzese James Hatton, i plutonisti sottolineavano invece il ruolo del magma e delle eruzioni vulcaniche nei processi di formazione delle rocce. Un convinto seguace di questa posizione era Johann Ehrenreich von Fichtel di Sibiu in Transilvania, cui Zois aveva inviato campioni di rocce raccolte ai piedi di monti Vršac e Triglav. Nel suo Mineralogische Aufsätze (1794) Fichtel sostenne che questi fossili provavano che le parti basse del massiccio erano costituite da sedimenti di origine marina (calcari secondari), mentre le parti più alte erano costituite da rocce calcaree primarie di origine magmatica. Zois, che tra l'altro corrispondeva con Dolomieu, che fu suo ospite nel 1784, non era d'accordo: era convito che anche le rocce calcaree della sommità fossero di origine marina; se i suoi campioni di fossili venivano dalle parti basse, era perché non aveva chiesto ai suoi uomini di raccoglierne ad altezze maggiori. Urgeva una spedizione geologica in piena regola. Zois la affidò a due sacerdoti, Valentin Vodnik e Jožef Pinhak, accompagnati dal conte Franz Hohenwart e da alcune guide, tra cui Matevž Kos e un altro dei raccoglitori di Karel Zois, Andrej Legat. Nell'agosto il gruppo esplorò il Vršac, a settembre il Triglav, raccogliendo abbastanza fossili da dimostrare le origini marine anche delle parti alte del massiccio. Valentin Vodnik era anche un poeta, e quella scalata ispirò uno dei suoi poemi più celebri, intitolato appunto Vršac. Fu poi uno dei principali redattori di Lublanske novice, riunendo nella sua persona i diversi aspetti del mecenatismo di Žiga Zois: gli interessi letterari, la promozione della lingua e della cultura slovena, la ricerca scientifica e l'amore per la montagna. Della generosità di Zois si giovarono anche i cittadini di Lubiana, cui aprì il giardino che fece costruire su un tratto delle antiche mura; la sua collezione di oltre 5000 minerali andò a costituire il primo nucleo del Museo di scienze naturali di Lubiana.  Un botanico rispettato, ma oscuro Rispetto a questa brillante e poliedrica figura, il fratello minore Karel appare decisamente in ombra. Non faceva parte del "circolo di Zois", e neppure viveva a Lubiana, ma per lo più a Brdo o anche a Javornik nell'Alta Carniola, dove gli Zois, oltre alla loro maggiore fonderia, possedevano una casa padronale. Questa scelta contro corrente e la relativa carenza di informazioni su di lui hanno dato origine a qualche malignità. Uno dei suoi primi biografi, Karel Dežman, ipotizzò che fosse "un po' eccentrico"; Voss raccolse la voce che non fosse in buoni rapporti con il fratello maggiore e che, dopo la sua morte, questi avesse fatto sparire tutti i documenti più o meno compromettenti. Nada Praprotnik, che ha dedicato molti studi a questi precursore della botanica slovena, ritrovando anche documenti inediti, contesta almeno la seconda affermazione; fino al 1795, quando la gravissima gotta di cui soffriva relegò Žiga nella casa di Lubiana e lo costrinse su una sedia a rotelle da lui stesso progettata, il barone trascorreva lunghi periodi a Brdo e Javornik e visitava spesso le ferriere. Condivideva la passione per la botanica del fratello, era orgogliosissimo delle piante che gli furono dedicate, e incoraggiò in ogni modo le sue ricerche. Illuminante a tale proposito è una sua lettera a Hacquet: "La sua passione botanica mi sta già influenzando. Ho avuto la fortuna di potergli inviare il tuo Leontodon terglouense con altri materiali che ho riconosciuto dai tuoi disegni. Sulle nostre montagne ci sono molte piante che tu e il signor Scopoli avete ignorato; i miei numerosi lavoratori delle miniere e delle foreste più alte mi permettono di cercarle. Ho fatto ristrutturare una piccola casa colonica a due terzi dell'altezza di Belščica in modo che l'anno prossimo io vi possa trascorrere il mese di luglio per dedicarmi alla botanica sulle cime e lungo la valle. Successivamente partiremo per Bohinj. Ho trovato modo di far portare mio fratello a cavallo a Vele Polje sul Triglav a basso costo, e spero di arrivarci io stesso". Forse, semplicemente Karel era di salute cagionevole (morì a poco più di quarant'anni), oppure non amava la città e la vita di società. Secondo Wulfen, a iniziarlo alla botanica fu un suo ex allievo del collegio gesuitico di Lubiana, un certo Weber; sicuramente determinante fu l'esempio di Hacquet, autore fra l'altro di una Flora carniolica, che lo stimava al punto che, quando partì da Lubiana alla volta di Leopoli, gli lasciò il suo erbario. Il vero mentore di Karel Zois fu però Franz Xaver Wulfen, al quale il barone sloveno inviò diverse piante che il gesuita pubblicò a partire dal 1788. Nada Praprotnik ne ha individuate una dozzina, a cominciare dalle due che portano il suo nome: Campanula zoysii (oggi Favratia zoysii), raccolta da Zois nelle montagne di Bohinj e sullo Storžič; Viola zoysii (oggi Viola calcarata subsp. zoysii) che gli spedì a Klagenfurt intorno al 1785 "dalle Alpi della Carniola al confine con la Carinzia, viva, ancora con la terra". Altri endemismi delle Alpi Giulie e Carniche segnalate da Zois e pubblicate da Wulfen sono Saxifraga tenella e Moehringia villosa. Zois era anche in contatto con altri botanici: a Willdenow inviò Senecio carniolicus (oggi Jacobaea carniolica), a Sternberg piante vive di Saxifraga atropurpurea (oggi Saxifraga exarata subsp. ampullacea) raccolte a Konjska Planina. Invece Thomas Host lo cita per Stemmacantha rhapontica (oggi Leuzea rhapontica subsp. rhapontica) raccolta sulle montagne di Bohinj. Sappiamo da diverse testimonianze che i fratelli Zois possedevano almeno due capanne o rifugi montani, da cui Karel partiva per le sue escursioni. Abbiamo già incontrato quella che sorgeva sotto Belščica sulle Caravanche; non esiste più ma è rimasto il nome Gospodova koča ("capanna del signore") perche la usava "un signore che era solito raccogliere piante". L'altra si trovava sul Dvojno jezero nella valle dei laghi del Triglav, o forse più in alto presso il lago Ledvice (a meno che le capanne fossero tre). Nel 1795 vi fecero sosta i membri della spedizione al Triglav; secondo la testimonianza di Franz Hohenwart, era costruita in legno di larice, comprendeva un'ampia cucina, dove dormivano anche i servitori, un magazzino per le provviste e le raccolte, camere per gli ospiti, una stanza da letto e un salotto per il barone. Arrivato poco prima del tramonto, il gruppo fu accolto molto ospitalmente e poté ammirare l'opera di Karel Zois che, sebbene si trovasse nel rifugio da solo una settimana, aveva raccolto già più di mille piante, molte delle quali destinate ai suoi corrispondenti; prima che potessero disimpegnarsi, ci vollero due ore! Chiaramente le piante venivano raccolte in più esemplari; alcune venivano essiccate per l'erbario (alla sua morte, Karel Zois lasciò un erbario di 2100 esemplari, per lo più costituito da piante alpine) o per essere spedite ad amici e corrispondenti; altre venivano portate vive a valle. Oltre a quelle raccolte di persona, Zois si serviva di una serie di raccoglitori professionisti; erano fittavoli o dipendenti della famiglia in qualità di boscaioli, cacciatori o minatori; tra i primi scalatori del Triglav, abbiamo già incontrato Matevž Kos e Andrej Legat. Secondo Wulfen, fu Kos a raccogliere Malaxis monophyllos sulle pendici del Vršac. Le piante vive, insieme a ceste di terra di montagna, andavano ad arricchire il giardino alpino che, con molta spesa e grande impegno, Karel Zois volle sul lato sud-est del parco di Brdo. Il castello era circondato da una vasta tenuta, con foreste, stagni, frutteti. Molto probabilmente già all'inizio del Settecento a sud dell'edificio c'era un parterre in stile barocco, con un asse principale lungo 600 metri, percorso da un ampio viale, con aiuole a ramages delimitate da siepi di bosso su entrambi i lati. Questa parte venne mantenute, ma già all'epoca di Michelangelo venne creato un giardino recintato che combinava il giardino di piacere con la tenuta agricola; progettato su due livelli, con un dislivello di 60 cm, era diviso in 24 parcelle rettangolari uniformi e simmetriche, piantate in vario modo e delimitate da alberi da frutto e siepi di agrifoglio. A partire dal 1784 o 1785, i fratelli Zois, pur rispettando la sostanzialmente l'impianto preesistente, intervennero aggiungendo diversi elementi: un nuovo viale con tigli posti su sei file e prati e campi su entrambi i lati; due stagni, ciascuno dei quali dotato di un padiglione estivo a pagoda e collegato al castello da un viale di carpini; diversi edifici, tra cui cottage rustici con il tetto di paglia, una gloriette, una ghiacciaia, una rimessa per barche e una pista da bowling; per le piante esotiche c'erano sia una serra sia un'orangerie, dove venivano ricoverate le piante in vaso che nella bella stagione era esposte all'esterno. Poiché utilizzavano il medesimo impianto di riscaldamento, forse erano due settori dello stesso edificio. Tra il 1785 e il 1796, a Brdo vennero piantati 6.398 alberi e 1.063 arbusti autoctoni ed esotici; le ornamentali esotiche furono fatte venire per lo più dall'Olanda ma anche dall'Inghilterra (tra i fornitori, il celebre vivaio Loddiges); per moltiplicarli, sul lato est venne creato un vivaio (Novina). A Karel le specie esotiche interessavano soprattutto come oggetto di studio; era lui a occuparsi della loro scelta e a tenere i contatti con i fornitori. Alcuni li ottenne anche dai suoi corrispondenti, in particolare da Thomas Host che, in cambio delle piante alpine, gli procurò diverse piante esotiche, probabilmente coltivate a Schönbrunn. La pupilla degli occhi di Karel Zois era però il giardino botanico alpino, che venne creato sul lato più assolato del giardino. Qui egli fece trapiantare le piante alpine che raccoglieva durante le sue escursioni o gli venivano portate dai suoi raccoglitori. Fare crescere e sopravvivere a Brdo, a circa 420 m sul livello del mare, piante che crescono molto più in alto e hanno esigenze particolari e diversificate non dovette essere un'impresa facile. Il giardino fu certamente preparato con grande accuratezza, provvedendo a fornire ad ogni pianta l'esposizione e il terreno giusto. Lo fa pensare il fatto che vi fossero coltivate con successo piante notoriamente difficili come l'orchidea Cypripedium calceolus, le emiparassite Pedicularis o la calcifila Tozzia alpina. Tra i manoscritti di Žiga Zois, ci è giunto un "Elenco principale dei semi delle piante alpine" che però fu certamente scritto da Karel Zois, come si deduce dal fatto che Campanula zoysii è chiamata "campanula mea"; è citata più volte, mentre non sembra che egli coltivasse la "sua" viola: forse era troppo difficile farla prosperare in pianura, o si accontentava di goderla nel suo cottage sulle Caravanche, dove ancora oggi cresce in abbondanza. Molte delle piante alpine coltivate a Brdo erano piuttosto comuni, ma non mancavano le specie più rare come un'altra campanula, Campanula cespitosa, un endemismo delle Alpi orientali scoperto da Scopoli; Lilium carniolicum, di distribuzione strettamente carsica; Primula carniolica, un raro endemismo sloveno che cresce solo nel settore settentrionale della Selva di Trnovo nelle Alpi Giulie; Drypis spinosa, una specie tipica dei ghiaioni calcarei, un endemismo illirico con stazioni disgiunte nelle Alpi di Kamnik; Geranium argenteum, che in Slovenia cresce solo in poche stazioni e probabilmente fu raccolto sul Črna prst, che già Wulfen considerava un vero e proprio giardino naturale per la sua ricchezza di specie. Oltre alle piante dei monti della Slovenia, Karel Zois coltivava anche specie montane ottenute dai suoi corrispondenti: ad esempio, non crescono in Slovenia Lomatogonium carinthiacum e Wulfenia carinthiaca, i cui semi gli vennero inviati dal direttore dell'orto botanico di Vienna von Jacquin. Alcune specie venivano da molto più lontano: nell'elenco e nei quaderni di Zois sono citate piante asiatiche provenienti dalla Siberia, dalla Kamčatka o dal lago Baikal. Probabilmente a procurargliele fu un altro illustre corrispondente, Peter Simon Pallas. Il giardino botanico alpino di Karel Zois è di grande importanza storica: non solo fu il primo orto botanico della Slovenia, ma è in assoluto uno dei primissimi giardini alpini. Basti pensare che l'Alpengarten del Belvedere a Vienna, che vanta la primogenitura, fu fondato successivamente, nel 1803. Tuttavia fu di brevissima durata: Karel Zois morì a soli 43 anni nella casa di famiglia a Trieste. Il fratello, ormai prigioniero della gotta, non visitava da tempo la proprietà, e alla sua morte, nel 1819, la lasciò a un nipote (anch'egli si chiamava Karel Zois) che trascurò del tutto sia il giardino alpino sia il vivaio. Nel catasto del 1826, mentre compare ancora il giardino barocco, non esistono più né l'uno né l'altro.  Erbe per prati indistruttibili Oltre che dall'eponimo delle due specie che gli furono dedicate da Wulfen, Karel Zois è ricordato dal genere Zoysia, omaggio di Willdenow con questa motivazione: "In memoria del barone Karl Zois di Lubiana, che ha studiato con grande zelo la flora del suo paese e attraverso un'attenta ricerca ha scoperto diverse nuove specie". Questo genere della famiglia Poaceae comprende otto specie di erbe originarie di una vasta area che va dall'Oceano indiano al Pacifico, con centro di diversità nell'Asia sud-orientale; sono erbacee perenni rizomatose tappezzanti con lamina fogliare breve, stretta e piatta che formano tappeti erbosi bassi e densi. Originarie di paesi caldi, fanno parte delle cosiddette "essenze macroterme", ovvero di quelle specie di graminacee per prati erbosi che prediligano climi caldi, hanno una notevole resistenza alla siccità, posseggono apparati radicali profondi e aggressivi che consentono loro di riprendersi rapidamente dopo la pausa invernale, durante la quale tendono a ingiallire o a perdere la parte aerea. Sono anche fortemente resistenti al calpestio, per cui trovano largo impiego, oltre che nei prati ornamentali, negli impianti sportivi come campi da golf, da calcio o da rugby, Le Zoysia formano un tappeto erboso molto fitto e compatto, che tende naturalmente a non permettere la crescita delle infestanti (tranne che nel periodo di dormienza, che è uno dei loro talloni d'Achille); la crescita è poi molto lenta, richiedendo quindi tagli meno frequenti delle classiche erbe da prato all'inglese. Ma soprattutto sono estremamente resistenti sia alle alte temperature sia alla siccità. In commercio si trovano essenzialmente due specie, Z. japonica e Z. matrella. Z. japonica, più settentrionale, è presente in Cina, Manciuria, Corea, Giappone; negli Stati Uniti fu introdotta dalla Cina nel 1895 e presto divenne la specie più utilizzata nei due terzi meridionali del paese. Rispetto alle altre specie, ha una tessitura più grossolana, cresce più rapidamente e necessita di almeno quattro ore di sole al giorno. Soprattutto negli Stati Uniti, ne sono state sviluppate numerose cultivar tra le quali 'Zenith' si segnala per la maggiore resistenza alle basse temperature (fino a -10). Z. matrella è diffusa in un'area vastissima che va dal Madagascar e dalle Mascarene a occidente fino alle isole Salomone a oriente; se ne distinguono due varietà: la più occidentale Z. matrella var. matrella, spesso commercializzata con il vecchio nome Z. tenuifolia, anche nota come "erba delle Mascarene" (dal Madagascar all'Australia settentrionale) e la più orientale, Z, matrella var. pacifica (dall'Indocina al Pacifico nord-occidentale), nota come "erba di Manila". Si distingue da Z. japonica per la lamina fogliare più fine (strettissima in Z. matrella var. matrella), i ciuffi più fitti, la predilezione per i terreni sabbiosi anche poveri e la resistenza alla salinità, essendo una specie prevalentemente costiera. La varietà occidentale con il nome Z. tenuifolia è stata fatta conoscere in Europa da Elie Bonaut, floricoltore di Antibes, che ne ha diffuso la coltivazione nella riviera francese. La sua principale caratteristica è la versatilità; inoltre ha un periodo di dormienza più breve (1-2 mesi). Anche di questa specie esistono molte cultivar, come 'BRF Zoysia' (la sigla sta per Blade Runner Farm), una delle più utilizzate per i campi da golf. Esistono anche ibridi tra le due specie, il cui nome botanico è Zoysia x forbesiana, dall'agronomo statunitense che per primo tentò questo incrocio. In epoca di riscaldamento globale e di precipitazioni ridotte, un prato di Zoysia può essere una soluzione particolarmente sostenibile, adatta anche a giardinieri pigri, anche se non sarà davvero "indistruttibile" come vanta la pubblicità. Ma così come c'è uno Zois famoso e uno più defilato, oltre a questa regina del green, abbiamo anche un'altra, più oscura Zoysia, anzi... falsa Zoysia. Nel 1924 in Somalia venne raccolta un'erba che a prima vista assomigliava a una Zoysia, ma non lo era. Nel 1928 il botanico italiano Chiovenda la pubblicò, denominandola Pseudozoysia sessilis. Unica specie di questo genere, è una piccola erbacea perenne, alta meno di 15 cm; anch'essa forma densi ciuffi di foglie con lamina stretta e lineare e ha infiorescenze a falsa spiga con spighette su assi contratti; è un'alofita che cresce sulle dune costiere. Ognuno ha i suoi talenti. Quelli di Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria e imperatore più di nome che di fatto, non erano né la politica né le armi, ma gli affari (per i quali è considerato addirittura un genio), le arti e le scienze. Fu un grande mecenate e lasciò la sua impronta più visibile nel parco di Schönbrunn, dove volle ci fossero anche un serraglio e un orto botanico ricchi di animali e piante esotiche. Su suggerimento dell'archiatra van Swieten, a crearlo furono due giardinieri olandesi, Adrianus van Stekhoven e Ryk van der Schot. Per popolare gabbie e aiuole, l'imperatore progettò di persona e finanziò una spedizione nelle Antille che ebbe grandissimo successo, certo grazie alla competenza e alle capacità organizzative del botanico von Jacquin, ma anche all'ingegno del giardiniere van der Schot che riuscì nell'impresa, rara all'epoca, di fare arrivare vive decine e decine di piante rare. Meritatissima dunque la dedica dell'esotico e sfavillante genere Schotia. 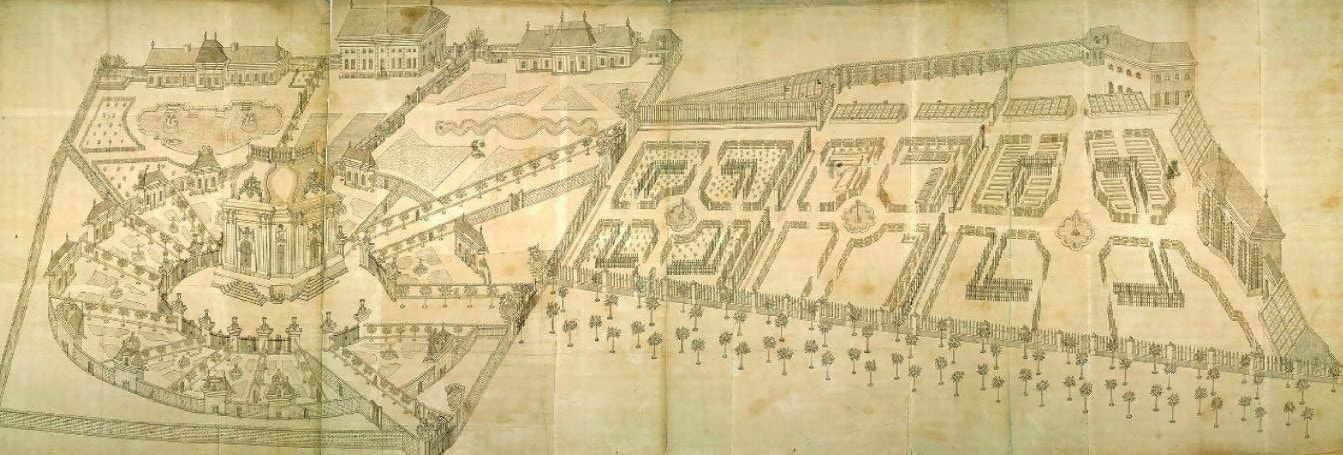 La nascita di un giardino imperiale Avere tempo libero può essere un ottimo affare. Francesco Stefano di Lorena, il marito francese dell'imperatrice Maria Teresa, anche dopo essere stato nominato imperatore come Francesco I, lasciò la cura dello stato alla consorte, che se ne intendeva molto più di lui, e si dedicò a consolidare il patrimonio familiare (abilissimo, lo separò da quello statale e lo moltiplicò, divenendo multimilionario grazie agli ottimi investimenti e a manifatture all'avanguardia) e alle sue svariate passioni. Patito cacciatore e coureur de femmes, buon violinista e mecenate di musicisti e compositori, amante del teatro, fu soprattutto collezionista) collezionava monete e medaglie) e protettore delle scienze. Quando divenne granduca di Toscana, acquistò per 40.000 scudi il ‘Cabinét de curiosités’ dell'erudito Jaen de Baillou, un'ampissima collezione di minerali, fossili, conchiglie, insetti ed altre curiosità naturali, e lo fece venire a Vienna insieme allo stesso Baillou come direttore della sua collezione privata, il primo nucleo del futuro Naturistorische Museum. Gli esemplari vennero sistemati in un palazzo sulla Wallnerstrasse (noto come Kaiserhaus) dove Francesco Stefano aveva i quartieri privati in cui poteva ricevere discretamente diplomatici e i suoi vari emissari, nonché gli scienziati che amava riunire attorno a sé; disponeva di una biblioteca e di un laboratorio ben attrezzato, dove venivano condotti esperimenti utili alle sue attività commerciali. Uno dei frequentatori più assidui era sicuramente l'archiatra van Swieten e probabilmente fu lui a suggerirgli di trasformare anche una parte del parco di Schönbrunn in un vero e proprio centro di ricerca, con un serraglio e un orto botanico. Il palazzo di Schönbrunn era inizialmente un casino di caccia, molto caro dall'imperatrice cui era stato ceduto dal padre, l'imperatore Carlo VI, quando era una giovane sposa; a partire dal 1743, la sovrana ordinò grandi ampliamenti per trasformarlo nella residenza estiva della famiglia imperiale, sontuosa come Versailles ma allo stesso tempo più intima e familiare. Della sistemazione dei giardini si occupò il marito, che si avvalse di diversi artisti fatti venire dalla Lorena. Era un giardino formale alla francese, con viali diagonali che confluivano al centro lungo un asse longitudinale. Di fronte alla facciata sud del palazzo, si allungava un vasto parterre con aiuole a disegni (parterre de broderie), delimitato lateralmente dai "boschetti", stanze verdi con siepi ed alberi potati in forme geometriche. Questa era la parte pubblica e di rappresentanza del parco. C'erano poi giardini riservati alla sola famiglia imperiale, tra cui proprio il settore a vocazione scientifica voluto da Francesco Stefano. Intorno al 1750 egli acquistò dalla comunità di Hietzing un terreno situato all'estremità occidentale del parco. In primo luogo vi fece allestire il serraglio; costruito nel 1751 su disegno dell'architetto lorenese Jean-Nicolas Jadot, ha pianta radiale; il centro è occupato da un padiglione da cui si godeva una vista a 360° sui viali a stella che portavano alle singole gabbie e voliere; è una leggenda che nel sotterraneo si trovasse un laboratorio imperiale segreto. Inaugurato con un grande ricevimento nell'estate del 1752 e, benché trasformato, ancora esistente, è considerato il più antico giardino zoologico del mondo. Nel 1753, iniziarono i lavori per l'annesso orto botanico. Su suggerimento di Van Swieten, fu assunto un esperto orticultore di Leida, la città natale dell'archiatra: Adrianus van Stekhoven (o, alla tedesca, Adrian Steckhoven, 1704/05-1782) arrivò a Vienna insieme al suo assistente Ryk (o Richard) van der Schot (1733-1790), nativo di Delft; portavano con loro 10.000 bulbi e una collezione di piante esotiche, tra cui una palma con una storia. Stekhoven sosteneva che nel 1684 l'avesse fatta venire dall'India lo Statolder Guglielmo d'Orange, poi Guglielmo III d'Inghilterra; all'epoca, la pianta aveva un'eta stimata di 30 anni. Nel 1702 fu donata al re Federico I di Prussia; nel 1739 il suo successore l'aveva donata a lui. Egli la trapiantò nel giardino viennese nel 1753 e nel 1765, con assidue cure, riuscì a farla fiorire e persino a fruttificare. Da quel momento fu per tutti la "palma di Maria Teresa". Scomparsa da molto tempo, non è mai stata identificata con certezza, anche se è stato supposto potesse trattarsi di Corypha umbraculifera, una palma monocarpica nota per la crescita lenta e per aver l'infiorescenza ramificata più grande del mondo. In tal caso, sarà morta poco dopo la prodigiosa fioritura. Ma torniamo al giardino che, creato da maestranze olandesi, è noto come "Giardino olandese". Aveva pianta grosso modo rettangolare; separato dal serraglio sul lato nord da una palizzata, era diviso in tre riquadri, ciascuno dei quali comprendeva quattro aiuole simmetriche, con una fontana centrale, nel punto d'intersezione dei sentieri; nel primo riquadro vennero piantati i bulbi portati dall'Olanda e altri fiori, in quello centrale orticole e piante da fiore, nell'ultimo specie delicate da proteggere in inverno, non ci è noto se in piena terra o in vaso. Al di fuori del giardino, lungo il lato occidentale, c'erano piante da frutto; altri fruttiferi, potati a spalliera, erano coltivati lungo il muro orientale. All'estremità del giardino venne costruita una grande serra, cui più tardi vennero aggiunte due ali; sul lato occidentale, c'erano quattro serre più piccole, forse più simili a cassoni vetrati, e sul fondo la casa del capo giardiniere. Nell'arco di un anno, il giardino fu pronto. Era certo ben organizzato, con le piante sistemate in modo scientifico, secondo il modello dell'orto botanico di Leida, ma appariva ancora molto vuoto, e un po' troppo casalingo e troppo simile simile a un orto. Francesco Stefano avrebbe voluto qualcosa di decisamente più imperiale. Stando alle memorie che Nikolaus Joseph von Jacquin dettò al figlio Joseph Franz, non gli sfuggì che quel giovanotto frequentava assiduamente il recentissimo giardino: ne stava infatti catalogando le piante secondo il sistema di Linneo, ancora ignoto negli Stati austriaci (del resto, Species plantarum è del 1753). Sentito il solito van Swieten, capì che era la persona giusta per popolare quelle aiuole e quelle gabbie troppo vuote. Gli propose di partire per le Indie occidentali a fare incetta di piante e animali esotici. Von Jacquin accettò, e il 9 dicembre 1754, munito di precise istruzioni imperiali e accompagnato dal solo aiuto giardiniere van der Schot, partì all'avventura. Mi riservo di raccontare questa spedizione in un altro post, per concentrarmi qui sul giardino e i suoi giardinieri. Basti ora dire che la spedizione si protrasse per cinque anni e toccò gran parte delle Antille; Von Jacquin si rivelò un ottimo organizzatore e inviò periodicamente a Vienna animali, piante e casse di curiosità naturali; il primo invio dalla Martinica giunse già nell'agosto 1755. All'inizio del 1756, era pronto un invio particolarmente prezioso: 266 tra alberi e arbusti, di 40 specie differenti, in gran parte ancora ignoti in Europa; mediamente gli alberi erano alti un metro, con un tronco del diametro di un braccio e più. Van der Schot li aveva accuratamente preparati al viaggio, estirpandoli dal terreno con una gran parte delle radici; le zolle, che potevano pesare anche 100 libbre, venivano poi avvolte in foglie di banano e assicurate con corde di Hibiscus tiliaceus. Inoltre, per limitare al massimo il fabbisogno d'acqua, le chiome erano state accuratamente potate, mantenendo la forma naturale. Nonostante questi preparativi, se nessuno se ne fosse preso cura durante il viaggio oceanico quelle piante sarebbero in gran parte perite. Ecco perché ad accompagnarle fu van der Schot in persona, che il 28 febbraio si imbarcò con il prezioso carico alla volta dell'Europa su un vascello dal nome ben augurante, l'Espérance. Oltre alle piante c'erano 27 uccelli esotici, un formichiere, un uistitì e dieci casse di conchiglie, pesci essiccati, fossili, minerali e oggetti etnografici. Le piante erano state preparate così bene e seguite con tanta cura che, ad eccezione delle Heliconia divorate dai ratti di bordo, arrivarono tutte sane e salve: uno straordinario successo per l'epoca dei velieri, quando la percentuale di piante vive che riusciva a superare i viaggi transoceanici era bassissima. Von Jacquin spedì a Vienna in tutto sette invii. Con l'ultimo, partito dall'Havana nel gennaio 1759, viaggiava egli stesso, insieme all'ultimo dei suoi compagni, l'uccellatore toscano Barculli. Grazie alla fortunatissima spedizione, il serraglio e il giardino olandese si trovarono d'un colpo a eguagliare se non a superare le collezioni dei giardini reali di Parigi o Londra. Nominato giardiniere imperiale e direttore del giardino di Schönbrunn, Van Stekhoven lo diresse abilmente per molti anni, intervenendo anche nel resto del parco, dove aggiunse tra l'altro una grotta artificiale al di sopra della bella fontana che gli dà il nome. Anche se nel 1765 l'imperatore morì all'improvviso, le collezioni continuarono a crescere; le conosciamo grazie al catalogo manoscritto redatto da Richard var der Schott tra il 1774 e il 1779. Finché, in una fredda giornata del novembre 1780, si produsse un increscioso incidente: mentre van Stekhoven, ormai anziano, giaceva a letto per un attacco di gotta e van der Schot era influenzato, uno degli aiuti dimenticò di ricaricare la stufa della grande serra; al mattino, il capo giardiniere accorse e completò il disastro caricandola troppo: così le piante che erano sopravvissute al gelo morirono per il caldo eccessivo. Non c'è da stupirsi se fu messo a riposo e sostituito da van der Schot, che diresse i giardini imperiali fino alla morte nel 1790, inaugurando anche una dinastia di giardinieri; suo figlio Joseph tra il 1794 e il 1804 fu il capo giardiniere dell'orto botanico universitario di Vienna. In precedenza, era stato uno dei membri della spedizione Märter, decisa da Giuseppe II proprio per rimediare i guasti dell'incidente del 1780. Oltre a lavorare nei giardini imperiali, padre e figlio furono attivi come progettisti di giardini in Boemia. Nel 1785 Richard van der Schot disegnò il parco all'inglese del castello di Veltrus per il conte Johann Chotek, mentre all'inizio dell'Ottocento il figlio passò alle dipendenze del principe di Liechenstein che lo mandò in America a fare incetta di piante per trasformare il parco di Lednice in stile paesaggistico.  Splendide fioriture Van Stekhoven è ricordato da una via di Vienna (Steckovengasse) ma da nessuna pianta, al contrario di van der Schot, onorato dal genere Schotia, istituito da von Jacquin con una dedica che ben testimonia la sua stima per l'antico compagno di viaggio: "Questo alberetto che nel mese di ottobre fiorisce copiosamente e in modo assai elegante nella serra calda del giardino imperiale di Schönbrunn costituisce un nuovo genere; perciò gli ho dato un nuovo nome, desunto dall'eccellente Richard van der Schot, giardiniere imperiale e prefetto del giardino imperiale di Schönbrunn, un tempo mio compagno di viaggio in America, grazie alla cui cura indefessa e all'eccezionale abilità in quel giardino sono oggi coltivate tante piante rare che ogni anno producono fiori". Von Jacquin espresse la sua stima anche scegliendo una pianta particolarmente bella, come lo sono tutte le quattro specie di questo piccolo genere di Fabaceae endemico dell'Africa meridionale. Sono alberi da piccoli a grandi, con vistose fioriture, scarlatte per Schotia afra, S. brachypetala e S. capitata, rosa per S. latifolia. I colori giusti per attirare i loro principali impollinatori, gli uccelli nettarinidi. In effetti producono enormi quantità di nettare, un richiamo e una risorsa anche per api e altri insetti, ma un problema quando vengono piantati in aree pavimentate. Il fogliame decorativo e il portamento aggraziato ne fanno ottime piante da ombra nelle aree non soggette a gelate; nei paesi d'origine hanno però molti alti usi: i semi di tutte le specie sono eduli, e i baccelli vengono raccolti ancora verdi e poi arrostiti; la corteccia di alcune specie veniva usata per produrre coloranti; corteccia, e talvolta foglie e radici, hanno proprietà medicinali. Qualche approfondimento nella scheda. Nel 1696, il frate francescano Francesco Cupani pubblica lo straordinario Hortus Catholicus: è il catalogo delle circa 3000 tra specie e varietà che crescevano nello splendido giardino di Misilmeri, voluto da Giuseppe del Bosco principe di Cattolica. Accanto alle officinali di prammatica, c'erano le specie sicule, molte delle quali raccolte di persona da Cupani, assiduo esploratore della flora dell'isola, e le esotiche più rare, giunte in Sicilia grazie alla rete di corrispondenti italiani e europei abilmente coltivata dal botanico francescano. Rimase invece incompleta e inedita l'ultima opera di Cupani, l'ancor più grandioso Panphyton siculum. Il confratello Plumier volle ricordarlo con il genere Cupania, cui più tardi si affiancò Cupaniopsis. Al suo allievo Bonanno, che tentò di completarne l'opera inedita, è invece toccato il monotipico Bonannia. 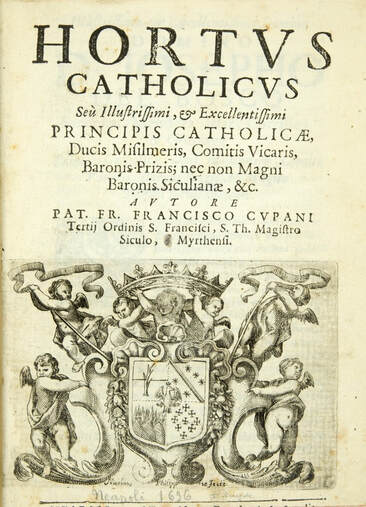 Un giardino straordinario e il suo catalogo Intorno al 1690, Giuseppe del Bosco, principe di Cattolica, decise di trasformare in orto botanico il Giardino Grande del suo palazzo di Misilmeri, a una quindicina di km da Palermo; già esistente almeno dal XV secolo, godeva di acque abbondanti grazie a una vicina sorgente. Non conosciamo nei particolari la genesi del progetto, che voleva anzitutto venire in soccorso delle genti bisognose del feudo attraverso la coltivazione di piante medicinali utili, ma è probabile che sia stato determinante l'incontro con il frate francescano Francesco Cupani (1657-1710), che da qualche anno si stava dedicando all'assidua esplorazione della flora siciliana. Nato a Mirto in provincia di Messina, come riferisce egli stesso nel prologo di Hortus Catholicus, Cupani inizialmente studiò medicina a Palermo, appassionandosi soprattutto di botanica; tuttavia a 24 anni entrò nel terzo ordine francescano, e lasciò lo studio della natura per la filosofia e la teologia, che in seguito insegnò prima a Verona poi a Palermo. La passione per le piante, relegata a svago marginale, si riaccese con forza al ritorno in Sicilia, alimentata dalla frequentazione di medici e speziali come Ignazio Arceri, medico del Regio nosocomio palermitano, e l'aromataro Nicola Gervasi (1632-1681), console del Collegio dei farmacisti e autore dell'Antidotarium Panormitanum Pharmaco-Chimico; di quest'ultimo, che Cupani definisce affettuosamente praceptor meus, "mio maestro", egli loda il giardino palermitano ricchissimo di piante rare. Ma la spinta determinante venne dall'esempio di Paolo Silvio Boccone, suo modello e assiduo corrispondente, che lo incoraggiò a proseguire le ricerche sulla flora indigena. Frutto di quattro anni di erborizzazioni, sfidando il caldo estremo dell'estate e i geli dell'inverno, è la prima opera edita di Cupani, Catalogus plantarum sicularum noviter adinventarum, pubblicata a Palermo nel 1692. Sono appena quattro pagine, con una lista di circa 150 piante in ordine alfabetico; secondo l'uso del tempo Cupani si avvale di nomi-descrizione polinomiali; ad esempio, l'attuale Euphorbia pithyusa subsp. cupanii figura come Tithymalus exiguus, pumilus, saxatilis, Portulaceae foliolis, flosculis rubentibus. A conclusione della lista, in una breve nota il francescano esprime la speranza di poter presto pubblicare le immagini delle piante, a meno che non lo faccia per lui il reverendo Silvio Boccone "famosissimo per la competenza erboristica", al quale ha inviato generosamente tutti gli exsiccata "mosso dall'onore della patria". Al momento dell'uscita del catalogo, il principe di Cattolica gli aveva già affidato la realizzazione del giardino di Misilmeri, in cui alle piante medicinali tanto native quanto esotiche si sarebbero affiancate ornamentali, piante esotiche rare, alberi da frutto e orticole. Per le piante medicinali e autoctone, il frate si avvalse della collaborazione di farmacisti ed erboristi come Pietro Citraro e Francesco Scaglione, nonché degli invii di numerosi corrispondenti che vivevano in parti dell'isola non esplorate di persona; ma continuò anche il lavoro sul campo, tanto che già nel 1694 fu in grado di stampare una seconda lista di piante siciliane, Syllabus plantarum Siciliae nuper detectarum, pubblicata sempre a Palermo, in cui le specie e varietà elencate sono salite a 300. Intanto il giardino cresceva grazie alla munificenza del principe, che lo trasformò in un luogo fatato con statue, fontane e addirittura uno zoo con animali esotici; lo circondava un muro coronato da oltre 600 vasi di piante esotiche, quasi un'anticipazione della ricchissima collezione di piante che racchiudevano. A farle arrivare in Sicilia fu una vasta rete di corrispondenti italiani ed europei che Cupani mise insieme forse con la mediazione iniziale di Boccone. Tra i corrispondenti più assidui troviamo infatti uno dei contatti di Padre Silvio, William Sherard, che a sua volta fece da tramite con botanici, appassionati e collezionisti britannici, gli inviò piante esotiche in cambio di semi siciliani, gli procurò libri (tra gli altri, Historia plantarum di John Ray). Determinante per la crescita del giardino fu poi Giovanni Battista Trionfetti, il curatore dell'orto botanico della Sapienza a Roma, che poté far giungere a Misilmeri le novità che affluivano a Roma grazie a gesuiti e sacerdoti viaggiatori. Tra i corrispondenti di Cupani troviamo molti altri grandi nomi della botanica del tempo: lo stesso Ray, Pitton de Tournefort, Caspar Commelin, i tedeschi Johann Georg Volkamer e Johannes Böhm. Questi scambi epistolari, oltre ad arricchire il giardino, consentirono al botanico siciliano di superare l'isolamento di una località periferica e di tenersi aggiornato sui progressi della botanica e sui grandi dibattiti del suo tempo, procurandosi i testi di riferimento indispensabili per catalogare le piante del giardino; nella nota di autorità premessa a Hortus Catholicus, egli elenca ben 90 titoli, tra i quali, oltre a testi già classici della botanica rinascimentale o del primo Seicento, troviamo libri di pubblicazione recente o recentissima, come il catalogo delle piante canadesi di Cornut (1635), Flora sinica di Boym (1656), la Centuria e il Prodromus di Breyne (rispettivamente 1678 e 1680), il catalogo delle piante olandesi di Jan Commelin (1683), i primi sei volumi di Hortus Malabaricus (1678-1686), il catalogo dell'orto botanico di Montpellier di Magnol (citato nella seconda edizione di Hortus Catholicus, e uscito lo stesso anno 1697). Come si vede, si tratta principalmente di cataloghi di orti botanici e di rassegne di flore esotiche: il problema principale che si poneva Cupani, come si evince anche dalla corrispondenza con Sherard, era infatti la corretta identificazione, per evitare di presentare come nuove piante già pubblicate in precedenza. Nonostante la grande mole di piante da identificare e descrivere, già nel 1696 Cupani fu in grado di dare alle stampe la prima edizione di Hortus Catholicus, accompagnata da un primo supplemento e seguita l'anno dopo da un secondo. E' un'opera imponente, che elenca circa 3000 tra specie e varietà; per le identificazioni e le denominazioni, Cupani rimase fedele all'insegnamento di Boccone, scegliendo una soluzione un po' datata: come punto di riferimento principale per l'identificazione dei generi (il concetto, anche se in modo ancora impreciso, si andava ormai affermando) si affidò all'autorità di Robert Morison, e al suo sistema basato sulla fruttificazione (che in qualche modo poteva essergli familiare, visto che anche Castelli, maestro del suo praeceptor Gervasi, si era basato sui frutti); per le specie e le denominazioni, oltre a Morison stesso, all'ancora più datato Pinax di Caspar Bauhin e all'Historia plantarum di Jean Bauhin. Come nelle liste precedenti, anche in Hortus Catholicus le piante si susseguono in ordine alfabetico, da Abies alba a Yucca. Per quelle già note, tipicamente Cupani parte dalla denominazione del Pinax, seguita, se differenti, da quelle di Jean Bauhin e di Morison; la voce si conclude (e questa invece è una novità) con il nome vernacolo siciliano, nel desiderio di allargare la conoscenza delle piante anche a chi non leggeva il latino. A mo' di esempio, ecco la voce iniziale (corrispondente a Abies alba Mill): Abies alba, seu foemina CBP [ovvero Caspar Bauhin Pinax], sive elate Thilia IB [ovvero Jean Bauhin], vulgo Erva di S. Filippu, o Arvulu cruci, Arvulu caccia diavuli. Ovviamente, se la pianta nel Pinax non compare, Cupani ricorre ad una o più altre autorità, ad esempio per l'attuale Hibiscus mutabilis L. a Paul Hermann, Morison e Ferrari: Althaea arborea, Rosea, Sinensis, flore multiplici HLB [Hermann, Hortus logduno-batavus], Althaea arborea, Sinensis Moris. Hist. 2 [Morison, Historia universalis Oxoniensis vol. 2], Rosa sinensis Ferrari Florae cult. vulgo Rosa Indiana. Per le piante non descritte in precedenza, Cupani usa una denominazione polinomiale, costituita dal nome generico seguito da uno o più epiteti. A tale proposito, si è spesso detto che egli abbia anticipato Linneo, facendo largo uso di nomi binomiali. Lasciando da parte i binomi ripresi da Bauhin (che a sua volta è ritenuto l'inventore dei nomi binomiali, ma non li usò in modo sistematico), vediamo se è vero con un esempio, tratto ancora dalla lettera A. Oltre a sei specie di Acetosa già descritte dai Bauhin e/o da Morison, Cupani ne descrive cinque nuove: "Acetosa Nebroides Arisari pallido-virenti folio", "Acetosa peregrina, lanceolata, vesiculis trigonis, venis sanguineis inscriptis", "Acetosa alienigena caule carens, sterilis, radice nimio reptatu, foecunda", "Acetosa lanceolato folio, e basi lata polyfido, Etnensis", "Acetosa montana angusto folio sagittae". Si tratta, evidentemente, di nomi descrizione polinomiali; anzi, nella secondo supplemento, Cupani esprime la sua perplessità di fronte a nomi troppo brevi che, egli teme, impedirebbero il riconoscimento proprio delle specie nuove. Per dirlo in altri termini, la separazione tra denominazione e descrizione, che Linneo stesso raggiungerà solo in Species plantarum, non è ancora avvenuta. Infatti, in Bibliotheca botanica, lo svedese collocò Cupani non certo tra gli innovatori o i sistematici, ma tra i curiosi, ovvero "coloro che raccolsero piante prima del tutto ignote o mal conosciute e le illustrarono con descrizioni e immagini". Il merito maggiore di Cupani sta ovviamente nell'esplorazione della flora siciliana, di cui fu instancabile raccoglitore e descrittore, segnando un passo avanti notevolissimo anche rispetto a Boccone. Da segnalare è anche l'attenzione alle produzioni agricole locali e soprattutto alle varietà delle piante fruttifere, che ne fanno un antesignano della pomologia: ad esempio, sono elencate e puntigliosamente descritte 35 varietà di mandorli, 48 di fichi, 45 di meli, 73 di peri, 48 di viti, 20 di limoni, 21 di aranci, 5 di cedri. Mentre scriveva Hortus Catholicus, Cupani già pensava a un progetto ancora più ambizioso: una vasta opera illustrata che avrebbe fatto conoscere al mondo la natura siciliana, descrivendo non solo le piante, ma anche gli animali, le conchiglie, i fossili, i minerali. Secondo quanto scrive nel prologo della prima edizione di Hortus Catholicus, intorno al 1696 il lavoro era già abbastanza avanzato: erano state incise 600 delle 800 lastre di rame previste (a pagarle fu evidentemente il generoso principe di Cattolica, che contava di trarre gloria europea dal munifico investimento); per quanto riguarda le piante era sua intenzione specificarne la denominazione secondo le indicazioni dei Bauhin e di Morison, il luogo di origine, le proprietà officinali, l'etimologia, i sinonimi in latino, il nome volgare, il segno celestiale, l'astro dominante e l'epoca più indicata di raccolta. Nel supplemento dell'anno successo, ci informa che ormai le lastre erano tutte pronte e il manoscritto a buon punto, tanto che contava, Dio volendo, di completarlo in pochi mesi. Ma, evidentemente, Dio non volle: il lavoro di raccolta e verifica si prolungò più del previsto e nel 1710 Cupani morì prematuramente, a poco più di cinquant'anni, lasciando l'opera incompleta. Torneremo più avanti sulla sorte di quell'opera sfortunata, per soffermarci sulle vicende successive del giardino di Misilmeri. Morto Cupani, che lo aveva fondato e diretto per quasi vent'anni, la direzione passò successivamente a due suoi collaboratori, Pietro Citraro e Francesco Scaglione. Nel 1714 ricevette la visita di Vittorio Amedeo II, appena divenuto re di Sicilia. Tuttavia nel 1721 Giuseppe del Bosco morì senza lasciare eredi diretti, e le proprietà e i feudi passarono al figlio di una sorella, Francesco Bonanno del Bosco. Nel corso del Settecento, i Bonanno sperperarono il patrimonio familiare. A risentirne fu anche lo splendido ma dispendioso giardino, via via sempre più trascurato. Intorno alla metà del secolo, ebbe ancora un sussulto, grazie all'arrivo da Padova dell'abile capo giardiniere Giovanni Maria Lattini, ma quando questi lasciò l'incarico, insoddisfatto del salario, il declino divenne inarrestabile. Nel 1785, all'atto della fondazione dell'orto botanico di Palermo, con il benestare del principe in carica, 2000 piante tra le più rare furono espiantate e traslate nel nuovo giardino, insieme a vasche di marmo, sedili di pietra e altro materiale. Da quel momento dell'antico Hortus Catholicus del principe Giuseppe del Bosco e di Francesco Cupani rimase solo il ricordo.  Da Cupania a Cupaniopsis A testimoniare il ruolo di Cupani nella scoperta delle piante sicule sono le diverse specie che lo ricordano nell'epiteto, come Colchicum cupanii, Genista cupanii, Aira cupaniana e la già citata Euphorbia pithyusa subsp. cupanii. Tributo alla fama europea del giardino e del suo creatore è invece la dedica del genere Cupania da parte di Plumier, che cita il giardino "ricchissimo di piante fatte venire dalle più remote contrade del mondo" nonché il suo "ordinatissimo catalogo". Poi validato da Linneo, il genere Cupania, della famiglia Sapindaceae, esclusivo dell'America tropicale, dal Messico all'Argentina, con centro di diversità in Brasile, comprende circa 60 specie di alberi e arbusti, che vivono in vari habitat, dalle foreste stagionalmente aride alle foreste pluviali. Benché presentino sia fiori femminili sia fiori maschili sulla stessa pianta, sono funzionalmente dioiche e poligame, poiché i fiori staminati (maschili) e quelli nettariferi (femminili) si aprono in momenti diversi. Hanno foglie composte alternate, con nervature molto evidenti, generalmente coriacee, spesso con faccia superiore glabra e inferiore tomentosa; i fiori, piccoli, con cinque petali e cinque sepali, sono raccolti in grandi infiorescenze spesso molto ramificate e sono seguiti da capsule che contengono semi arillati. Tra le specie di maggiore diffusione, citiamo C. cinerea, originaria delle foreste umide dalla Costa Rica al Brasile, a volte coltivata come ornamentale; particolarmente notevoli i frutti, che a maturazione si aprono formano una stella coriacea con al centro semi neri avvolti in un arillo aranciato. Per la sua chioma elegante, è spesso utilizzata nelle alberature anche C. vernalis, diffusa dalla Bolivia al Brasile e all'Argentina settentrionale. A celebrare indirettamente Cupani, si è aggiunto il genere Cupaniopsis ("simile a Cupania"), stabilito da L.A.T. Radlkofer nel 1879. Anch'esso appartenente alla famiglia Sapindaceae, raggruppa una quarantina di specie di alberi e arbusti diffusi in Nuova Guinea, in Australia e nelle isole del Pacifico; ricorda Cupania per le foglie composte e i frutti a capsula. Purtroppo molte piante di questo genere, endemiche di piccole aree, sono minacciate, in pericolo di estinzione o addirittura già estinte, come C. crassivalvis della Nuova Caledonia, dichiarata estinta nel 1998. La specie più nota è l'australiana C. anacardioides, nota con il nome vernacolare tuckeroo. E' un piccolo albero originario delle foreste litoranee dell'Australia orientale e settentrionale. Più che al momento della fioritura, diventa spettacolare al momento della fruttificazione, quando produce grandi grappoli di capsule aranciate che si aprono in tre lobi, rivelando i semi scuri ricoperti da un arillo arancio brillante; sono appetiti da numerose specie di uccelli. Per la sua bellezza, anche questa specie è spesso utilizzata nelle alberature stradali, soprattutto nelle zone costiere vista la sua tolleranza alla salinità.  Un'opera maledetta e una pianta tossica Per concludere, resta ancora da raccontare della sorte dell'ultima opera inedita di Cupani. Nel 1713, probabilmente per volontà del principe, sotto il titolo Panphyton siculum vennero stampate le sole immagini, con una tiratura di poche copie (se ne conoscono in tutto sette), per altro diverse tra loro, tanto da fare pensare a prove di stampa. I manoscritti furono invece affidati, perché li completasse e li preparasse per la stampa, al farmacista Antonio Bonanno, nei testi d'epoca spesso chiamato Antonino, figlio di Vincenzo, uno dei collaboratori di Cupani, e di una figlia di Nicola Gervasi (per questo motivo, è anche noto come Bonanno Gervasi). Bonanno riuscì a rivedere e predisporre un primo volume, con 187 tavole, che fu stampato nel 1719, ma lo stesso anno morì. Come abbiamo già visto, nel 1721 morì anche il principe, e con la sua morte ebbe fine ogni tentativo di pubblicare quell'opera sfortunata. I manoscritti furono ereditati da un'altra famiglia di farmacisti imparentata con i Bonanno, i Chiarelli, che custodirono gelosamente una copia di Panphyton Siculum in quattro volumi, appartenuta a Antono Bonanno con le sue annotazioni manoscritte, e 16 volumi di note manoscritte di Cupani. Desideravano pubblicarli, ma mancavano le risorse finanziarie. Il momento giusto sembrò arrivare quando entrarono in contatto con il botanico statunitense Rafinesque, che visse in Sicilia dal 1805 al 1815. Deciso a far risorgere il Panphyton, da lui ribattezzato Panphysis sicula, fece approntare copie delle incisioni e cercò di coordinare i suoi sforzi con quelli dei Chiarelli, ma poi anche lui dovette rinunciare. Nel 1815, quando ripartì dall'America, portò con sé le 121 tavole di incisioni che era riuscito a far preparare; al largo del Connecticut si inabissarono nelle acque dell'oceano, insieme alla biblioteca di Rafinesque e circa 60 casse di collezioni; il botanico salvò la vita, ma dovette ricominciare dal nulla. Non stupisce che egli abbia voluto ricordare il tentativo dell'altrettanto sfortunato Bonanno; nel 1814 pubblicò su un giornale siciliano, Specchio delle scienze, il genere Bonannia (Sapindaceae) con queste parole "Questo genere ha gran somiglianza con Cupania [...]; gli ho perciò dato il nome di Bonannia in onore di Antonino Bonanni Gervasi, discepolo ed illustratore del P. Cupani, e del P. Filippo Bonanni gesuita, autore di una conchilogia". Pubblicato su una rivista locale, il nuovo genere passò inosservato. Come nomen rejicendum, è oggi sinonimo di Blighia. Nel 1826, fu la volta del boemo Presl che in Flora Sicula creò un secondo genere Bonannia (Brassicaceae), in onore tanto di Vincenzo quanto di Antonio Bonanno "coetanei e discepoli del reverendo Cupani". Oggi è sinonimo di Brassica. Infine, nel 1843 Gussani in Florae Siculae Synopsis creò un terzo genere Bonannia (Apiaceae); anche se non lo cita esplicitamente, il riferimento a una tavola del volume curato da Bonanni, fa presumere che il dedicatario sia sempre lui; benché sia l'ultimo arrivato, fu accettato dalla comunità scientifica ed è tuttora valido come nomen conservandum. Si tratta di un genere monotipico, rappresentato dalla sola B. graeca, una rara erbacea dei pascoli montani aridi, presente in Sicilia dal Messinese al Palermitano, in Calabria nella Sila e nel Pollino e in poche località sparse in Grecia e nell'Egeo. E' un'erbacea perenne, alta fino a 30 cm, con foglie basali lanceolate e foglie cauline ridotte a guaine, e fiori gialli riuniti in ombrelle. Tutta la pianta emana una resina giallastra tossica, che può causare la morte degli agnelli. Nel 1625 il tipografo romano Mascardi pubblica Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quæ continentur Romæ in horto Farnesiano; nel frontespizio e nella lettera dedicatoria figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Farnese e prefetto del suo giardino sul Palatino, ma diversi elementi hanno indotto gli studiosi a pensare che la paternità vada attribuita a Pietro Castelli, medico illustre e futuro fondatore dell'orto botanico di Messina. Come che sia, l'opera è di grande interesse perché contiene alcune delle prime descrizioni, nonché pregevoli immagini, di piante esotiche di recentissima introduzione, tra le quali Vachellia farnesiana, dedicata propria alla famiglia Farnese nei cui giardini fiorì per la prima volta in Europa. Con o senza meriti, l'altrimenti quasi sconosciuto Tobia Aldini si fregia invece della dedica del genere Aldina (Fabaceae), americano come molte delle piante che coltivava nel giardino dei Farnese. 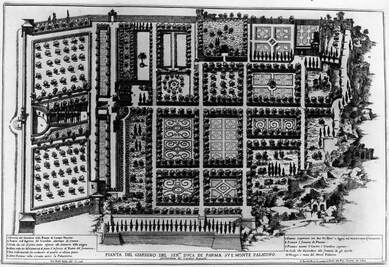 Un giardino rinascimentale adagiato sulla Roma imperiale Fin dagli anni '20 del Cinquecento, il cardinal Farnese, futuro papa Paolo III, incominciò ad acquistare diverse vigne sul Palatino, forse già allora pensando di farvi costruire, a gloria del suo casato in ascesa, un giardino "adagiato" in senso letterale sulle glorie di Roma imperiale. In quest'area sorgeva infatti il primo vero palazzo imperiale, quello di Tiberio, di cui si vedevano imponenti vestigia. E fu su di esse che a partire dal 1565 il celebre architetto Jacopo Barozzi (detto il Vignola, 1507-1573), su incarico del "cardinal nepote" Alessandro Farnese (1520-1589) si appoggiò per creare gli Orti farnesiani, forse il più celebre giardino della Roma rinascimentale. Iniziati dal Vignola e proseguiti da Carlo Rainaldi (1611-1691), i lavori si protrassero per tre generazioni, con il cardinale Odoardo (1573-1626) e il duca di Parma Odoardo I (1612-1646), che ordinò gli ultimi grandi lavori. Ma quando trasferì la sua corte a Parma, per il giardino iniziò il declino. Oggi di quel celebre complesso rimangono alcuni elementi monumentali, sottoposti a un recente restauro: il Ninfeo della pioggia, il Teatro del Fontanone e le sovrastanti uccelliere. Possiamo però ricostruirne l'aspetto al tempo del massimo fulgore grazie a stampe dell'epoca. Il giardino, che supera un dislivello di 20 metri, comprendeva quattro terrazze sovrapposte, collegate da sentieri e scale, con elementi monumentali posti a diversi livelli lungo un unico asse longitudinale, forse sul modello del Tempio della Fortuna primigenia di Palestrina. Il visitatore dell'epoca vi accedeva da un portale monumentale progettato dal Vignola (demolito, fu ricostruito in altra posizione a metà Novecento) e si trovava immediatamente di fronte il Teatro d'ingresso, uno spazio semicircolare adornato da statue e fiancheggiato simmetricamente da due boschetti in pendio; una rampa di scale lo portava al Ninfeo della pioggia, creato da Rainaldi, un vasto ambiente a pianta rettangolare, parzialmente interrato, con nicchie, statue e una fontana decorata con rocce, concrezioni calcaree e stalattiti, che stillando acqua a gocce produceva (e produce) un suono caratteristico che ricorda lo scroscio della pioggia. Da questo ambiente due scale parallele davano accesso direttamente alla terza terrazza, mentre la seconda, una stretta striscia con alberelli in vaso e aiuole geometriche bordate di bosso, era collegata alla prima da quattro sentieri paralleli. Il punto focale della terza terrazza era il Teatro del Fontanone, una fontana monumentale racchiusa in una nicchia absidata decorata da stalattiti da cui l'acqua ricade in un ampio bacino, che faceva da base a una loggia centrale e a due voliere, due edifici a pianta pressoché quadrata che ospitavano uccelli rari ed esotici. affaccianti sul quarto e ultimo ripiano, al quale si accedeva da due scale laterali. A questo punto, il visitatore aveva raggiunto la sommità del colle e il giardino vero e proprio, che si estendeva pressoché in piano, fino al ciglio del Palatino che si affaccia sul Circo Massimo. Era un tipico giardino all'italiana con una serie di "stanze" verdi quadrate o rettangolari con parterres a ramages, bordate da alberi d'alto fusto. La piazza dei platani si distingueva dagli altri scomparti per una fontana con bacino a frastagli, circondata da 10 platani posti in cerchio; da qui, tramite due scale si scendeva al ninfeo degli specchi. Nell'angolo sud-occidentale si trovavano il Casino dei fiori e il giardino segreto, riservato all'esclusiva fruizione del principe, e all'estremo lembo, racchiuso da muri, il selvatico, con le piante lasciate allo stato naturale. Quando i Farnese lasciarono Roma, il giardino andò incontro a un progressivo degrado, e le aiuole tornarono ad essere vigne, orti e carciofaie. Nell'Ottocento, divennero una zona di scavo archeologico, e, mentre le strutture vennero conservate, quanto rimaneva dei giardini fu totalmente distrutto. All'inizio del Novecento, Giacomo Boni, soprannominato l'archeologo giardiniere per la sua passione e i suoi studi sulle piante, risistemò alcune aree a verde, da una parte guardando agli antichi giardini di Roma imperiale, dall'altra proprio agli Orti farnesiani. Per individuare le piante esotiche introdotte all'epoca del Cardinal Odoardo si rifece a Exactissima Descriptio Rarorium Quarundam Plantarum quae continentur Romae in Horto Farnesiano, che è anche il punto di riferimento dell’attuale restauro vegetale del Palatino. 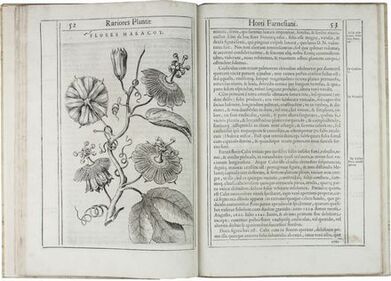 Una paternità contesa Il libro fu pubblicato nel 1625 dal tipografo romano Mascardi, legato all'Accademia dei Lincei di cui pubblicò alcune delle prima opere. Si tratta di un catalogo delle piante rare, per lo più di origine americana, coltivate negli Orti farnesiani al tempo del Cardinal Odoardo, cui il contatto con i gesuiti garantivano l'accesso in anteprima a piante esotiche. La paternità del libro è un piccolo giallo: nel frontespizio e nella lettera dedicatoria al cardinale figura come autore Tobia Aldini, medico del cardinal Odoardo e prefetto degli Orti farnesiani, ma già nel Settecento è stato suggerito che il vero autore potrebbe essere un altro medico attivo a Roma, Pietro Castelli. Infatti subito dopo la dedicatoria si trova un acrostico dedicato "all'eruditissimo autore" in cui la prima lettera di ogni verso forma la scritta Petrus Castellus Romanus; inoltre la nota del tipografo è sparsa di lettere maiuscole che formano la scritta Petrus Castellus e si conclude con la frase in caratteri maiuscoli In gratiam Tobiae Aldini scipsi cunta, "Ho scritto tutto per la benevolenza di Tobia Aldini". Se ne è voluto dedurre che Aldini sia solo un prestanome, o addirittura uno pseudonimo di Castelli. A me pare che la posizione più equilibrata sia quella di Lucia Tongiorgi Tomasi, secondo la quale "sembra più probabile che, sebbene Aldini sia il vero autore, si sia avvalso ampiamente dei consigli e dei suggerimenti dell'illustre botanico, specialmente nella redazione del testo latino". In effetti, Castelli è citato più volte, e potremmo senz'altro attribuire a lui, o almeno alla sua consulenza, gli excursus eruditi, mentre sembrano più farina del sacco di Aldini le puntuali informazioni sulla coltivazioni delle piante, frutto evidentemente dell'esperienza diretta in giardino. Come che sia, si tratta di un testo di grande interesse per conoscere i viaggi delle piante esotiche di fine Rinascimento. E' diviso in sedici capitoli, di lunghezza molto diseguale (da molte pagine a poche righe), ciascuno dedicato a una singola pianta esotica coltivata negli Orti farnesiani, di cui vengono fornite una descrizione spesso molto dettagliata, informazioni sull'arrivo in giardino e sulla coltivazione, le eventuali virtù medicinali e gli usi culinari. Molto pregevoli le illustrazioni in bianco e nero, che in alcuni casi ritraggono anche particolari come i frutti o i semi. Il libro esordisce con un lungo capitolo su Acacia farnesiana (oggi Vachellia farnesiana), di cui costituisce la prima attestazione in Europa; la pianta, ottenuta da semi giunti da San Domingo nel 1611 come dono del granduca di Toscana, si ambientò benissimo, tanto da fiorire copiosamente due volte all'anno; doveva costituire l'orgoglio del cardinale, quindi Aldini le dedica il capitolo più lungo, un vero trattatello di una trentina di pagine, che comprende anche un confronto con la prima acacia nota in Europa, Acacia nilotica. La seconda specie trattata è Hyiucca canedana, ovvero una Yucca che sulla base delle illustrazioni è stata identificata come Yucca gloriosa var. tristis; stranamente, la si dice giunta dal Canada, paese dove non cresce alcuna specie di questo genere, segno delle vie anche contorte di trasmissione delle piante esotiche; anche questo capitolo è un ampio trattatello, con il confronto con altre specie e informazioni dettagliate sul pane di yucca messicano, che però non è ricavato da una Yucca, ma dalla cassava o manioca. Ancora americana la terza specie, maracot, ovvero la passiflora, una pianta altamente simbolica nei cui fiori i gesuiti vedevano i segni della passione di Cristo; Aldini si mostra scettico, scrivendo: "Io non ci vedo tanto significato mistico, se non a forza; in tutta la pianta non compare affatto la croce, che è il primo e principale segno della passione del salvatore". Invece si dilunga nella descrizione della pianta, dei fiori e dei frutti, "aciduli ma dal sapore gradevole". Giunta dalle Indie nel 1620 è laurus indica (Persea indica), in realtà originaria delle Canarie. L'autore, con grande sfoggio di erudizione, si preoccupa soprattutto di negare che vada identificata con la cannella. Da qui in avanti, i capitoli si fanno sempre più brevi, riducendosi spesso a un disegno e una pagina di testo. Non tutte le piante sono identificabili (non lo è, ad esempio, Narcissus calcedonicus, unica pianta non illustrata da un disegno): citiamo hololiuchi o convolvolo peruviano, in cui riconosciamo Rivea corymbosa; glans unguentaria, ovvero Moringa oleifera; Lilionarcisso rubeo indico, presumibilmente un Hippeastrum; il ricino americano ovvero Jatropha curcas; solis flos tuberosus, ovvero il topinambur Helianthus tuberosus; Agave americana, ormai quasi una vecchia presenza nei giardini europei, dove è attestata già nella prima metà del Cinquecento.  Un genere amazzonico per un esperto di piante americane Di Tobia Aldini sappiamo molto poco: non ne conosciamo né la data di nascita né quella di morte, ma soltanto che era nato a Cesena e che a partire dal 1617 il cardinale Odoardo Farnese, di cui era anche il medico personale, gli affidò la direzione degli Orti farnesiani. Dai documenti del tempo in cui è citato emerge che faceva parte dei circoli intellettuali e scientifici della Roma del primo Seicento, ed era molto stimato tanto come chimico, ovvero farmacista, quanto come semplicista, ovvero esperto di erbe medicinali. In particolare ci è rimasta una sua lettera a Faber, in quegli anni impegnato nell'edizione del Tesoro messicano, al quale potrebbe aver fornito informazioni sulle piante americane coltivate nel giardino. Nel 1621 contribuì con una lettera a Discorso della duratione delli medicamenti di Pietro Castelli, al quale inizialmente dovette essere legato da grande amicizia, che tuttavia venne meno dopo il 1626, quando, morto il cardinale, Aldini passò al servizio del cardinal Barberini come curatore del suo Museo di curiosità ed ebbe anche la direzione del giardino dei semplici vaticano, con grande dispiacere di Castelli, che aspirava a quel posto per sé. Fu probabilmente questa situazione a spingerlo a trasferirsi a Messina. Così si esprime in amara lettera a Cassiano dal Pozzo; "Roma non mi vole, e stima un Tobia per maggior semplicista, per maggior Chimico, per maggior Cosmografo, e per maggior filosofo e Medico che Dioscoride, Paracelso. Tolomeo, Aristotele e Galeno quali tutti al suo dire sono ignoranti". Dopo questa data non abbiamo altre notizie di Aldini. Nonostante una presenza un po' fantasmatica e la discussa paternità di Exactissima Descriptio, gli sono stati dedicati due generi Aldina, rispettivamente da Adanson e Endlicher, e due generi Aldinia da Scopoli e Rafinesque. L'unico valido è Aldina Endl., un piccolo genere di circa 17 specie di alberi della famiglia Fabaceae, nativi delle foreste umide di Guyana e Amazzonia settentrionale. Sono alti alberi, spesso muniti di contrafforti, con foglie composte pennate e infiorescenze terminali o ascellari, solitamente ricoperte di una peluria dorata o rugginosa. I fiori, a simmetria radiale, hanno 4-6 petali, da bianchi a giallastri, numerosi stami, e sono profumati. Il frutto è un legume drupoide, talvolta spugnoso, per favorire la dispersione fluttuando sulle acque. L'esuberante, a volte indomabile, Macleaya cordata appare il ritratto vegetale perfetto per il funzionario, entomologo, collezionista e naturalista dilettante Alexander Macleay, un uomo che non conosceva le mezze misure. Nei suoi anni inglesi accumulò una collezione di insetti che era considerata la più bella e vasta del paese, forse del mondo; quando si trasferì in Australia come segretario coloniale, divenne una figura di spicco nella vita amministrativa, culturale, mondana e politica del Nuovo Galles del Sud. Sempre all'insegna del gigantismo: la sua casa di Elizabeth Bay, ancora oggi considerata la più bella dimora del periodo coloniale, era circondata da un giardino di 22 ettari, ricco di piante rare venute da tutto il mondo. Purtroppo non esiste più, ma l'impronta di Macleay rimane nelle strade della città, dove fioriscono le jacaranda da lui introdotte, nell'Australian Museum e soprattutto nel Macleay Museum di Sydney.  Un burocrate della botanica Nel gennaio 1826, quando Alexander Macleay (1767-1848) sbarcò a Sidney, era alla soglia dei 60 anni; forse un po' tardi per iniziare una nuova vita, ma anche un'occasione da non perdere. In patria era stato in importante funzionario del Transport Board del Ministero della guerra; ma nel 1818, finite le guerre napoleoniche, il dipartimento era stato soppresso, ed egli era stato messo a riposo con una pensione di 750 sterline. Poco per un uomo dai gusti dispendiosi con un'enorme famiglia; così, quando lord Bathurst, che era stato il suo capo, gli propose il posto di segretario coloniale del Nuovo Galles del Sud, con uno stipendio di 2000 sterline e il mantenimento della pensione, dopo qualche esitazione accettò. Tra le diverse considerazioni, certo pensò anche che il Nuovo Galles del Sud era un terreno ideale per coltivare le sue passioni naturalistiche. Oltre che un abile burocrate, Macleay era infatti un naturalista dilettante, noto per la sua grande e raffinata collezione entomologica. Nato in Scozia in un'antica famiglia impoverita dalle guerre giacobite, era stato educato a una carriera commerciale e nel 1786 si era trasferito a Londra, dove avviò un commercio di vini. A un certo punto dovette entrare in contatto con l'ambiente scientifico e nel 1794 venne ammesso alla Linnean Society; il segretario Thomas Marsham e il reverendo William Kirby era due noti entomologhi e forse furono loro ad avviarlo alla raccolta e allo studio degli insetti. Nel 1795, forse grazie alla raccomandazione di Banks, venne assunto come primo capo dell'Ufficio dei prigionieri di guerra; in seguito, l'ufficio confluì nel Transport Board, e Macleay fece carriera, divenendo prima capo del dipartimento della corrispondenza ed infine segretario del Board, rendendosi utile a Banks per lo scambio di prigionieri francesi con scienziati britannici. A partire dal 1798, quando Marsham diede le dimissioni per diventare tesoriere, Macleay mise le sue capacità amministrative al servizio della Linnean Society, ricoprendo a titolo gratuito l'incarico di segretario fino alla vigilia della sua partenza per l'Australia. Manteneva la corrispondenza, curava l'edizione e la stampa delle Transactions, teneva informato il presidente James Edward Smith che viveva nel Surrey e raramente partecipava alle riunioni. Svolgeva tutti questi compiti con grande zelo ed efficienza, esattamente come i suoi doveri d'ufficio, dividendo le sue giornate tra il Ministero e la Linnean Society. Nella sua posizione di burocrate della scienza poté stringere molti contatti che gli permisero di arricchire rapidamente la sua collezione di insetti, cominciata con le escursioni entomologiche e gli scambi con gli amici; poi vennero gli esemplari ottenuti da una rete corrispondenti (come il pittore John William Lewin, che gli spedì insetti proprio dal Nuovo Galles del Sud) e gli acquisti alle aste. Tra il 1804 e il 1818, Macleay riuscì ad aggiudicarsi integralmente o in parte le collezioni entomologiche di Dru Drury, Edward Donovan, Thomas Marsham, John Francillon e del generale Thomas Davies, di grande rilevanza storica per la presenza di numerosi esemplari tipo. A questo punto la sua collezione era probabilmente la più ricca del paese; se ne servirono largamente Kirby e Spense per il loro An Introduction to Entomology, pubblicato nel 1815 con una dedica a Macleay. Si moltiplicarono anche i riconoscimenti scientifici: nel 1809 fu ammesso alla Royal Society, nel 1813 alla Reale accademia delle scienze svedese, nel 1818 all'Accademia delle Scienze di Torino. Gli insetti erano l'interesse preminente, ma non il solo: Macleay amava anche le piante e nella casa di campagna che aveva acquistato nel Surrey creò un giardino ricco di specie esotiche, che come segretario della Linnean Society a volte riusciva a procurarsi in anteprima: è il caso di uno dei primi esemplari di Wisteria sinensis, arrivato direttamente dalla Cina nel 1819. Tra le piante preferite le rose; quando partì per l'Australia, ne portò con sé 34 piedi, incluse tre noisette, all'epoca una novità. Collezionare insetti e possedere una elegante villa di campagna erano abitudini dispendiose per un funzionario ministeriale, sebbene di alto livello; anche di più era crescere uno stuolo di figli e figlie. Lui e la moglie Elisa Barclay ne ebbero diciassette; sette morirono prima di raggiungere l'età adulta; rimanevano quattro maschi, cui assicurare un'educazione universitaria in vista di carriere prestigiose, e sei ragazze cui trovare marito, come nel più classico romanzo di Jane Austin. Quando Macleay si trovò a disporre solo di una modesta pensione, arrivarono le difficoltà finanziarie, accresciute dal fallimento della banca privata del fratello di cui era azionista. Lasciare le amicizie e una posizione scientifica pazientemente coltivata per un quarto di secolo era doloroso, ma l'offerta troppo allettante. Così si risolse ad accettare e a partire per gli antipodi; che fosse una destinazione definitiva, lo dimostra il fatto che lo accompagnavano la moglie e le sei figlie (la maggiore, Frances Leonora detta Fanny, aveva 34 anni, la più piccola, Barbara, 12); nella stiva, la preziosa collezione di insetti (all'epoca, contava circa 9000 pezzo), la biblioteca e casse di piante. Uomo molto attivo, capace di lavorare anche 20 ore al giorno, di grandissima esperienza amministrativa, Macleay seppe rendersi indispensabile al governatore Darling. Dopo anni di incertezze finanziarie, ora godeva di un buon stipendio e ottenne anche vaste concessioni fondiarie, tra cui una di circa 22 acri a Elizabeth Bay, a circa due miglia ad est della città. La famiglia si stabilì nella casa assegnata al Segretario coloniale nei pressi dell'ufficio, ma fin dal 1827 Macleay cominciò a trasformare la proprietà di Elizabeth Bay in un giardino paesaggistico, sfruttando la splendida posizione affacciata sulla baia. Fece costruire un muro di sostegno, una strada d'accesso, delle stalle ingentilite da torrette e un cottage per il giardiniere. Affidò il progetto del giardino a Thomas Shepherd, il primo vivaista della colonia; era un seguace del giardino paesaggistico che propagandò nel suo Lectures of Landscape Gardening (1836), dedicato a Macleay "in segno di ammirazione per l'abilità consumata, la conoscenza e lo zelo nelle attività orticole". Mentre gli altri proprietari di giardini facevano tabula rasa della vegetazione spontanea per ricreare agli antipodi i giardini della madrepatria, Macleay chiese a Shepherd di preservarla; costituita da alberi di Eucalyptus tereticornis con il relativo sottobosco, divenne lo sfondo dove inserire sentieri sinuosi, laghetti, un ponte rustico, grotte, edifici romantici e piante esotiche fatte venire dall'Inghilterra, dall'India, dalla Cina e da altri angoli dell'Impero britannico. Così descrive il giardino Mrs Lowe, che lo visitò al momento del suo massimo splendore: "Il cammino che porta alla casa è tagliato attraverso rocce ricoperte dagli splendidi arbusti selvatici e dai fiori di questo paese, e qua e là c'è un immenso albero primordiale [...]. In questo giardino ci sono piante di ogni clima: fiori e alberi di Rio, delle Indie Occidentali, delle Indie Orientali, della Cina e persino dell'Inghilterra. I bulbi del Capo sono splendidi, e se non le avessi viste non potrei credere quanto belle siano le rose. Gli aranci, i limoni, gli altri citrus e i guaiavi sono immensi, i melograni sono in piena fioritura. Mr Macleay ha anche un'immensa collezione di piante della Nuova Zelanda". Non abbiamo cataloghi del giardino, ma le semine e i trapianti sono documentati da due quaderni, di mano in parte di Alexander Macleay in parte del figlio William Sharp: Plants Received at Elizabeth Bay, ca 1826-1840, e Seeds Received at Elizabeth Bay, 1836-1857, che elenca semi di 3806 varietà. Era un autentico orto botanico con rarità di ogni tipo; tra i fornitori, oltre a Shepherd, troviamo il famoso vivaio londinese Loddiges, specialista in piante esotiche; qualche pianta arrivò da scambi con altri appassionati, come William Macarthur di Camden. Il giardino doveva già essere completato nel gennaio 1836, quando Macleay vi diede una splendida festa in onore degli ufficiali delle HMS Beagle e Zebra, in viaggio alla volta del Pacifico; c'erano le famiglie più in vista della colonia, per un totale di 200 invitati; ma non c'era il naturalista del Beagle Charles Darwin, che aveva approfittato dello scalo per un'escursione naturalistica sulle Blue Mountains. La festa si svolse sul prato antistante la villa la cui costruzione era iniziata l'anno prima; Macleay ne aveva affidato la progettazione a John Verge, il più rinomato architetto della colonia, che disegnò un edificio a due piani in stile classico, particolarmente notevole per la sala centrale ovale sormontata da una lanterna.  Nobiltà e miseria di una casa e di un giardino Un giardino da favola, feste danzanti e una residenza alla moda, oltre a corrispondere al gusto del lusso che Macleay aveva già manifestato in Inghilterra, facevano parte della strategia per inserirsi nell'élite della società della colonia, costituita da emigrati che stavano facendo fortuna con l'allevamento delle pecore nelle terre ottenute in concessione dal governo (una speculazione a cui si dedicò egli stesso). Nonostante la sua figura di goffo arrivista fosse anche oggetto di caricatura, l'operazione riuscì abbastanza da assicurare ottimi matrimoni a cinque figlie su sei. Nel 1838 Macleay fu anche tra i fondatori dell'esclusivo Australian club. Ma c'erano circoli a cui teneva anche di più: quelli dei "gentiluomini naturalisti" di cui in Inghilterra aveva fatto parte nella posizione privilegiata di noto collezionista e segretario della Linnean Society, Tra i doveri d'ufficio del segretario coloniale, c'era la gestione dell'orto botanico. Era stato fondato nel 1816 dal governatore Macquaire, ma, anche se il primo sovrintendente Charles Fraser aveva incominciato a trapiantarvi le specie native raccolte durante le sue spedizioni, era ancora poco più di un orto in cui si coltivavano le verdure per la mensa del governatore. La riuscita del giardino di Elizabeth Bay, che aveva dimostrato le potenzialità di un terreno di per sé arido, sabbioso e poco fertile, sicuramente stimolò la coltivazione di fruttifere ed esotiche anche nell'orto botanico, cui Macleay donò numerose piante; tuttavia, il giardino non decollò fino alla fine degli anni '40, in seguito a una serie di vicende sfortunate tra cui la morte di Richard Cunningham e la rinuncia di suo fratello Allan. Macleay incontrò maggior successo nell'istituzione del Museo australiano. La creazione di un museo della colonia era stato il principale obiettivo della Philosophical Society of Australia, fondata nel 1821 da sette gentiluomini; erano stati raccolti o donati minerali, fossili, manufatti indigeni, custoditi proprio nell'ufficio del segretario coloniale, ma la società si era presto arenata. Macleay rilanciò il progetto e già nel 1827 convinse il governatore a stanziare 200 sterline per istituire il Museo coloniale, che nel 1830 fu trasferito in un capannone annesso all'ufficio dell'avvocatura, poi nel 1831 nell'edificio del Vecchio consiglio legislativo. Nel 1836 venne rinominato Australian Museum e, probabilmente su suggerimento di Macleay, posto sotto la giurisdizione del "Comitato di sovrintendenza del Museo Australiano e dell'Orto botanico", di cui facevano parte sia lui, nelle vesti di presidente, sia suo figlio William Sharp e diverse personalità della colonia che ne condividevano gli interessi scientifici, tra cui Phillip Parker King. Intanto Macleay continuava ad accumulare piante, insetti e altri oggetti naturali (i suoi interessi si erano estesi anche all'ornitologia e agli animali marini). Per quanto riguarda le piante, gli si attribuisce l'introduzione in Australia del glicine, che come abbiamo visto già coltivava in Inghilterra, e della jacaranda, oggi comunissima lungo i viali cittadini; nel 1836 è documentato l'arrivo di una Magnolia denudata. Tra gli apporti alla collezione entomologica merita segnalare diversi esemplari avuti da Raffles e le 192 diverse specie di insetti raccolte dal capitano King nel corso della ricognizione della costa australiana tra il 1818 e il 1822. Nel conferirgli l'incarico, l'ufficio coloniale aveva raccomandato a Macleay di non prendere iniziative personali e di non discostarsi dalle disposizioni del governatore; egli si era attenuto strettamente a questa direttiva, con il risultato che la crescente impopolarità di Darling ricadde anche su di lui; membro fin dal 1825 del Consiglio legislativo e del Consiglio esecutivo, per altro condivideva pienamente le scelte conservatrici del governatore, ostile a concedere pieni diritti politici agli ex-deportati. Anche Macleay fu oggetto di una violenta campagna di stampa che lo accusava di essersi fatto strumento del tirannico Darling per puro interesse personale; uno dei capi d'accusa più gravi era proprio la concessione della tenuta di Elizabeth Bay, che includeva una riserva aborigena sotto protezione governativa. A Londra arrivò la duplice richiesta di rimuovere tanto l'odiato governatore quanto il suo tirapiedi, ovvero il segretario coloniale. In effetti nel 1831 Darling, terminato il suo mandato, fu richiamato in Inghilterra ma la sua relazione sull'operato di Macleay fu così positiva che l'ufficio coloniale decise di mantenerlo al suo posto. Tuttavia le sue relazioni con il nuovo governatore Burke si fecero sempre più tese, finche nel 1835 quest'ultimo notificò all'Ufficio coloniale che era necessario nominare un nuovo segretario in vista dell'imminente pensionamento di Macleay, quasi settantenne. Il quale non era stato consultato in proposito e cercò di opporsi in tutti i modi, minacciando anche di adire le vie legali, finché all'inizio del 1837 fu costretto al ritiro. Come in Inghilterra vent'anni prima, si trovò di nuovo immerso nei debiti. Anche se con la sua strenua resistenza si era almeno garantito una buona pensione, la perdita del lauto stipendio diede il colpo di grazia a una situazione già problematica a causa dei debiti accumulati per costruire la casa o investiti in speculazioni avventate, proprio nel momento in cui il prezzo della lana crollava e il Nuovo Galles del Sud era investito da una grave crisi. Molti altri erano indebitati e Alexander Macleay cercò inutilmente di vendere una parte delle terre. A salvarlo dalla bancarotta fu il figlio maggiore William Sharpe Macleay (1792-1865), che era anche il maggiore dei suoi creditori; trasferitosi a Sydney nel 1839, nel 1844 si fece carico di parte dei debiti e provvide a saldarli vendendo la mobilia, la biblioteca, che contava circa 4000 volumi, diversi terreni. Per costringere il padre a un regime di stretta economia, lo convinse a trasferirsi con la moglie presso una delle sorelle sposate e si trasferì nella casa di Elizabeth Bay, dove visse fino alla morte. In queste tristi vicende, l'anziano Alexander era ancora impegnato in politica: nel 1843 fu eletto all'assemblea legislativa, di cui fu speaker fino al 1846. Morì nel 1848 in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Al funerale assistette una gran folla, a dimostrare che nonostante tutto era stato una personalità di primo piano nella vita della colonia. A ereditare la collezione entomologica fu William Sharp che la unì alla propria. Dopo essersi laureato a Cambridge, aveva intrapreso la carriera diplomatica, con primo incarico a Parigi, dove aveva frequentato tra gli altri Cuvier; quindi aveva approfittato di una missione a Cuba e di un viaggio negli Stati Uniti per incrementare la sua collezione di insetti, in parte raccolta di persona, in parte ottenuta attraverso scambi e acquisti. A differenza del padre, che non pubblicò nulla eccetto una monografia sul genere Passus, fu uno scienziato con ambizioni teoriche, creatore del sistema di classificazione quinario che godette di qualche successo tra i naturalisti britannici, un ambiente in cui era ben inserito (tra i suoi contatti, anche il giovane Darwin, che incoraggiò a pubblicare i risultati naturalistici del viaggio del Beagle). Continuò ad incrementare la collezione anche in Australia; al momento della sua morte nel 1865, unita a quella del padre, occupava 480 cassetti e contava tra 100.000 e 150.000 esemplari. William Sharp diede un grande contributo anche al giardino. Al suo arrivo nel 1839 portò con sé molti bulbi che si era procurato durante lo scalo a Città del Capo; altre 88 varietà gli furono invite l'anno dopo da Nathaniel Wallich, suo corrispondente e sovrintendente dell'orto botanico di Calcutta. Nel 1841 ricevette una visita speciale: quella di Joseph Dalton Hooker, figlio del direttore di Kew, di passaggio in Australia come naturalista dell'Erebus; Hooker fu entusiasta del giardino e lo descrisse come il paradiso dei botanici: "La mia sorpresa fu sconfinata per le bellezze naturali del luogo, il gusto inimitabile con cui i giardini erano disposti e il numero e la rarità delle piante che vi erano raccolte". Macleay gli restituì la visita sull'Erebus e passò un'intera giornata ad ammirare gli esemplari raccolti da Hooker nei mari antartici. Alla sua morte lasciò la collezione al cugino William John Macleay e la casa al fratello minore George (un altro personaggio sopra le righe, noto come esploratore, viaggiatore e bon vivant) che suddivise la proprietà in lotti, ne vendette gran parte e affittò la casa al cugino. William John Macleay (1820-1891) era arrivato in Australia insieme al cugino William Sharp che lo aveva iniziato all'entomologia. Anche lui era un appassionato collezionista; nel 1862 fondò e presiedette l'Entomological Society. Dopo aver ereditato la collezione di Alexander e William Sharp, decise di ampliarne la portata, trasformandola in una raccolta zoologica a 360°. Nel 1874 fu tra i soci fondatori e primo presidente della Linnean Society del Nuovo Galles del Sud. Finanziò diverse spedizioni; nel 1875 guidò quella del Chevert in Nuova Guinea, la prima spedizione scientifica australiana in un altro paese. Ormai le collezioni erano così grandi che dovette far costruire un nuovo edificio per ospitarle ed assumere un curatore nella persona di George Master. Nel 1889 ne fece dono all'Università di Sydney; nacque così il Macleay Museum, uno dei più importanti musei naturalistici dell'Australia. Alla morte di George la casa passò agli Onslow, discendenti di Rosa Roberta, una delle figlie di Alexander; nel Novecento fu semiabbandonata, ristrutturata, smembrata in appartamenti finché nel 1963 fu acquistata dal Consiglio della Contea. Restaurata e riportata allo splendore originale, oggi è un museo inserito dall'Unesco nella lista del patrimonio dell'umanità. Il giardino aveva cessato da tempo di esistere.  Macleaya, splendide e invadenti Robert Brown era stato ammesso alla Linnean Society nel novembre 1798, pochi mesi dopo l'elezione a segretario di Alexander Macleay. Dopo il suo ritorno dall'Australia, la società lo assunse come impiegato e bibliotecario; si trovò così a lavorare quasi quotidianamente con Macleay. Tra i due dovette svilupparsi una stretta amicizia. Nell'autunno nel 1814, Brown soffrì una brutta infreddatura e il suo capo lo invitò a trascorrere le vacanze natalizie con la sua famiglia nella villa del Surrey. Fu un momento molto piacevole per il botanico, trascorso in dotte conversazioni con il padrone di casa e con William Sharp, all'epoca studente a Cambridge, ma anche con la ventunenne Fanny, la più grande delle ragazze di casa. Come le sorelle, aveva ricevuto un'eccellente educazione scientifica, aiutava il padre a tenere in ordine le collezioni, era una brillante conversatrice (lo dimostrano le belle lettere che scrisse da Sydney al fratello quando questi si trovava all'Avana) e una dotatissima pittrice botanica. Per farla corta, Brown (che aveva il doppio dei suoi anni) credette di aver trovato l'anima gemella. Non sappiamo se si limitò a un corteggiamento, o ci fu una richiesta ufficiale; sappiamo invece che a opporsi fu la madre (in Australia aveva fama di essere una vera arpia), che sentenziò che Fanny si sarebbe sposata prima o poi, ma ora doveva aiutarla ad allevare i fratellini e le sorelline. Del resto, Brown come innamorato le pareva decisamente freddo (e con pochi soldi, aggiungo io). Così l'idillio finì, senza intaccare l'amicizia tra i Macleay e Brown. Anche quando Fanny viveva in Australia, lei e il vecchio innamorato continuarono a corrispondere, scambiando disegni ed esemplari, ma senza alcuna nota romantica. Fanny fu l'ultima delle sorelle Macleay a sposarsi addirittura nel 1836, ma morì sei settimane dopo il matrimonio. Quando il vedovo partì per Londra, Alexander Macleay (che forse era all'oscuro di tutto) ebbe la brillante idea di munirlo di una lettera di raccomandazione... proprio per Robert Brown. Al quale doveva, se non altro, la dedica del genere botanico Macleaya istituito da Brown nel 1826, poco dopo la partenza dell'amico per l'Australia, con queste parole: "Al mio molto stimato amico Alexander Macleay, Segretario della colonia del Nuovo Galles del Sud, i cui meriti come naturalista generale, profondo entomologo e botanico pratico sono ben noti". Brown separò il nuovo genere da Bocconia contro il parere di altri autorevoli botanici; la separazione, oggi confermata dalle analisi molecolari, ha prevalso solo nel 1920. Macleaya R.Br. è un piccolo genere della famiglia Papaveraceae cui appartengono due sole specie, M. cordata e M. microcarpa. La prima, originaria di Cina e Giappone, è abbastanza diffusa nei nostri giardini. E' una vigorosissima erbacea perenne capace di superare i due metri d'altezza, con grandi foglie lobate, molto decorative, tra grigio verdi e verde azzurro. I piccoli fiori sono riuniti in grandi pannocchie piumose bianco-camoscio. Dove trova le condizioni ideali, tende a formare molti polloni e può essere piuttosto invadente. M. microcarpa, endemica della Cina centro-orientale, è simile, ma con fiori più piccoli, rosati all'esterno e bronzei all'interno. Sono disponibili anche cultivar con fiori più rosati o rossastri, nonché un ibrido tra queste due specie, M. x kewensis, con pannocchie da camoscio-crema a rosate. |
Se cerchi una persona o una pianta, digita il nome nella casella di ricerca. E se ancora non ci sono, richiedili in Contatti.
CimbalariaAppassionata da sempre di piante e giardini, mi incuriosiscono gli strani nomi delle piante. Un numero non piccolo di nomi generici sono stati creati in onore dei personaggi più diversi. Vorrei condividere qui le loro storie e quelle delle piante cui sono legati. Archivi
April 2024
Categorie
All
|

 RSS Feed
RSS Feed